di Franco Ricciardiello
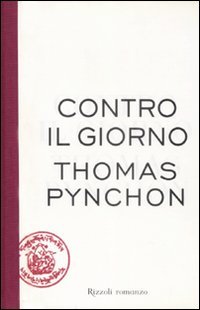 Thomas Pynchon, Contro il giorno, Rizzoli, 2009, pp. 1127, € 25,60
Thomas Pynchon, Contro il giorno, Rizzoli, 2009, pp. 1127, € 25,60
A 72 anni di età, e con solo sette romanzi alle spalle malgrado una precoce iniziazione alla scrittura, ancora ai tempi del liceo, Thomas Pynchon è oggi probabilmente l’unica icona indiscussa della letteratura postmoderna. Nessun altro autore è ugualmente lontano dalla più suggestiva definizione di “letteratura” come metafora della realtà. Il mondo di Pynchon infatti non è esattamente sovrapponibile a quello che conosciamo, anche se non è facile cogliere le differenze che si presentano come semplici smagliature, una sottile sensazione di straniamento. Questa impressione è accentuata dalla lettura del recente Contro il giorno, pubblicato da Rizzoli lo scorso giugno in una monumentale edizione — 1127 pagine di formato inusuale — sicuramente il più lungo dei lunghi romanzi di Pynchon.
Per la verità, negli Stati Uniti il 4 agosto 2009 è già uscito un romanzo più recente, Inherent Vice, drasticamente più breve del quale forse vedremo la traduzione in tempi accettabili. Il ritardo nella pubblicazione italiana di Contro il giorno potrebbe essere dovuto alla mole del materiale piuttosto che a difficoltà nella traduzione, considerato che la complessità di linguaggio non è neppure lontanamente paragonabile allo stile pirotecnico de L’arcobaleno della gravità (1973) o a quello ostico, fiorito di arcaismi di Mason & Dixon: qui si recupera piuttosto lo stile di Vineland (1990) e di quel mitico V. (1963) ormai lontano 45 anni, agli albori del postmoderno come categoria estetica.
Dunque, un altro tentativo di tracciare la mappa di un mondo attraverso topoi scelti con cura nel generoso immaginario pynchoniano; giusto qualche esempio: gli sviluppi della matematica teorica, le solite trame dei servizi segreti, l’età pionieristica nelle scoperte dell’elettricità e delle proprietà della luce, l’evento di Tunguska, il viaggio nel tempo, il mito delle città perdute. Dare un’idea di Contro il giorno equivale a tentare di tracciare una mappa della pletora di avvenimenti e argomenti che si snodano nel corso della narrazione; e siccome il romanzo è esso stesso una mappa, e che per giunta può a sua volta essere (forse) interpretato grazie a una mappa contenuta esplicitamente nel testo, forse possiamo farci un’idea del livello di complessità. Per chi fosse interessato a orizzontarsi in questo labirinto senza perdere neppure il minimo rimando, può tornare utile la guida che il sito in lingua inglese http://pynchonwiki.com/ fornisce per ogni romanzo di Thomas Pynchon, e che consiste in una quantità di spiegazioni sugli infiniti riferimenti culturali contenuti quasi in ogni pagina. A ogni modo, fornire un breve riassunto della trama è possibile.
Colorado, fine ‘800. L’anarchico Webb Traverse, organizzatore dei minatori in sciopero e terrorista dinamitardo, viene fatto assassinare dal magnate dell’industria Scarsdale Vibe. La storia segue le vicende dei quattro figli Traverse fino al primo dopoguerra. La figlia si innamora del sicario che ha ucciso Webb e condivide il suo destino di tirapiedi del padronato lungo il Far West di inizio secolo, fino alla Hollywood del cinema muto. L’ultimogenito accetta una borsa di studio di Scarsdale Vibe per studiare prima sulla East Coast e poi a Gottinga, la cui università è il centro nevralgico della matematica avanzata; ma quando prende coscienza del compromesso accettato fugge in Italia (Domodossola e Venezia, poi Torino) e rimane coinvolto nelle guerre balcaniche. I due primogeniti maschi si separano e si ritrovano più volte attraverso la un mondo e un continente sui quali grava l’imminenza, quasi l’urgenza della catastrofe mondiale: vedranno il Messico della rivoluzione, l’Europa inquieta e quasi ansiosa di sangue, i Balcani attraversati dalle trame dei servizi di intelligence (tema molto caro a Pynchon, in virtù delle sue potenzialità di “storia segreta”) e da quella prova di conflitto moderno, anticipazione della morte su larga scala, che è la guerra scatenata dai nascenti Stati slavi del sud contro la Repubblica ottomana dei Giovani Turchi. L’esilio dei Traverse si intreccia con il dovere di vendicare l’omicidio del padre: prima rivolgeranno la loro attenzione all’esecutore materiale, poi risaliranno al mandante Scarsdale Vibe, e il loro riscatto intersecherà il terrorismo anarchico, azione individuale e violenta per contrastare la violenza degli Stati industriali. Pynchon fotografa con cruda sincerità gli anni ruggenti del capitalismo, l’economia di mercato allo stato puro: un sistema economico che a cavallo di un secolo trasformò il mondo grazie alla scienza e alla tecnica, e che raggiunse l’apice del dominio con la Prima guerra mondiale. Questa fase onnipotente del capitalismo terminò con la rottura dell’alleanza tra religioni di Stato e gli Stati industriali, esattamente negli anni considerati da Pynchon; in seguito, il suo dominio sull’uomo e sul mondo fu contrastato dai Soviet, da Roosevelt e dal fascismo. Il periodo storico scelto permette di mettere in scena lo scontro tra proto-globalizzatori (Scarsdale Vibe) e proto-antiglobal (gli anarchici), la sanguinosa fine dell’età d’oro del capitalismo: la Storia non è finita, come scrisse Francis Fukuyama, con la caduta del muro di Berlino, bensì oltre mezzo secolo prima.
La vendetta contro il mandante dell’assassinio di Webb è il Leitmotiv del romanzo, ma come al solito in Pynchon si tratta di un pretesto per cucire insieme una quantità di episodi come punti sulla mappa di un territorio psichico. L’attendibilità storica degli avvenimenti è volutamente alterata; la quarta di copertina recita: “Thomas Pynchon non descrive il mondo com’è, ma come potrebbe essere con appena qualche ritocco”: per esempio il crollo del campanile di San Marco a Venezia a causa di un siluro aereo, durante una battaglia molto weird SF tra aeronavi (!) russe e americane. Benché non si arrivi mai all’ucronia vera e propria, la narrazione è inquinata da slittamenti verso una realtà “altra”, non una Storia alternativa bensì il dubbio di sottili differenze. Non è un mistero che Pynchon sia più interessato al dettaglio che al quadro generale: la sua narrativa procede per metonimie incastrate una sull’altra come il percorso di un labirinto. Malgrado ciò, lo stile di scrittura rimane semplice: siamo molto lontani dai lunghi, straordinari anacoluti de L’arcobaleno della gravità che costruivano non solo un percorso di scrittura, ma un vero e proprio procedimento linguistico di stupefacente bellezza.
Il punto di vista del “narratore onnisciente”, che ha reso assolutamente pirotecnica la scrittura di Thomas Pynchon, rimane in un angolo. La metafora, figura retorica per antonomasia del linguaggio figurato, è poco interessante per il nostro autore: il suo stile è quanto di più distante si possa immaginare dalla poesia. Il suo campo di battaglia è piuttosto la sineddoche: rappresentare il particolare per significare il generale. Non esiste forse stile letterario più lontano da una scrittura cinematografica: è completamente assente qualsiasi elemento spettacolare, anzi l’autore tende a spezzare ogni situazione potenzialmente scenografica. Perfino il più noto prodotto del montaggio, quel flashback che tanta fortuna ha conquistato nella scrittura moderna, è usato con parsimonia. Contro il giorno segue una narrazione sequenziale, quasi cronologica: ciò che interessa l’autore è la digressione spaziale, non quella temporale. Pynchon procede per successivi, impercettibili slittamenti costruiti uno dentro l’altro, come un’estensione dell’anacoluto dalla dimensione grammaticale a quella narrativa: è evidente che si tratta di un procedimento più affine alla metonimia che alla metafora.
Non si può negare l’intenzione di Pynchon di dare rilievo ai dettagli e attutire la visione d’insieme. La migliore chiave di lettura di Contro il giorno è infatti l’itinerario sfinciuno, una carta dell’Asia centrale stilata da esuli veneziani emigrati sulle orme di Marco Polo, che dovrebbe mostrare anche la via per la mitica Shambhala, città perduta del buddismo tibetano. Per questo servizi di intelligence e organizzazioni più o meno segrete sono sulle sue tracce. La particolarità dell’itinerario sfinciuno è che le indicazioni e i simboli contenuti sulla carta diventano leggibili solo se osservati tramite una lente particolare, prodotta dagli artigiani dell’Isola degli Specchi a Venezia. È una deviazione meccanica dunque, uno slittamento della luce a produrre significato: in fin dei conti, un’altra metonimia. Intorno al tema della luce e della sua deviazione si sviluppa una serie di interessanti digressioni: c’è un minerale, lo Spato d’Islanda, che riappare periodicamente nella trama, quasi sempre a giustificare un lieve scostamento dalla realtà: per esempio, esperimenti di prestidigitazione che causano la duplicazione di esseri umani.
Nonostante la serietà della materia, Pynchon trova comunque il gusto di dissacrare tutto; esemplare è l’aneddoto della copertina, quel sigillo rosso che rappresenta una stilizzazione di vette montuose, nuvole e tetti a pagoda dall’apparenza molto vintage. Leggiamo nell’edizione italiana che “L’editore si dichiara pienamente disponibile ad adempiere i propri doveri per l’immagine di copertina di cui, nonostante le ricerche eseguite, non è stato possibile rintracciare gli aventi diritto”. Un fan americano (dal sito pynchonwiki.com) sostiene di aver mostrato il simbolo a un centro culturale tibetano, e questa sarebbe la risposta del traduttore Tenzin Namgyal: la traduzione della scritta misteriosa intorno al timbro è “Camera di commercio del governo del Tibet”. Nulla rende meglio l’idea di quanto Thomas Pynchon sia ancora un enfant terrible di settant’anni.



