di Alberto Prunetti
Beppe De Sario, Resistenze innaturali, Milano, Agenzia X, 2009, pp. 254, 16 euro
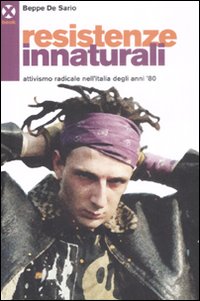 Resistenze innaturali di Beppe de Sario è un libro importante, denso, ben scritto, che passa in rassegna la storia di tre scene antagoniste italiane degli anni Ottanta. Tre città, tre scenari di resistenza urbana: Roma, Milano e Torino. Più in particolare, tre diversi luoghi di movimento: il forte Prenestino a Roma, il Cox 18 a Milano e El Paso a Torino. Gli anni sono gli Ottanta, ma per essere precisi la ricerca scivola abbondantemente nei primi anni Novanta, quando i centri sociali fanno irruzione nel discorso pubblico e nella scena politica italiana.
Resistenze innaturali di Beppe de Sario è un libro importante, denso, ben scritto, che passa in rassegna la storia di tre scene antagoniste italiane degli anni Ottanta. Tre città, tre scenari di resistenza urbana: Roma, Milano e Torino. Più in particolare, tre diversi luoghi di movimento: il forte Prenestino a Roma, il Cox 18 a Milano e El Paso a Torino. Gli anni sono gli Ottanta, ma per essere precisi la ricerca scivola abbondantemente nei primi anni Novanta, quando i centri sociali fanno irruzione nel discorso pubblico e nella scena politica italiana.
Attraverso le testimonianze orali di alcuni protagonisti di quelle esperienze, assieme alla capacità di ricostruire nel dettaglio le tensioni politiche e le contraddizioni di quegli anni, l’autore riesce a connettere la trama di queste esperienze: i rapporti non sempre facili coi militanti degli anni Settanta, sia comunisti che anarchici; il ruolo fondante della musica, dal ribellismo irruente del punk ’77 fino alla politicizzazione dell’anarcopunk e dell’hardcore e del rap. E poi le varie facce delle occupazioni: i centri sociali, le sale prove in comodato d’uso, le autogestioni, gli squat, le case occupate. I luoghi più aperti verso una politica rivolta alle necessità del quartiere e i laboratori dell’utopia, le “zone temporaneamente autonome” dove i pirati si ritirano per lanciare il prossimo assalto contro la città. Un miriade di differenze che sarebbe impossibile riassumere in una recensione.
Avrei potuto recensire “Resistenze innaturali” segnalando gli strumenti critici (notevoli e affinati, ispirati ai subaltern-studies d’aria anglofona) con cui De Sario ha condotto la sua indagine. Avrei potuto riassumere le tesi di fondo del volume, indicando gli strumenti della ricerca, la metodologia, i risultati raggiunti.
E invece no. Il libro racconta una storia che è stata costruita da tante persone e in parte è anche la mia storia, e la lettura ha sollevato in chi scrive una nebulosa di riflessioni. Se una recensione in certo modo partecipa del senso complessivo di un’opera, queste mie righe, per quanto periferiche all’opera e lontane dall’intenzionalità dell’autore, si inscrivono nella memoria di quegli anni. Cercherò quindi di riflettere brevemente sulla mia esperienza.
Sono cresciuto in provincia, in una zona dell’Italia piuttosto distante dai centri di diffusione delle pratiche di occupazione. La capacità d’irradiazione dei centri sociali si estendeva però anche al di fuori delle zone metropolitane, attraverso una rete estremamente funzionale di contatti postali collegati al giro delle autoproduzioni. Anche se il gruppo delle persone che frequentavo ai tempi del liceo (siamo negli anni a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta) non arrivò mai a occupare, ricevevamo e facevamo circolare un’ampia messe di pubblicazioni. Perlopiù fanzine musicali connesse al punk e all’hardcore, tantissima musica quindi (cassette e vinili), e poi i libri delle edizioni libertarie. Ci arrivavano il punk e le edizioni underground da Torino, da Milano i fumetti del prof. Bad Trip, il cyberpunk e l’America delle pantere nere, da Roma il rap. Quando i centri sociali cominciarono a essere una realtà influente, capace di estendere il suo bacino di influenza, le istituzioni giocarono la carta della legalizzazione, che doveva portare a una forte divisione tra le varie realtà autogestite. Noi ci schierammo col gruppo di centri sociali contrari alla legalizzazione.
La musica è stata importante. Sono arrivato ai centri sociali attraverso la musica. Ero rimasto fulminato negli anni del liceo dai Sex Pistols, che mi rivelarono un mondo di ribellione nichilista e mi staccarono dalla lettura della teologia della liberazione sudamericana. La rivolta degli anticristi, per un ateo che leggeva le poesie di Cardenal e agli scritti di Leonardo Boff, si spostò presto sulla sponda dei Crass, un gruppo di punk anarchico con una capacità di critica sociale piuttosto radicale e costruttiva. L’hardcore che mi convinceva di più era quello straight edge, tipo Minor Threat e Fugazi (anche se mi spallava il loro moralismo) ma finii ben presto per ritrovarmi a pogare sotto il palco dei Negu Goriak, la nuova formazione dei Kortatu, dei baschi che mescolavano rap e punk con uno spirito politico piuttosto esplicito. Intanto erano cominciati i miei pellegrinaggi nelle città italiana. Le manifestazioni della Pantera a Roma, la visita per la festa del non lavoro al Forte Prenestino di Roma, dove mi ritrovai a dormire in un umido sotterraneo. E poi i concerti al vecchio CPA di Firenze e alla Giungla di Firenze, quando finii a pogare davanti ai Sick of It All (se la memoria non mi inganna). Milano è una città che mi ha sempre stressato (forse perché l’ho conosciuta perlopiù attraverso le pagine amare di Bianciardi) ma nelle sole due volte che ci sono andato non sono riuscito a uscire dal quartiere ticinese. C’era davvero un’aria di paese in quelle strade, un’atmosfera che tranquillizzava un provinciale come me. E non ci voleva molto per passare dal rifugio dei punkabbestia (dove dormivo al ghiaccio) ai locali più confortevoli del Conchetta, che ospitava la splendida libreria di Primo Moroni.
Di Torino invece mi innamorai. El Paso mi colpì in modo quasi romantico: ricordo la bandiera nera dei pirati che sventolava sul vecchio asilo occupato, un cortiletto pieno di autocostruzioni, una libreria fantastica e punk ovunque, alcuni molto truzzi. Torino non è lontana dalla Francia e oltre a una serie di concerti di gruppi francesi da sballo (grandissimi i Les Sheriff) dal Paso arrivavano le idee e le pratiche situazioniste, via Marsiglia e Parigi. Un giro notevolissimo. L’azione diretta si mescolava con la provocazione dadaista (ricordo la madonnina in piazza che piangeva vino e il tipo vestito da cameriere che consegnò al sindaco un pesce in consiglio comunale subito dopo lo sgombero di una occupazione dicendo “il signore ha ordinato uno sgombro”,). Rimbaud, Cravan e Benjamin Péret si scoprivano punk, e la provocazione era all’ordine del giorno. Erano anni in cui le occupazioni a Torino si estendevano e c’erano altre realtà da visitare, come lo splendido Barocchio, una chiesa sconsacrata dove la gente faceva autocostruzione sul serio e il bar era migliore di tanti club. Una realtà che si scontrò ovviamente con le istituzioni e la repressione giudiziaria, di cui il segno più amaro rimane la morte di Baleno e Soledad, ricostruita egregiamente da Tobia Imperato ne Le scarpe degli assassini.
Poche memorie che non riassumono l’effervescenza di quegli anni, né tantomeno la grande capacità di mobilitazione di squat e centri sociali, che rimangono probabilmente in Italia i migliori laboratori di antagonismo sociale. Ci sarebbe molto da dire. La rete dei non sottomessi alla leva, i giri vegetariani, i collettivi editoriali. Una recensione non basta. Chi si è mosso nelle realtà di quegli anni, nella diversità a volte anche marcata delle pratiche e degli orientamenti ideologici, troverà il libro di De Sario bellissimo e stimolante. E sentirà il bisogno di continuare a raccontare quella storia.



