di Giuseppe Cassieri
 Scienza millenaria, nobilmente seduttiva tra pensiero filosofico e agganci teologici, tra fisica e metafisica, la cosmologia vanta negli ultimi decenni un picco portentoso di attrazione anche in virtù delle incalzanti meraviglie tecnologiche. Con un non trascurabile scarto culturale, tuttavia; e cioè che i candidi amatori di fenomeni celesti, così come coloro che avanzano domande di maggior peso circa l’origine e i misteri dell’universo, si immergano in sinossi amabilmente semplificate e colorate o in proiezioni avveniristiche dedotte da volatili ipotesi di laboratorio. Consigliabile, perciò, una scelta in bianco e nero che ci aiuti a capire, grazie a un ragionevole linguaggio tecnico, sia i lavori in corso, i fallimenti e gli esiti felici della ricerca, sia gli orizzonti concettualmente possibili ma non ancora (o forse mai) subordinati al potere investigativo dell’uomo.
Scienza millenaria, nobilmente seduttiva tra pensiero filosofico e agganci teologici, tra fisica e metafisica, la cosmologia vanta negli ultimi decenni un picco portentoso di attrazione anche in virtù delle incalzanti meraviglie tecnologiche. Con un non trascurabile scarto culturale, tuttavia; e cioè che i candidi amatori di fenomeni celesti, così come coloro che avanzano domande di maggior peso circa l’origine e i misteri dell’universo, si immergano in sinossi amabilmente semplificate e colorate o in proiezioni avveniristiche dedotte da volatili ipotesi di laboratorio. Consigliabile, perciò, una scelta in bianco e nero che ci aiuti a capire, grazie a un ragionevole linguaggio tecnico, sia i lavori in corso, i fallimenti e gli esiti felici della ricerca, sia gli orizzonti concettualmente possibili ma non ancora (o forse mai) subordinati al potere investigativo dell’uomo.
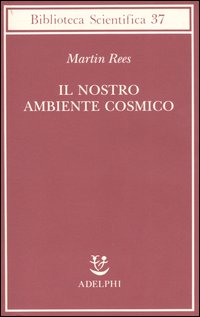 Una guida in tal senso la vedo al n. 37 della Biblioteca Scientifica Adelphi e segnalo:
Una guida in tal senso la vedo al n. 37 della Biblioteca Scientifica Adelphi e segnalo: ![]() “Il nostro ambiente cosmico” dell’autorevole Martin Rees, professore all’Università di Cambridge e Astronomo Reale d’Inghilterra. Il libro è frutto di una serie di conferenze tenute a Princeton, luogo consacrato dei cosmologi che mette in fibrillazione l’illustre ospite e lo induce a confessare di essere stato ben temerario ad accogliere l’invito avendo di fronte «persone più competenti di me»; ma poi, con anglico humour, si giustifica e dichiara il suo specifico intento: «descrivere una certa attività di frontiera oggi molto vivace, mettendo in evidenza alcune idee nuove e rendendole accessibili al grande pubblico». E dunque, il meglio che si possa ottenere nella comunicazione: lo scienziato in veste di divulgatore.
“Il nostro ambiente cosmico” dell’autorevole Martin Rees, professore all’Università di Cambridge e Astronomo Reale d’Inghilterra. Il libro è frutto di una serie di conferenze tenute a Princeton, luogo consacrato dei cosmologi che mette in fibrillazione l’illustre ospite e lo induce a confessare di essere stato ben temerario ad accogliere l’invito avendo di fronte «persone più competenti di me»; ma poi, con anglico humour, si giustifica e dichiara il suo specifico intento: «descrivere una certa attività di frontiera oggi molto vivace, mettendo in evidenza alcune idee nuove e rendendole accessibili al grande pubblico». E dunque, il meglio che si possa ottenere nella comunicazione: lo scienziato in veste di divulgatore.
Martin Rees muove dall’interrogativo retorico di Einstein: «Dio avrebbe potuto creare il mondo in modo diverso?» (e argomenterà con maliziosa leggerezza il suo «sì che poteva»), ritesse la parabola del Big Bang, si sofferma sulla singolarità dell’habitat che ci riguarda, e rende omaggio alle geniali intuizioni di Giordano Bruno che cinque secoli addietro configurava infiniti mondi, infiniti spazi, e forniva precoce sostegno a una rivoluzionaria teoria di fine Novecento, il «multiverso», in cui ciò che per tradizione definivamo unico, assoluto, assume valore «locale», guadagnandosi comunque un magnifico titolo: «oasi di fertilità». Giordano Bruno è altresì fervido sostenitore di mondi, oltre che multipli, «abitati», e Martin Rees raccorda quella fantasiosa preveggenza cinquecentesca alle aspettative odierne, senza eludere la nota obiezione di Enrico Fermi: «Come mai gli extraterrestri, qui, non si vedono?».
Problematico, talora agnostico, e sempre pronto a misurarsi con germi speculativi non immediatamente percettibili, l’autore spiega: 1) l’assenza di prove non è prova di assenza; 2) può darsi che Soli lontanissimi splendano su mondi altrettanto intricati e complessi del nostro, ma ognuno avrebbe un suo percorso evolutivo; 3) è più facile che due scimmie, battendo a casaccio su una tastiera, arrivino a comporre la stessa commedia di Shakespeare, che due ecosistemi siano la replica esatta l’uno dell’altro. Aggiunge però: se il «multiverso» fosse infinito, qualunque cosa, anche la più improbabile, potrebbe verificarsi, compresa l’apparizione degli extraterrestri. Asserto che riaccende l’entusiasmo di quanti, al risveglio, vorrebbero incontrare un E.T. battente bandiera marziana.
Se però così non fosse, se la ricerca di ignoti confratelli risultasse fallimentare, l’essere umano avrebbe almeno tre motivi per confortarsi: solitudine eroica e privilegiata; più alta opinione di sé; orgoglio e responsabilità nel gestire l’ambiente di stretta appartenenza. Particolarmente efficaci e comprensibili ai non addetti, le pagine che trattano i buchi neri, il dialogo interstellare, il collasso totale e, al vertice delle aspirazioni, la teoria unitaria di tutte le forze che governano universi e microcosmo. In attesa di questo evento («il massimo trionfo intellettuale di ogni tempo»), l’autore lancia un appello che immagino abbia ricevuto calorosi applausi nelle aule di Princeton: «Aver caro il confortevole pianeta» in cui (per caso?) ci troviamo insediati. «Aver caro il nostro tenue puntino azzurro sperduto nell’immensità del cosmo e non compromettere (ulteriormente) il futuro della vita».



