di Girolamo De Michele
Tommaso De Lorenzis, Valerio Guizzardi, Massimiliano Mita: Avete pagato caro non avete pagato tutto. La rivista «Rosso» (1973-1979), 109 pp.+DVD con la raccolta completa della rivista, DeriveApprodi, Roma, 2008, € 18.00 [qui un estratto del libro].

«Pat Garret e Billy Kid erano due che facevano una loro battaglia contro i proprietari fondiari. Ma Pat Garret era un legalitario: non gli piaceva che Billy ammazzasse i nemici anche alla festa di nozze quando lui aveva deciso per la tregua con l’esercito, la polizia, i proprietari. Pat fa la scelta e diventa sceriffo. A malincuore. Di fatto diventa alleato dei proprietari, non senza cercare, ogni tanto, di lasciare perdere Kid e di mantenere una buona fama tra i suoi vecchi compagni. Ma, in fin dei conti, Pat spara contro Kid. La storia finisce lì. Qualcuno immagina che il Kid sia stato solo ferito e come ogni eroe degli oppressi, rinasca dopo ogni ferita e alla fine trionfi su Garret. Il “compromesso storico”, la questione sindacale della battaglia delle vertenze, Enrico B. e Luciano L. sono fratelli gemelli di questo vecchio Garret. Era l’autunno 1973».
 Cominciava così l’articolo Pat Garret e Billy Kid ovvero i consigli del sindacato e l’autonomia operaia sul numero 10, maggio 1974, di Rosso, all’indomani della chiusura della vertenza dell’Alfa Romeo. Un numero che, non per caso, ammoniva in prima pagina: «Una crisi è vera crisi se è crisi del padrone». Si noti: “padrone”, non “lavoratore che intraprende”. Non è un mero slittamento semantico: nomina sunt consequentia rerum. Bastano questi pochi elementi a dare l’idea di cos’è stata la rivista Rosso: non, come ultimamente è capitato di nuovo di dover sentire (in spregio persino alle verità giudiziarie) “la struttura illegale di Autonomia Operaia”, ma un potente laboratorio dell’antagonismo sociale degli anni Settanta. Di questa rivista l’editore DeriveApprodi ci restituisce oggi tutta la forza, e tutte le contraddizioni, in un DVD che ne riproduce l’intera vita, dal marzo 1973 al maggio 1979, un mese dopo quel 7 aprile che inaugurò con un colpo di mano giudiziario un’epoca in cui, come ricordano Chicco Funaro e Paolo Pozzi, «l’eresia dev’essere eliminata» e nessun compagno «avrà più tempo o modo di occuparsi di una rivista». Accanto al DVD, un densissimo saggio di Tommaso De Lorenzis, Valerio Guizzardi, Massimiliano Mita:
Cominciava così l’articolo Pat Garret e Billy Kid ovvero i consigli del sindacato e l’autonomia operaia sul numero 10, maggio 1974, di Rosso, all’indomani della chiusura della vertenza dell’Alfa Romeo. Un numero che, non per caso, ammoniva in prima pagina: «Una crisi è vera crisi se è crisi del padrone». Si noti: “padrone”, non “lavoratore che intraprende”. Non è un mero slittamento semantico: nomina sunt consequentia rerum. Bastano questi pochi elementi a dare l’idea di cos’è stata la rivista Rosso: non, come ultimamente è capitato di nuovo di dover sentire (in spregio persino alle verità giudiziarie) “la struttura illegale di Autonomia Operaia”, ma un potente laboratorio dell’antagonismo sociale degli anni Settanta. Di questa rivista l’editore DeriveApprodi ci restituisce oggi tutta la forza, e tutte le contraddizioni, in un DVD che ne riproduce l’intera vita, dal marzo 1973 al maggio 1979, un mese dopo quel 7 aprile che inaugurò con un colpo di mano giudiziario un’epoca in cui, come ricordano Chicco Funaro e Paolo Pozzi, «l’eresia dev’essere eliminata» e nessun compagno «avrà più tempo o modo di occuparsi di una rivista». Accanto al DVD, un densissimo saggio di Tommaso De Lorenzis, Valerio Guizzardi, Massimiliano Mita: ![]() Avete pagato caro non avete pagato tutto. La rivista «Rosso», arricchito dai contributi di Funaro e Pozzi e da uno stralcio dell’intervista sull’operaismo di Toni Negri del 1979.
Avete pagato caro non avete pagato tutto. La rivista «Rosso», arricchito dai contributi di Funaro e Pozzi e da uno stralcio dell’intervista sull’operaismo di Toni Negri del 1979.
Un’operazione editoriale importante per almeno tre ragioni: innanzitutto, per la riproduzione di materiale storico altrimenti destinato all’oblio e alla mistificazione, e che invece ridiventa disponibile e fruibile, quantomeno in termini documentari, in un periodo caratterizzato da rievocazioni (non sempre ma) spesso sterili e ipocrite: si pensi ai democristiani che ieri si adoperavano attivamente per ottenere la morte di Aldo Moro, ed oggi tuonano contro la presenza, peraltro inesistente, degli “assassini di Moro” sui media.
In secondo luogo, per la serietà della curatela dei tre autori del saggio, provenienti dall’esperienza di Banlieues e Frame, due tra le più interessanti riviste di movimento degli ultimi anni, che hanno saputo coniugare il puntiglio storiografico con una forma espressiva accattivante, improntata a un taglio narrativo che mescola parafrasi politica e citazioni letterarie colte e raffinate, ottenendo talvolta lo spiazzante effetto di passare la prosa negriana al filtro dell’editing di un Ellroy o un Izzo. Una precisa scelta stilistica: l’estetica è una forma dell’etica, non il riposo del guerriero.
 Infine — ed è l’aspetto di maggior rilievo — per il taglio ermeneutico dei tre curatori. Che non si nascondono dietro l’acribia ricostruttiva che espone senza interpretare (la sostituzione dell’esposizione all’interpretazione è un’operazione ermeneutica eminentemente politica, come sa chi ha frequentato l’incompiuto libro di Benjamin su Parigi), né cede all’ennesima riedizione dello stucchevole derby Roma-Milano (o Roma-Padova) sulle responsabilità della sconfitta dei movimenti degli anni Settanta. Le questioni poste, attraversate, non risolte dall’esperienza di Rosso — la questione della violenza, il «maledetto problema del politico», il rapporto tra il multiforme proliferare delle pratiche e la riduzione ad unità del comando capitalistico (e della direzione politica leninista?) — sono ancora qui, sul terreno dell’esistente. Si parla dei “ruggenti Settanta” per parlare del terzo millennio: «è bene rimarcare come proprio l’annosa questione del potere e delle forme politiche sia tornata d’attualità nel momento in cui la Storia ha ripreso la sua irrefrenabile corsa verso la barbarie, la guerra ha saturato la profondità dell’orizzonte […]. È cominciato il tempo della catastrofe planetaria, quotidiana, generalizzata. Ed è persino possibile che, in quest’epoca, non basti neppure una nuova, creativa manifestazione della potenza moltitudinaria. Di sicuro, è inutile eludere il problema. Farlo non è servito. Il Novecento è tornato, una volta di troppo, a bussare a tutte le porte. E non ne ha risparmiata nessuna» (pp. 37-38).
Infine — ed è l’aspetto di maggior rilievo — per il taglio ermeneutico dei tre curatori. Che non si nascondono dietro l’acribia ricostruttiva che espone senza interpretare (la sostituzione dell’esposizione all’interpretazione è un’operazione ermeneutica eminentemente politica, come sa chi ha frequentato l’incompiuto libro di Benjamin su Parigi), né cede all’ennesima riedizione dello stucchevole derby Roma-Milano (o Roma-Padova) sulle responsabilità della sconfitta dei movimenti degli anni Settanta. Le questioni poste, attraversate, non risolte dall’esperienza di Rosso — la questione della violenza, il «maledetto problema del politico», il rapporto tra il multiforme proliferare delle pratiche e la riduzione ad unità del comando capitalistico (e della direzione politica leninista?) — sono ancora qui, sul terreno dell’esistente. Si parla dei “ruggenti Settanta” per parlare del terzo millennio: «è bene rimarcare come proprio l’annosa questione del potere e delle forme politiche sia tornata d’attualità nel momento in cui la Storia ha ripreso la sua irrefrenabile corsa verso la barbarie, la guerra ha saturato la profondità dell’orizzonte […]. È cominciato il tempo della catastrofe planetaria, quotidiana, generalizzata. Ed è persino possibile che, in quest’epoca, non basti neppure una nuova, creativa manifestazione della potenza moltitudinaria. Di sicuro, è inutile eludere il problema. Farlo non è servito. Il Novecento è tornato, una volta di troppo, a bussare a tutte le porte. E non ne ha risparmiata nessuna» (pp. 37-38).
La storia racconta di Rossocome di una rivista nata dall’incontro tra il Gruppo Gramsci, un polo attrattivo lombardo capace di tenere insieme militanti operai e intellettuali di spessore come Romano Madera e Giovanni Arrighi, e il versante milanese di quella parte di Potere Operaio che si riconosceva nelle teorizzazioni di Negri. Una rivista che prende ben presto il sottotitolo di Giornale dentro il movimento, e che dentro il movimento, nel suo periodo più alto (dal ’73 al ’76) sa confrontarsi con quella componente underground del movimento che ha come riferimento l’esperienza di Re Nudo. Se torniamo a quel pezzo del ’74 su Berlinguer e Pat Garret, vi troviamo le due simultanee pinze dell’astice sovversivo che attanaglia il reale: il soggetto dell’antagonismo, e il linguaggio espressivo che lo nomina. «Non più la tradizionale declinazione dell’“inchiesta operaia” e della “conricerca”, bensì una narrazione frattale, sincopata, “sporca”, dei nuovi metodi di vivere e di confliggere. Negri parla d’una “documentazione pratica”, in cui la “registrazione fenomenologica del fatto” si traduce immediatamente in “potenzialità di linea politica, in tendenza, in identificazione di soggetto”».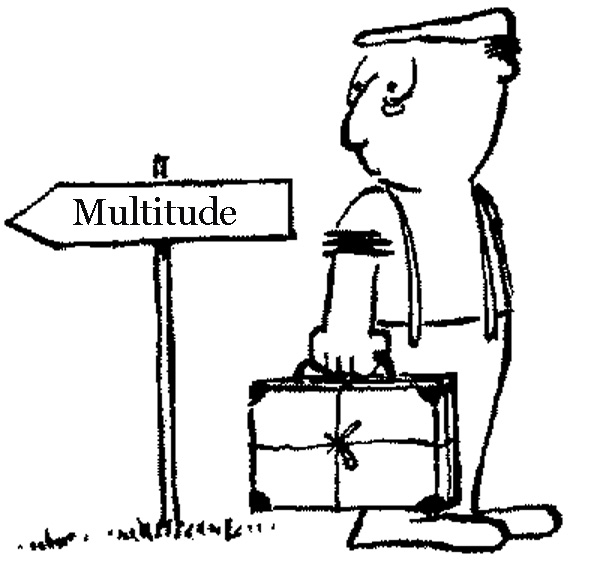 Lo sforzo è quello di misurarsi col declino dell’operaio-massa e con il nuovo soggetto che va delineandosi nelle lotte: «oltre la catena, al di là dei muri della fabbrica, lungo le dorsali d’una produzione che s’innerva sul territorio, sguscia nel terziario e sussume la società» (pp. 17-18). L’operaio di cui parlano le pagine di Rossonon discende dall’alto della tradizione teorica tardo-ottocentesca che vuole il lavoro essere il luogo dell’eticità dispiegata, dal cui fango si raccattane le bandiere dei Valori e del Progresso che la borghesia ha lasciato cadere: l’operaio di cui qui si narra è carne e sangue, «meno rude ma più irriverentemente pagano» (p. 15). Con i suoi comportamenti: rifiuto del lavoro, sabotaggio, boicottaggio della catena e del ciclo produttivo. Un operaio che non ama, ma odia il proprio luogo di lavoro; che odia il sistema che lo ridefinisce in quanto produttore di merce e valore di scambio; che odia la propria stessa condizione.
Lo sforzo è quello di misurarsi col declino dell’operaio-massa e con il nuovo soggetto che va delineandosi nelle lotte: «oltre la catena, al di là dei muri della fabbrica, lungo le dorsali d’una produzione che s’innerva sul territorio, sguscia nel terziario e sussume la società» (pp. 17-18). L’operaio di cui parlano le pagine di Rossonon discende dall’alto della tradizione teorica tardo-ottocentesca che vuole il lavoro essere il luogo dell’eticità dispiegata, dal cui fango si raccattane le bandiere dei Valori e del Progresso che la borghesia ha lasciato cadere: l’operaio di cui qui si narra è carne e sangue, «meno rude ma più irriverentemente pagano» (p. 15). Con i suoi comportamenti: rifiuto del lavoro, sabotaggio, boicottaggio della catena e del ciclo produttivo. Un operaio che non ama, ma odia il proprio luogo di lavoro; che odia il sistema che lo ridefinisce in quanto produttore di merce e valore di scambio; che odia la propria stessa condizione.
La violenza dei comportamenti antagonisti, al di là della dialettica repressione-reazione nelle strade e nelle piazze, esprimeva questo irriducibile dato, che solo delle menti povere di comprensione potevano ricondurre alle devianti pedagogie di cattivi maestri.  La rimozione di questo dato, congiunta alla cattiva infinità di una nostalgica e mitologica rievocazione dell’età dell’oro della classe operaia, ha reso quantomeno ambiguo il dibattito che sull’uso della violenza, contribuendo a perpetuare quell’equivoco che vuole, nella comune opinione, equiparati lo sciopero selvaggio e la banda armata, l’illegalità di massa e la pratica terroristica. Un’ambiguità che si fa costitutiva dell’incapacità di leggere — e contrastare — l’altra forma di violenza: quella dei cicli produttivi, delle nuove servitù, della precarizzazione dell’esistenza esperita nella dissoluzione di ogni pratica (prima ancora che cultura) della sicurezza sui luoghi di lavoro. Una Thyssenkruppizzazione diffusa che nasce a cavallo degli anni ’70-’80: prosciugato o esaurito il mare dell’antagonismo sociale, l’ostilità anti-istituzionale e anti-burocratica si è riconvertita nell’individualismo proprietario dell’ex operaio del nord-est che si fa padroncino investendo la liquidazione nel capannone industriale, mettendo il sapere operaio al servizio del capitale globale, diventando leghista o berlusconiano. È qui che la sinistra riformista perde, senza più saperla recuperare, la capacità non di interpretare ed esprimere, ma persino di leggere la società. Si badi: non la classe operaia, ma la società tutta. Perché l’operaio di cui parla Rossonon è solo quello di Mirafiori: nella fabbrica diffusa che è la società tardo-capitalistica, Mirafiori è ovunque. Accanto agli operai delle grandi e piccole fabbriche, la vera novità sta «nell’apparire di “aggregati sociali” caratterizzati da rivendicazioni del tutto originali”. Il movimento femminista e quello del proletariato giovanile costituiscono specificità d’indubbia rilevanza». Le lotte si diffondono sul terreno della produzione culturale, dei bisogni diffusi: alla centralità della fabbrica si sostituisce la metropoli. «Ora più di prima, la scelta delle parole, l’invenzione lessicale, la definizione d’altre “grammatiche” diventano strumenti specificamente politici» (p. 35). Non è, di nuovo, un orpello estetico: non a caso dopo il ’76, con la frantumazione del movimento in mille rivoli che, ognuno perso per i fatti suoi, se non si disseccano a Poona piuttosto che al Macondo o in qualche cupa sede clandestina, non riescono più, se non eccezionalmente, a mordere il reale e a cogliere l’estraneità dell’operaio sociale al militarismo, fa riscontro un gap linguistico, una lignificazione dei linguaggi: «sembra che l’intero piano delle metafore, delle ridefinizioni semantiche, dei richiami retorici, degli slittamenti di senso, dell’eccedente nonsense, pieghi a un certo punto verso l’allegoria bellicista e la ciclicità della Storia» (p. 65).
La rimozione di questo dato, congiunta alla cattiva infinità di una nostalgica e mitologica rievocazione dell’età dell’oro della classe operaia, ha reso quantomeno ambiguo il dibattito che sull’uso della violenza, contribuendo a perpetuare quell’equivoco che vuole, nella comune opinione, equiparati lo sciopero selvaggio e la banda armata, l’illegalità di massa e la pratica terroristica. Un’ambiguità che si fa costitutiva dell’incapacità di leggere — e contrastare — l’altra forma di violenza: quella dei cicli produttivi, delle nuove servitù, della precarizzazione dell’esistenza esperita nella dissoluzione di ogni pratica (prima ancora che cultura) della sicurezza sui luoghi di lavoro. Una Thyssenkruppizzazione diffusa che nasce a cavallo degli anni ’70-’80: prosciugato o esaurito il mare dell’antagonismo sociale, l’ostilità anti-istituzionale e anti-burocratica si è riconvertita nell’individualismo proprietario dell’ex operaio del nord-est che si fa padroncino investendo la liquidazione nel capannone industriale, mettendo il sapere operaio al servizio del capitale globale, diventando leghista o berlusconiano. È qui che la sinistra riformista perde, senza più saperla recuperare, la capacità non di interpretare ed esprimere, ma persino di leggere la società. Si badi: non la classe operaia, ma la società tutta. Perché l’operaio di cui parla Rossonon è solo quello di Mirafiori: nella fabbrica diffusa che è la società tardo-capitalistica, Mirafiori è ovunque. Accanto agli operai delle grandi e piccole fabbriche, la vera novità sta «nell’apparire di “aggregati sociali” caratterizzati da rivendicazioni del tutto originali”. Il movimento femminista e quello del proletariato giovanile costituiscono specificità d’indubbia rilevanza». Le lotte si diffondono sul terreno della produzione culturale, dei bisogni diffusi: alla centralità della fabbrica si sostituisce la metropoli. «Ora più di prima, la scelta delle parole, l’invenzione lessicale, la definizione d’altre “grammatiche” diventano strumenti specificamente politici» (p. 35). Non è, di nuovo, un orpello estetico: non a caso dopo il ’76, con la frantumazione del movimento in mille rivoli che, ognuno perso per i fatti suoi, se non si disseccano a Poona piuttosto che al Macondo o in qualche cupa sede clandestina, non riescono più, se non eccezionalmente, a mordere il reale e a cogliere l’estraneità dell’operaio sociale al militarismo, fa riscontro un gap linguistico, una lignificazione dei linguaggi: «sembra che l’intero piano delle metafore, delle ridefinizioni semantiche, dei richiami retorici, degli slittamenti di senso, dell’eccedente nonsense, pieghi a un certo punto verso l’allegoria bellicista e la ciclicità della Storia» (p. 65).
E invece nel 1975, in uno dei migliori (anche metodologicamente) articoli di Rosso— A Lenin non piaceva Frank Zappa — viene fotografata la tristezza del «militante perfetto [che] vive dei cascami della cultura riformista» e pratica la dimensione culturale solo all’interno degli schemi della Terza Internazionale: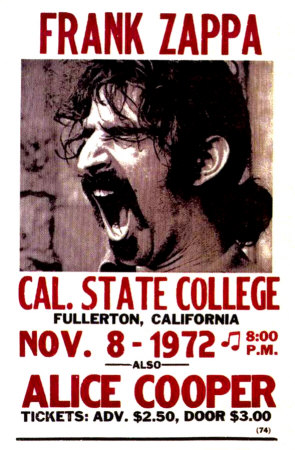 «evitare e il dubbio, scansare la crisi, parlare poco di sé non approvare comportamenti violenti e spontanei che non rientrano nelle tradizioni “pure”. E infine: occhio alla decadenza e al pessimismo». Invece, con un crescendo che sarà mirabilmente sintetizzato da Gianfranco Manfredi nella sua Quarto Oggiaro Story): «a noi piacciono i film western, quelli della “crisi”, il teatro-provocazione, il rock, i fumetti più illogici possibili, i libri senza martiri ed eroi, la riscoperta del proprio corpo […] e il comunismo lo pensiamo come una cosa molto lussuosa, dove nessuno starà in piedi su una zolla di terra a sudare piscia e sangue». Perché «non si può essere autonomi in fabbrica e sul territorio, e riformisti o neo-riformisti su “tutto il resto”». Con le parole d’un vecchio saggio: Duck, You Sucker! Qui, di nuovo, è il metodo dell’analisi (che i curatori del volume fanno proprio) a segnare la differenza tra Rossoe quella sinistra moderata che, cedendo ai «melanconici toni d’un pessimismo “crepuscolare”» (p. 30) e alle sirene dell’autonomia del politico, relega «la ricchezza del processo di produzione sociale nei sordidi quartieri d’una “seconda società”, versione imbellettata del Lumpen» (p. 21). Come l’operaio sociale si coglie solo a partire dalle lotte che ne marcano la genesi, e non dai banchi scolastici delle Frattocchie o dai libri dei Padri Fondatori — l’operaio, diceva il filosofo Roberto Dionigi, non si sfoglia; così i bisogni del proletariato metropolitano si colgono solo all’interno della multiforme creazione di nuovo essere sociale.
«evitare e il dubbio, scansare la crisi, parlare poco di sé non approvare comportamenti violenti e spontanei che non rientrano nelle tradizioni “pure”. E infine: occhio alla decadenza e al pessimismo». Invece, con un crescendo che sarà mirabilmente sintetizzato da Gianfranco Manfredi nella sua Quarto Oggiaro Story): «a noi piacciono i film western, quelli della “crisi”, il teatro-provocazione, il rock, i fumetti più illogici possibili, i libri senza martiri ed eroi, la riscoperta del proprio corpo […] e il comunismo lo pensiamo come una cosa molto lussuosa, dove nessuno starà in piedi su una zolla di terra a sudare piscia e sangue». Perché «non si può essere autonomi in fabbrica e sul territorio, e riformisti o neo-riformisti su “tutto il resto”». Con le parole d’un vecchio saggio: Duck, You Sucker! Qui, di nuovo, è il metodo dell’analisi (che i curatori del volume fanno proprio) a segnare la differenza tra Rossoe quella sinistra moderata che, cedendo ai «melanconici toni d’un pessimismo “crepuscolare”» (p. 30) e alle sirene dell’autonomia del politico, relega «la ricchezza del processo di produzione sociale nei sordidi quartieri d’una “seconda società”, versione imbellettata del Lumpen» (p. 21). Come l’operaio sociale si coglie solo a partire dalle lotte che ne marcano la genesi, e non dai banchi scolastici delle Frattocchie o dai libri dei Padri Fondatori — l’operaio, diceva il filosofo Roberto Dionigi, non si sfoglia; così i bisogni del proletariato metropolitano si colgono solo all’interno della multiforme creazione di nuovo essere sociale.
È qui che cominciano a trovare cogenza gli strumenti interpretativi elaborati in Francia da Deleuze, Guattari, Foucault; ed è qui che balenano le prime scintille di «una soggettività moltitudinaria irriducibile al concetto di popolo e nemica del potere costituito» (p. 33). Una soggettività — è il dubbio che ci rimane e che rilanciamo, in costruttiva polemica, non solo ai curatori, ma a chiunque vorrà fare un uso critico e non museale di queste pagine — che non poteva ieri, e non può oggi, vedere ridotta senza nocumento la propria complessità dalla categorizzazione leninista espansività-centralizzazione; che deve sapersi liberare, nei linguaggi e nelle pratiche, dalla necessità del leninismo per costruire forme fluide di proliferazione orizzontale: se Lenin non amava Frank Zappa, ancor meno potevano piacergli Sam Peckinpah e Sergio Leone.
Di nuovo: Duck, You, Sucker!
[versione integrale della recensione pubblicata su “Liberazione” del 26 marzo 2008]



