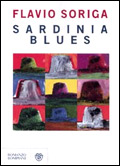Pani, Corda e Licheri, tre amici, tre abbandonati inconsolabili, tre pirati in quell’oceano che è la Sardegna senza vip, senza cartoline, senza lusso.
È la Sardegna vera, che non vuole più essere quella delle passioni deleddiane, dei rapimenti e d’inesprimibili linguaggi ancestrali, ma semplicemente isola di un selvaggio west in cui cavalcare tra persone che si conoscono, sparlano, si annoiano o un po’ si amano e locali di provincia che si fanno fondali simbolici di miraggi irrealizzabili. Non-luoghi del Montiferru campidanese di Soriga in un grande non-luogo che è la Sardegna contemporanea, che però lega indissolubilmente i tre protagonisti e ne pregiudica le vite arrabattate, complice uno smisurato spirito d’appartenenza.
È Davide Pani l’io narrante, il malato, il rifiutato, la parte di Soriga che si dispera ma non vuole smettere di sognare. Sembra sudamericano, ha vissuto per un lungo periodo a Londra dove ha amato follemente una ballerina che ha poi perduto, è sardo profondamente sardo sempre più sardo: ma critica questa terra che adora, che sente sua ma vuole staccare dalla propria pelle. Credo tuttavia non si possa considerare senso d’appartenenza deviato. Piuttosto tenderei a parlare di coscienza di sé e di mero spirito critico: vivere l’isola stabilmente è un conto. Abitare in una metropoli come Londra e poi tornare in Sardegna è ben altra cosa. Ciò che è cambiato in Davide/Soriga è il punto di vista sull’isola, la capacità di guardare da fuori un popolo, i suoi costumi e le abitudini consolidate, e immaginare traccia di se stessi in quel magma irresistibile.
 Sembrerà più triste il paesaggio contemplato. Sembrerà poco normale abusare di comportamenti “provinciali”, farne spesso motivo d’orgoglio, e soprattutto restare fermi immobili a guardare quello che si è stati, alla Sardegna tramandata, senza provare a dire o pensare qualcosa che possa — seppur minimamente — cambiare le cose.
Sembrerà più triste il paesaggio contemplato. Sembrerà poco normale abusare di comportamenti “provinciali”, farne spesso motivo d’orgoglio, e soprattutto restare fermi immobili a guardare quello che si è stati, alla Sardegna tramandata, senza provare a dire o pensare qualcosa che possa — seppur minimamente — cambiare le cose.
Davide ha vissuto all’estero, è stato con una bellissima ballerina che l’ha lasciato (e questa è la sorte che accomuna lui, Corda e Licheri), ma c’è qualcos’altro a rendere più smaccata la sua amarezza — e a renderne più gloriosa la reazione, la voglia di non mollare: è talassemico, una malattia del sangue che lo costringe dalla nascita a continue trasfusioni, a controlli serrati e incessanti, e a sentirsi un vampiro in costante pericolo di vita. Mezzo chilo di sangue altrui ogni tre settimane gli regala la forza di resistere e gli concede — almeno per i primi giorni — un’energia fuori del comune; ma è il ferro a trasformarsi in nemico incontrollabile: se, come gli accadde una volta nell’infanzia, si concentrasse in una singola zona qualunque del suo corpo, rischierebbe di morire improvvisamente.
Ma quello che la malattia comporta, e la consapevolezza che spinge Soriga a rivelare in questo romanzo per la prima volta tutto il suo disagio (ne I diavoli di Nuraiò, edito dal Maestrale, e in Neropioggia, da Garzanti, non erano presenti elementi autobiografici così sinceri e diretti), lo lascerei alla lettura del romanzo. Sarebbe tanto impossibile quanto ingiusto raccontare una confessione così sofferta.
Almeno un punto andrebbe però accennato: quello dell’elemento “etnico” che fa insistente capolino tra le pagine del romanzo. ![]() Sardinia blues (Bompiani, 16 €) va letto in questo caso come grande affresco bukovskiano (Sergio Pent) dell’isola appartenente alla letteratura sarda prima che italiana. Alle sue spalle non si può infatti eliminare l’apporto straordinario — forse irripetibile ma senz’altro trainante — del genio letterario di Sergio Atzeni. Dopo aver scavato dalla Sardegna a lui contemporanea (Atzeni morì in circostanze tragiche e adatte alla più disparate interpretazioni nel 1995) a quella del mito e della nascita, alla proto-Sardegna, aveva mostrato concretamente come popoli e lingue dovessero essere accostate per rendere — con fenomeni fonologici e profondamente metaforici — un mondo altro, senza tempo né confini, ma che proprio grazie all’influsso della pluralità e della commistione potesse ricercare una delle possibili verità.
Sardinia blues (Bompiani, 16 €) va letto in questo caso come grande affresco bukovskiano (Sergio Pent) dell’isola appartenente alla letteratura sarda prima che italiana. Alle sue spalle non si può infatti eliminare l’apporto straordinario — forse irripetibile ma senz’altro trainante — del genio letterario di Sergio Atzeni. Dopo aver scavato dalla Sardegna a lui contemporanea (Atzeni morì in circostanze tragiche e adatte alla più disparate interpretazioni nel 1995) a quella del mito e della nascita, alla proto-Sardegna, aveva mostrato concretamente come popoli e lingue dovessero essere accostate per rendere — con fenomeni fonologici e profondamente metaforici — un mondo altro, senza tempo né confini, ma che proprio grazie all’influsso della pluralità e della commistione potesse ricercare una delle possibili verità.
Ecco il passaggio fondamentale da cui Soriga parte per la sua lingua spesso “sporcata” e cadenzata dal sardo, ma anche dall’inglese, dallo spagnolo… Davide ha già nel suo stesso corpo tracce culturali altrui: le trasfusioni iniettano nel suo corpo di vampiro anime differenti, geni e caratteristiche di altri popoli. È come se in lui vivessero le diversità che vorrebbe arricchissero il panorama provinciale sardo: le ballerine, che rappresentano insieme la delusione dei tre pirati e il loro sogno di un futuro meno claustrofobico, sono lo specchio di una possibile apertura.
Filippo La Porta parla per Sardinia blues di confronto con la modernità e di assenza di radici; credo che colga il fulcro della ricerca di Soriga soltanto per quanto concerne l’accostamento con il mondo attuale. Il problema legato alle radici si sviluppa invece in maniera diametralmente opposta: troppo profonde per essere estirpate — e lungi Soriga dal volerlo fare, altrimenti non avrebbe certo incentrato sull’isola la sua storia e il panorama dei suoi riferimenti — le radici lo rendono insofferente a una certa idea erroneamente indotta del territorio sardo. Critica la Deledda, accusandola di menzogne, faciloneria e uso spropositato di luoghi comuni (veemente l’attacco al nome del figlio, Sardus, quale estrema onta di chiusura e cattivo gusto). Ma c’è in realtà tanta letteratura sarda in Sardinia blues, e la stessa Deledda si trasforma in una sorta d’incarnazione della trappola del tipo di Sardegna da cui Soriga vorrebbe fuggire.
L’ultima delle dediche dell’autore recita infatti testuali parole: “ai sardi che sanno essere leggeri”. Da qui bisognerebbe partire per decodificare la protesta del giovane autore: il suo non è un attacco esplicito alla Sardegna — e si spera che i sardi che sanno essere leggeri l’abbiano colto. Quello che Soriga attacca è il mondo sardo che si chiude a riccio per preservare la propria identità, quello dei circoli sardi che — talvolta — alle novità prediligono la protezione delle glorie del passato (tornando, appunto, alla Deledda, o nel migliore dei casi a Dessì o Sebastiano Satta), che alle capacità di uno scrittore italiano del calibro di Giorgio Todde tendono a preferire le rime d’improvvisazione.
Si arriva così ai riferimenti al mondo letterario contemporaneo di Sardinia blues, che prendono il via dal romanzo impossibile di Andrea Corda, uno dei tre protagonisti, il più unito a Davide (che con lui condivide un segreto: basta un attimo e si può perdere qualunque cosa — essere disillusi, seppure non passivamente, è la consapevolezza che li lega). Corda, in un attimo di grande sconforto per la stesura di un libro che gli sembra a ogni lettura meno accettabile, polemizza urlando contro il cliché dello “scrittore sardo”, ancorato da sempre e per sempre al Sud, alle tradizioni, alla generosità di quella brava gente e all’incredibile bellezza del loro mare. Più di tutto lo atterrisce l’idea di poter essere additato come “ennesimo narratore di una terra inenarrabile”, di essere invitato per un tour dei circoli sardi italiani, essere accomunato — come si accennava sopra — alla Deledda da gente che non conosce neppure l’esistenza di Roth o Carver.
Ma Corda, e con lui i suoi amici, sogna però anche un film sulla provincia sarda (La terra dei castelli di pietra si potrebbe chiamare, o “un titolo simile che alluda a tutte le puttanate sulla nostra storia unica e straordinaria eccetera”): è questo il nodo della contraddizione, uno dei momenti del romanzo in cui Soriga ammette — al pubblico e a se stesso — che quelle diavolo di origini gli piacciono, sono sue, non vuole perderle… però.
Puntualizzati alcuni punti chiave, si può ora giungere all’accenno di trama che Soriga propone, e che determina anche lo squilibrio di questo commento-recensione. L’intreccio è assolutamente secondario, se quello che si vuole fornire è uno spaccato della confusione di una generazione di disoccupati che vaga per un’isola fantastica che ha però così poco da offrire. Sopravvissuti a un amore appassionato e divorante che ha dato l’ultima stoccata alle loro illusioni, i tre pirati del Messico sardo si barcamenano tra piccoli furti, fughe amorose (e qui spicca il personaggio di Dani, la ragazza bella e sensuale che ama ballare, il simbolo di una certa concezione della donna di paese), musiche lontane che li fanno sentire parte del resto del mondo, pettegolezzi di un minuscolo paese terrorizzato da droga e omosessualità, ma che non riesce a realizzare — complice l’abitudine — i reali problemi da cui è attanagliato (“[…] lunghi tortuosi inarrestabili impensabili i percorsi delle maldicenze, la fuga dei ragazzi dei nostri paesi per Londra e Barcellona, non è solo il lavoro che non c’è, Aria aria aria, lontano da qui, fatemi scappare da queste arpie che sussurrano e chiacchierano e inventano e giudicano — Ma l’hai vista la figlia del tale come si veste?, Ma lo sai che il figlio del tale si droga? —, DROGA DROGA DROGA, ossessione delle loro menti, mariti e figli persi nell’alcool nei trenta bar di ogni nostro piccolo o minuscolo paese ma questo non conta, ad ogni ora fin dal mattino moltitudini di uomini e lavoratori e padri e mariti al bancone di un bar ubriachi persi ma questo non è grave, DROGA DROGA DROGA, non compro mai il fumo e non so preparare le canne, non tiro mai la cocaina e bevo così poco, il mio fisico non mi permette quasi niente, questa è la cosa peggiore della mia malattia e nessuno me l’ha mai detto ma lo sento, eppure basta così poco a farti essere una volta e per sempre un drogato, un probabile o sicuro drogato, tossico maledetto stonato, sono un drogato da dicerie di villaggio, un tossico ipotetico, fumo dei mezzi sigari ed è tutto il mio sballo, ho smesso di ascoltare le donne nelle corriere, la gente che tutto sa e giudica, — Lasciamo perdere, quante cose potrei dirti, non farmi parlare —, sono dure da riempire, in effetti, le giornate nei nostri paesi […]”).
Nulla da aggiungere, credo, aldilà di una puntualizzazione sullo stile torrenziale di Soriga. Abolito il punto per sottolineare una ricerca decisa di velocità e continuità che sembra voler affastellare pensieri, narrazione e descrizioni (e qui torna Atzeni, col suo Bellas mariposas, ma anche Paolo Nori), tutto è privo di ordine e gerarchia, e le parole sembrano ricalcare esattamente le variazioni ritmiche interne di rabbia e desiderio dei protagonisti. Il flusso è specchio di uno stato d’animo reattivo, scandito dagli spazi che interrompono l’intreccio, di una voglia infinita di non mollare e dire/fare qualcosa perché anche la Sardegna cambi, pur rimanendo la loro Sardegna.
Per concludere, Cristina Taglietti, sul “Corriere” del 21 gennaio, lo inscrive con merito nel cosiddetto rinascimento sardo — seppur così vario per tematiche, stile e uso della lingua — a fianco di Milena Agus, Salvatore Niffoi e Marcello Fois, dimenticando però scrittori come Todde, “l’immigrato” Carlotto, Angioni, Marrocu e Abate (che su “Tuttolibri” Sergio Pent non omette). Ma è giusto parlare di rinascimento sardo per scrittori così diversi? Non si rischia di fare un passo indietro, e di fare irritare Flavio Soriga? Una cosa è certa: non sarebbe male cominciare a parlare di scrittori italiani, bravi o meno, più o meno interessanti e di ampio respiro.