di Girolamo De Michele 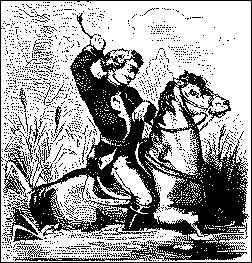
(Versione integrale dell’articolo pubblicato su Liberazione-Queer del 14 gennaio 2007)
Nel 1550, a Valladolid, l’erudito aristotelico Ginés de Sepúlveda e il domenicano Bartolomé de Las Casas, vescovo di Chiapas dusputarono sulla superiorità della civiltà cattolica europea rispetto alla natura barbara e feroce degli amerindi. A uno sguardo ingenuo la contrapposizione appare evidente. Per Sepúlveda i “selvaggi” vivono in una condizione naturale, prossimi più alle scimmie che agli uomini, in preda agli istinti ferini e privi di quella ragione che, per contro, si evidenzia nelle pratiche dei civilizzati europei. Per Las Casas, al contrario, i nativi vivono in una naturale condizione adamitica, prossima a quella di Adamo prima del peccato: sono naturalmente predisposti all’evangelizzazione, poiché la loro natura non solo non si oppone, ma prelude al messaggio culturale di cui sono portatori i missionari europei.
Di questa facile distinzione ha fatto giustizia, in un’opera classica e imprescindibile, Tzvetan Todorov (La conquista dell’America, 1982), dimostrando che Las Casas condivide con Sepúlveda il pre-giudizio dell’ideale di sé come elemento a partire dal quale valutare l’alterità nelle sue differenze o identità. I due duellanti ci ricordano, insomma, la classica copia di sbirri dei film polizieschi: l’uno buono e l’altro cattivo, entrambi giocatori dello stesso gioco. Di queste strane coppie è piena la storia del pensiero, ogni volta che si tratta di delimitare il terreno della “natura umana” rispetto alla “cultura”. Ad esempio, Hobbes argomentava la necessità di uscire dalla condizione naturale per realizzare quell’artificio politico che è il Leviatano, laddove Locke sosteneva che già in natura sono posti i diritti fondamentali dell’uomo, primo fra tutti la proprietà privata fondata sul lavoro. Per entrambi si tratta in realtà di costruire la forma politica più efficiente rispetto alla domanda di sicurezza generata dalle guerre civili e più funzionale alla circolazione monetaria sulla quale la borghesia inglese fonda la propria egemonia (ricordiamo che per lavoro qui si intende non la prestazione di forza-lavoro, ma l’anticipazione del capitale da parte dell’imprenditore). Che questo ordine politico sia del tutto artificiale (superamento dell’homo-natura attraverso un processo di civilizzazione) o sia lo sviluppo e il potenziamento della natura umana, senza traumatiche rotture, risulta meno interessante del reale equilibrio dei poteri che si attua nel modello hobbesiano piuttosto che in quello lockeano, affermatosi con la Gloriosa Rivoluzione. Hobbes, insomma, vuole rompere con la condizione naturale perché in essa non trova elementi per fondare il mercantilismo autoritario, Locke vuole conservare la positività della condizione naturale perché in essa riesce a fondare l’egemonia della borghesia inglese depurata dalle asprezze dei Livellatori (eguaglianza politica, limitazione della proprietà individuale, diritto di voto esteso a qualunque lavoratore, sia pure immigrato, sovranità parlamentare). C’è dunque di che sospettare della coppia natura-cultura, sia che i due termini siano intesi come poli contraddittori, sia che l’una sia la valorizzazione dell’altra. Non è casuale che la differenziazione tra natura e cultura sia anche stata un potente strumento di discriminazione razziale: il chiodo fisso della “mancanza di storia” delle popolazioni africane che, da Hegel a Heidegger, attraversa un certo pensiero filosofico è un sintomatico esito di questa differenziazione, del tutto analogo allo spirito imperialistico col quale gli europei hanno inventato il selvaggio civilizzabile, cioè quello più simile nelle pratiche (economia stanziale contro commercio) e persino nell’aspetto fisico (i Tutsi apparivano “belli” perché armonici, gli Hutu sgraziati e rozzi, dunque selvaggi) ad assumere il ruolo di tramite intermedio del processo di civilizzazione che veniva portato in Africa. Cos’è dunque che non funziona, nella coppia terminologica natura-cultura? Torniamo ai nostri duellanti cinquecenteschi. Sepúlveda, da buon aristotelico, crede fermamente nell’esistenza di gerarchie naturali, e su di esse fonda una serie di coppie antinomiche: indiani/spagnoli, bambini/adulti, donne/uomini, animale/umano, intemperanza/temperanza, corpo/anima (deducibili dall’Etica Nicomachea e dal primo libro della Politica, se alla prima coppia si sostituisce quella barbaro/greco). La natura è per lui il ricettacolo di tutte le polarità negative, e come tale fornisce un’assiologia negativa: così facendo l’erudito spagnolo anticipa quel versante pessimistico e conservatore del pensiero moderno (da Taine a Gehlen) che vede nella scoperta dell’animale istintivo nel cuore stesso dell’essere umano qualcosa da disciplinare e irregimentare in un sistema di forze che rimanda alla disciplinazione delle masse da parte dei regimi fascisti. Per Las Casas la natura è l’origine di quanto di positivo manifesta la civiltà, e non conosce invece quegli aspetti distruttivi (gli spagnoli sono paragonati a “lupi crudelissimi”, gli indios a “tenere pecorelle”) che l’uomo, nell’eccedere sulla via dell’errore, può manifestare. Se infatti le tenere pecorelle amerindie accettano docilmente l’evangelizzazione, turchi e mori, «veri rifiuti barbari delle nazioni», la rifiutano. In questo caso la natura fornisce un’assiologia positiva, funzionale alla caratteristica xenofobia del paese devoto a San Jago de Compostela, persecutore dei Moros (come lo Jago shakespeareano lo è nei confronti del moro Otello). Entrambi credono di parlare della “natura” come di un oggetto che “sta lì” e, lì dov’è, è fonte di valori, cioè di cultura. Entrambi, in realtà, proiettano in quell’oggetto i propri valori: creano, sulla base del proprio bagaglio culturale, un oggetto che presumono obiettivo e che chiamano “natura”. Questa mossa era coerente con l’aristotelismo scolastico (ma non con gli aristotelici arabi e gli averroisti), che interpreta la natura attraverso le griglie delle categorie metafisiche, prima fra tutte il finalismo. Meno coerente è la sua riproposizione, nascosta sotto forma di una critica alla comprensione scientifico della natura, che affiora dal discorso di Regensburg. Il bersaglio primo del discorso di Ratzinger del 12 settembre 2006 è infatti non tanto una generica «sintesi tra platonismo (cartesianismo) ed empirismo, che il successo tecnico ha confermato», ma la comprensione scientifica del mondo che si dà a partire da Galilei e Newton, col rifiuto del finalismo, dell’essenzialismo e dell’assiologia. La scienza non si chiede il perché delle cose, ma il come: non ne indaga il valore, ma il funzionamento. I valori sono sradicati dalla fondazione in una natura che è tenuta a rilucere dello splendore della verità rivelata, e diventano oggetto della determinazione umana: cessano di essere enti di natura, e diventano prodotti della cultura, cioè del concreto agire umano (e non certo «dalle regole dell’evoluzione», come subdolamente afferma Ratzinger). A questa comprensione a-valutativa del mondo si accompagna la progressiva perdita di centralità dell’uomo in quanto ente privilegiato, dalle amare riflessioni dell’ultimo Lévi-Strauss sulle creazioni dello spirito umano — “il loro senso non esiste che in rapporto all’uomo e si confonderanno nel disordine quando egli sarà scomparso” (Tristi tropici) — alla lucida diagnosi del post-strutturalismo francese sulla precarietà e transitorietà del soggetto, il pensiero post-moderno ha tracciato le direttive di un nuovo modo di essere nel mondo.
il chiodo fisso della “mancanza di storia” delle popolazioni africane che, da Hegel a Heidegger, attraversa un certo pensiero filosofico è un sintomatico esito di questa differenziazione, del tutto analogo allo spirito imperialistico col quale gli europei hanno inventato il selvaggio civilizzabile, cioè quello più simile nelle pratiche (economia stanziale contro commercio) e persino nell’aspetto fisico (i Tutsi apparivano “belli” perché armonici, gli Hutu sgraziati e rozzi, dunque selvaggi) ad assumere il ruolo di tramite intermedio del processo di civilizzazione che veniva portato in Africa. Cos’è dunque che non funziona, nella coppia terminologica natura-cultura? Torniamo ai nostri duellanti cinquecenteschi. Sepúlveda, da buon aristotelico, crede fermamente nell’esistenza di gerarchie naturali, e su di esse fonda una serie di coppie antinomiche: indiani/spagnoli, bambini/adulti, donne/uomini, animale/umano, intemperanza/temperanza, corpo/anima (deducibili dall’Etica Nicomachea e dal primo libro della Politica, se alla prima coppia si sostituisce quella barbaro/greco). La natura è per lui il ricettacolo di tutte le polarità negative, e come tale fornisce un’assiologia negativa: così facendo l’erudito spagnolo anticipa quel versante pessimistico e conservatore del pensiero moderno (da Taine a Gehlen) che vede nella scoperta dell’animale istintivo nel cuore stesso dell’essere umano qualcosa da disciplinare e irregimentare in un sistema di forze che rimanda alla disciplinazione delle masse da parte dei regimi fascisti. Per Las Casas la natura è l’origine di quanto di positivo manifesta la civiltà, e non conosce invece quegli aspetti distruttivi (gli spagnoli sono paragonati a “lupi crudelissimi”, gli indios a “tenere pecorelle”) che l’uomo, nell’eccedere sulla via dell’errore, può manifestare. Se infatti le tenere pecorelle amerindie accettano docilmente l’evangelizzazione, turchi e mori, «veri rifiuti barbari delle nazioni», la rifiutano. In questo caso la natura fornisce un’assiologia positiva, funzionale alla caratteristica xenofobia del paese devoto a San Jago de Compostela, persecutore dei Moros (come lo Jago shakespeareano lo è nei confronti del moro Otello). Entrambi credono di parlare della “natura” come di un oggetto che “sta lì” e, lì dov’è, è fonte di valori, cioè di cultura. Entrambi, in realtà, proiettano in quell’oggetto i propri valori: creano, sulla base del proprio bagaglio culturale, un oggetto che presumono obiettivo e che chiamano “natura”. Questa mossa era coerente con l’aristotelismo scolastico (ma non con gli aristotelici arabi e gli averroisti), che interpreta la natura attraverso le griglie delle categorie metafisiche, prima fra tutte il finalismo. Meno coerente è la sua riproposizione, nascosta sotto forma di una critica alla comprensione scientifico della natura, che affiora dal discorso di Regensburg. Il bersaglio primo del discorso di Ratzinger del 12 settembre 2006 è infatti non tanto una generica «sintesi tra platonismo (cartesianismo) ed empirismo, che il successo tecnico ha confermato», ma la comprensione scientifica del mondo che si dà a partire da Galilei e Newton, col rifiuto del finalismo, dell’essenzialismo e dell’assiologia. La scienza non si chiede il perché delle cose, ma il come: non ne indaga il valore, ma il funzionamento. I valori sono sradicati dalla fondazione in una natura che è tenuta a rilucere dello splendore della verità rivelata, e diventano oggetto della determinazione umana: cessano di essere enti di natura, e diventano prodotti della cultura, cioè del concreto agire umano (e non certo «dalle regole dell’evoluzione», come subdolamente afferma Ratzinger). A questa comprensione a-valutativa del mondo si accompagna la progressiva perdita di centralità dell’uomo in quanto ente privilegiato, dalle amare riflessioni dell’ultimo Lévi-Strauss sulle creazioni dello spirito umano — “il loro senso non esiste che in rapporto all’uomo e si confonderanno nel disordine quando egli sarà scomparso” (Tristi tropici) — alla lucida diagnosi del post-strutturalismo francese sulla precarietà e transitorietà del soggetto, il pensiero post-moderno ha tracciato le direttive di un nuovo modo di essere nel mondo. Tramonto del soggetto, declino dell’antropocentrismo significa infatti possibilità di nuovi rapporti col vivente non-umano (il tema dei diritti degli animali rilanciato con forza da Martha Nussbaum) e con l’ambiente (formulazione di diritti impersonali non vincolati al soggetto umano, come i diritti dell’ambiente, dei mari, delle montagne). In luogo dell’imperialismo culturale nei confronti della natura si intravede la possibilità di recuperare una visione della natura comune a tutte le cose «come caos indifferenziato, come molteplicità potenziale» scevro dalla pesantezza dei valori e della metafisica, quell’atomismo che Calvino riproponeva nelle Lezioni americane, il più importante testo filosofico di fine millennio, la cui lettura è sempre un antidoto nei confronti dei paralogismo di chi, dalla constatazione che il relativismo è frutto della fine dei valori della tradizione, ne deduce la negatività perché, appunto, è male che valori e gerarchie tramontino: con buona pace del barone di Münchhausen, non si fuoriesce dalla palude tirandosi per il codino.
Tramonto del soggetto, declino dell’antropocentrismo significa infatti possibilità di nuovi rapporti col vivente non-umano (il tema dei diritti degli animali rilanciato con forza da Martha Nussbaum) e con l’ambiente (formulazione di diritti impersonali non vincolati al soggetto umano, come i diritti dell’ambiente, dei mari, delle montagne). In luogo dell’imperialismo culturale nei confronti della natura si intravede la possibilità di recuperare una visione della natura comune a tutte le cose «come caos indifferenziato, come molteplicità potenziale» scevro dalla pesantezza dei valori e della metafisica, quell’atomismo che Calvino riproponeva nelle Lezioni americane, il più importante testo filosofico di fine millennio, la cui lettura è sempre un antidoto nei confronti dei paralogismo di chi, dalla constatazione che il relativismo è frutto della fine dei valori della tradizione, ne deduce la negatività perché, appunto, è male che valori e gerarchie tramontino: con buona pace del barone di Münchhausen, non si fuoriesce dalla palude tirandosi per il codino.



