di Gaspare De Caro e Roberto De Caro

Contabilità
Riproponiamo l’articolo Come si muore a Bologna, già pubblicato in Hortus Musicus, III, 11, luglio-settembre 2002, evocativo di un episodio esemplare del nostro modo di essere e di non essere più, del diverso trattamento, cioè, che le nostre usanze civiche riservano ai morti dello Stato e ai morti della società. Cade a proposito un tale tema nel momento in cui da ogni parte politica si esibisce con concorrenziale cordoglio la memoria dei militari italiani morti tre anni fa a Nassirya, in quella che l’excusatio costituzionalista ha persistito a garantire, con memorabile trovata lessicale, guerra non guerreggiata. Tali guerre pacifiche, d’altra parte, non da oggi listano a lutto i semisecolari bollettini irenici delle nostre Forze armate, mandate dallo Stato a cercar glorie cavourriane in improbabili Crimee e a fraternizzare con locali generalmente poco inclini alle parentele coatte, in Congo, Somalia, Mozambico, Libano, Bosnia, Kosovo, Albania, Macedonia, Iraq, Afghanistan, ancora Libano.
Secondo i calcoli del ministro della Difesa Parisi sarebbero 106 i militari morti in tali missioni all’estero dal 1960: senza dubbio tanti, e noi doverosamente ci associamo al compianto, ma la reiterazione non dovrebbe esimere i nostri politici dall’ostentare ogni volta un doloroso stupore? Comunque non è questo il punto al quale ci richiama l’articolo che segue. Al ricordo, all’apprezzamento, agli onori giustamente tributati dallo Stato a questi caduti, nonché a quelli in servizio di Stato all’interno, non fanno per nulla riscontro altrettanta attenzione e cordoglio pubblico per le vittime della guerra – guerreggiata, non guerreggiata? – che insanguina aspetti della nostra vita niente affatto esenti dalle responsabilità dell’amministrazione. Le statistiche delle vittime degli incidenti stradali, per esempio – settemila in un anno, più ventimila feriti – non meriterebbero almeno un armistizio invece delle ricorrenti deprecazioni delle Autorità abbinate alla inflessibile, bellicosa promozione della motorizzazione patriottica? Di incidente però si muore più negli ospedali che sulle strade: 90 morti al giorno, secondo alcune associazioni mediche; altre associazioni discutono le cifre, ma non smentiscono la gravità del fenomeno, il micidiale accumulo di errori tecnici e disfunzioni. Non sarebbe ora che lo Stato conducesse una campagna di pace anche negli ospedali? Come si muore a Bologna ci richiama però in particolare alle vittime di incidenti mortali sul lavoro: cento al mese, quanti i militari morti all’estero in cinquant’anni. Ma è una stima al ribasso, perché i lavoratori in nero stentano, vivi o morti, ad entrare nelle statistiche. Tanto meno se non hanno il permesso di soggiorno, ministri in lacrime alla loro morte non se ne vedono.
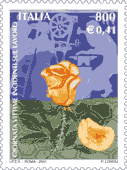
Come si muore a Bologna
Il 21 marzo 2002 è morto a Bologna, a ventinove anni, Reuf Islamj. Non una morte eccellente, come l’altra bolognese di quegli stessi giorni, a poche centinaia di metri dalla sua. Non meno atroce, la morte di Reuf Islamj, ma non altrettanto eccellente. Perciò, giustamente, niente lutto cittadino, niente cordoglio nazionale per lui, niente fiaccolate di sdegno, niente autorevoli visite espiatorie ai familiari, niente interrogazioni parlamentari. Nessun cardinale ha invocato le pene dell’inferno per gli esecutori e i mandanti della sua morte, per lui nessuno zelante provveditore agli studi ha chiesto didattico che si parli nelle scuole del «valore inalienabile della persona». Niente. Perché non c’era nulla di eccellente nella sua morte, come non c’era nulla di eccellente nella sua vita. E dunque niente. Lavorava per l’Università, è vero, ma non era un professore: perciò l’Alma Mater non ha trovato un’aula da dedicargli, come usa per le morti eccellenti. Si è solo affrettata a dichiarare «di non avere alcun tipo di responsabilità nella vicenda luttuosa di Reuf Islamj, essendo la semplice destinataria del lavoro finito e non la commissionaria di opera». Nel dotto distinguo giuridico dell’Alma Mater non sentite alitare lo spirito di Irnerio? E del resto Irnerio avrebbe mostrato maggiore contrizione per la morte di uno sterratore? Questo infatti era Reuf Islamj, e di questo è morto.
Era un clandestino albanese, espulso già due volte dall’Italia, di quelli caparbiamente scampati agli affondamenti, ai rastrellamenti, ai recinti dell’«accoglienza». Era venuto da Valona «in cerca di fortuna», informa con sadismo involontario (forse) la stampa cittadina. Di fatto alla fine aveva avuto fortuna: non era sopravvissuto alimentando le angosce proprietarie della grassa Bologna, aveva trovato lavoro. Uno di quei lavori per i quali, come il nostro Presidente pazientemente ammonisce gli xenofobi, abbiamo bisogno di loro. Nel caso di Reuf lavoro nero, diritto non scritto della libertà di intrapresa; lavoro mansueto, domato dalla sua stessa precarietà; lavoro davvero libero, insomma: da antieconomiche rigidità salariali e da ingombranti norme di sicurezza. Gli hanno fatto scavare una buca di quattro metri per «adeguamento igienico-funzionale» – senza eleganti eufemismi: per le fogne dell’Alma Mater. Era in fondo a quella fossa, a scavare ancora, quando una frana annunziata lo ha sepolto vivo. Lo hanno tratto di lì troppo tardi, sei ore dopo. Lo hanno pianto in pochi: una vecchia zia, i compagni di lavoro, tra cui due cugini venuti anche loro «in cerca di fortuna», qualche bolognese che lo aveva conosciuto e gli era amico. Ma non c’erano fiori su quella buca, erano finiti tutti su un altro marciapiede, poco lontano.
Reuf Islamj è tornato a Valona per esservi seppellito. Giusto così: forse non era nemmeno cristiano e, come raccomanda sempre il cardinale Biffi, non è il caso di turbare la cittadinanza con riti alieni. Naturalmente si sono aperte inchieste. Si aprono sempre, dopo. Ma dimenticheremo presto Reuf Islamj. Qualcuno anzi, come il manifesto, che era a Bologna per quell’altra morte, quella eccellente, ha preferito non occuparsene affatto. Non a caso. La vita e la morte dei clandestini non sono all’ordine del giorno: nemmeno votano! Allora meglio tacere, aggiungere il proprio silenzio agli autorevoli, realistici avalli della necessità economica, con i suoi costi, ahimè, inevitabili. Abbiamo bisogno di ouvriers sans papier, dello stupro senza limiti e senza vergogna di forza lavoro inerme, complice in tutta Europa la calcolata avarizia dell’ospitalità. L’Europa ha bisogno di schiavi. Reuf Islamj non era importante, era solo uno di loro.



