|
Texto disponible también en
 ESPAÑOL ESPAÑOL |
Note e digressioni sulla presunta “bianchitudine” del punk
e le origini afro del corpo rock
di Wu Ming 1
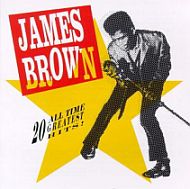 [Questo saggio di non facile lettura, scritto nell’estate 2006, è uscito sul n. 23 di Mucchio EXtra, trimestrale di approfondimento musicale. Il numero è attualmente in edicola, con lunghi speciali su Lucio Battisti, Beach Boys (notevolissimo), George Clinton, Tom Verlaine e una lista ragionata dei 100 album fondamentali di country-rock. La versione che pubblichiamo qui è diversa nell’impostazione tipografica, poiché i capoversi sono separati l’uno dall’altro e numerati a ritroso, come in un countdown. WM1]
[Questo saggio di non facile lettura, scritto nell’estate 2006, è uscito sul n. 23 di Mucchio EXtra, trimestrale di approfondimento musicale. Il numero è attualmente in edicola, con lunghi speciali su Lucio Battisti, Beach Boys (notevolissimo), George Clinton, Tom Verlaine e una lista ragionata dei 100 album fondamentali di country-rock. La versione che pubblichiamo qui è diversa nell’impostazione tipografica, poiché i capoversi sono separati l’uno dall’altro e numerati a ritroso, come in un countdown. WM1]
I. AFRICAN GENESIS
Gli africani sono il raggruppamento umano più antico del pianeta, e ogni estetica che abbia a che fare con la società umana deve assumerli almeno come punto di partenza!
– Amiri Baraka, 1994.
20. Lo rivelò il Guardian alla fine del decennio scorso: gruppi neo-fascisti di diversi paesi avevano comprato Los Pedriches, villaggio spagnolo abbandonato a una novantina di chilometri da Valencia. Intendevano trasformarlo in insediamento “utopico”, rifugio per latitanti, sede di convegni e colonie estive dove sperimentare il lifestyle di un futuro “nuovo ordine”. C’era e c’è lo zampino – anzi, trattandosi di maiali, lo zampone – di una nota formazione di ultradestra con un piede a Roma e uno a Londra.
Nei dépliants che si ebbe modo di vedere, si invitavano i giovani d’Europa a trasferirsi a Los Pedriches e sottoporsi a una severa disciplina, per smetterla di “parlare, muoversi, agire come dei negri” (corsivo mio). Un chiaro riferimento all’influenza dell’hip-hop: andatura dondolona, gestualità esagerata, braghe col cavallo infimo, slang appropriato alla bisogna. Antropologia da incubo, per un nazi.
Wiggers Beware! è la minaccia che appare sui siti di klanisti, miliziani e nazi americani. “State attenti, negri bianchi!”
19. 1967. Nel suo libro d’esordio Soul On Ice, scritto in carcere, il futuro leader delle Pantere nere Eldridge Cleaver dice alcune cose sul twist:
La missione di Chubby Checker fu insegnare di nuovo ai bianchi, che nel corso della loro storia l’avevano scordato, come si dimena il culo. E’ un’abilità che un tempo possedevano, ma che avevano abbandonato, spinti dal sogno puritano di rifuggire la corruzione della carne, lasciando ai neri i pericoli del Corpo […] Il twist fu un missile teleguidato lanciato dal ghetto nel cuore dei sobborghi. Il twist riuscì dove politica, religione e leggi avevano fallito, e scrisse nei cuori e nelle anime ciò che la Corte Suprema poteva scrivere soltanto sui libri.
 18. Dobbiamo a Padre Stephen Theodore Badin, sacerdote cattolico dell’ordine dei Sulpiziani, la descrizione orripilata di un revival metodista in Kentucky, nel 1805:
18. Dobbiamo a Padre Stephen Theodore Badin, sacerdote cattolico dell’ordine dei Sulpiziani, la descrizione orripilata di un revival metodista in Kentucky, nel 1805:
Là essi predicano molto e pregano pochissimo. Si divertono, bevono liquori e urlano canzoni sacre e profane. Danzano o saltano senz’ordine, e cadono a terra esanimi come morti; hanno movimenti del corpo della testa, dei piedi e delle mani che di solito sembrano involontari, come quelli degli energumeni: si stracciano via parte dei vestiti, specialmente il sesso che dovrebbe essere più modesto […] Si possono vedere numerosi ministri bianchi e neri, agitati come furie, che gridano frasi sibilline fatte di testi sacri senz’ordine, il cui grande potere è quello di collegare i sensi e l’immaginazione, di rinnovare la superstizione e di eccitare forti passioni. Quelli che partecipano si esprimono con rapidità, rumore e impetuosità, senza fermarsi un istante, ripetendo con enfasi e con le contorsioni di un prestigiatore molti brani tolti dalla scrittura, senza preoccuparsi di renderli intelligibili […] le donne: come pitonesse di Apollo appaiono in grande agitazione con sguardi selvaggi, tremano violentemente, cantano esortano, ballano, pregano, battono le mani […] Essi chiamano queste stravaganze Revivals of Religion. (Citato in: Luca Cerchiari, Civiltà musicale afro-americana. Alle origini del jazz, del samba e dei canti spirituali, Mondadori, 1999).
Secondo gli studiosi di cultura afroamericana, quella di Badin è una delle più antiche testimonianze di un processo che avrebbe sconvolto e trasformato per sempre la società e la cultura americana.
Influenza reciproca: all’evangelizzazione degli schiavi africani da parte di battisti e metodisti corrisponde una “africanizzazione” del cristianesimo. I neri, a modo loro, pregano il Dio dei bianchi. Di contro alcuni bianchi, in determinate occasioni, si muovono, danzano, gridano, rantolano e vanno in trance come fossero posseduti dagli Orishas, gli spiriti della religione Yoruba.
Oltraggio, sovversione pura. Un bianco non può voler muoversi come un negro!
17. E’ il morbo che Ishmael Reed (nel romanzo Mumbo Jumbo) chiama Jes Grew (“jazz grew” / “it just grew”). Un’epidemia sociale che ogni tanto s’impenna e sale, trova il suo tipping point e aggredisce la società americana (e in seguito quella europea).
Jes Grew è il contagio del muoversi da negri, l’infezione della danza che fa scuotere il culo, “l’uragano spirituale che solleva detriti di 2000 anni dalle loro radici spargendoli ovunque”.
Con la rapidità stupefacente del Telegrafo Segreto di Booker T. Washington, Jes Grew si diffonde in America secondo uno strano percorso. Sono colpite Pine Bluff e Magnolia nell’Arkansas, A Natchez, Meridian e Greenwood nel Mississippi altri casi. Epidemie sporadiche scoppiano a Nashville e a Knoxville nel Tennessee come anche a St. Louis dove la sculettata e le contorsioni costringono il governatore a chiamare la Guardia Nazionale. E’ un’influenza potente, Jes Grew infetta tutto ciò che tocca.
No, un bianco non può voler muoversi come un negro. Occorre reprimere, recintare, segregare, e al contempo attenuare gli effetti, edulcorare le forme.
Ma Jes Grew è troppo forte. E’ arrivato in America con gli schiavi, e subito ha attinto alla fonte dei millenni, ha riavviato un processo, unificando ciò che è diviso, divaricando ciò che è unito.
 16. “Genesi africana”. Modello “Out of Africa”. Veniamo tutti da là. Lo hanno scoperto i paleontologi, lo stanno dimostrando i genetisti. Studiando l’origine dei nostri geni, risaliamo a una donna africana di 150.000 anni fa, la più recente antenata comune di tutti gli umani viventi. La nostra “Eva mitocondriale”.
16. “Genesi africana”. Modello “Out of Africa”. Veniamo tutti da là. Lo hanno scoperto i paleontologi, lo stanno dimostrando i genetisti. Studiando l’origine dei nostri geni, risaliamo a una donna africana di 150.000 anni fa, la più recente antenata comune di tutti gli umani viventi. La nostra “Eva mitocondriale”.
“Look back, look back, Athena was black / Athena was black if you look back“. Di che parla la canzone degli Alma Megretta? Che significa “Atena era nera”?
“Ma te hai visto bbuono dint’ ‘o specchio ‘e che culore tiene ‘a faccia?“, canta Raiz. Qualche anno prima, diceva che siamo tutti “figli di Annibale”. E’ un aficionado della tematica.
Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization è il titolo di un saggio di Martin Bernal del 1987, e il nome dell’infuocato dibattito che ne è scaturito: “the Black Athena controversy”. In sostanza, il tema del contendere è l’apporto africano (e semitico) alle civiltà antiche del Mediterraneo (egiziana, mesopotamica, greca, latina). C’è chi lo riscopre ed esalta, e chi lo sminuisce o lo nega. La questione è complessa e ramificata.
15. Quel che è certo: la tratta transatlantica degli schiavi (la Diaspora africana) smuove qualcosa di antico, e brucia lunghe code di paglia nell’inconscio collettivo.
Jes Grew comincia a propagarsi nel Settecento. Non è ancora epidemia: è un virus piccolo, incerto e ancora debole, ma è mutageno, capace di adattarsi.
Nel XIX secolo, il virus è ormai forte. Il contagio parte da Congo Square, New Orleans, dove gli schiavi si trovano a suonare i tamburi e danzare. Da lì si estende, decennio dopo decennio, e intanto inizia il novecento.
Negli anni Venti (la decade narrata in Mumbo Jumbo) Jes Grew investe gli States in lungo e in largo. E’ una vera emergenza culturale. In qualche modo, l’America bianca rimedia, circoscrive e contiene. Esercita pressioni sulla borghesia nera perché prenda le distanze dai “riti selvaggi”, mette in circolo versioni “ripulite” della nuova musica (l’orchestra di Paul Whiteman, nomen omen!) e per il momento riesce a “sbiancare” il primo jazz.
Nel suo Il popolo del blues, Amiri Baraka descrive quest’affannato “correre ai ripari” ogni volta che Jes Grew si manifesta, s’impossessa della musica popolare e la rende più africana nello spirito e nelle forme.
Più africana, ovvero: poliritmie, timbriche ruvide, irriducibilità alla scala temperata occidentale (quarti di tono etc.), uso percussivo di strumenti melodici (il pianoforte, le corde del contrabbasso), uso melodico di strumenti ritmici (batteria e percussioni), imitazione strumentale della voce umana (sax, tromba, chitarra blues etc.), fortissima componente di improvvisazione e composizione spontanea, atmosfera dionisiaca.
E’ una continua oscillazione tra polarità “bianche” e “nere”: nel cuore della comunità nera nasce un sottogenere di black music; l’America bianca reagisce, ne elabora e mette in circolo una versione più blanda, sonorità più lisce e ritmo più semplice. Musica poco o per niente improvvisata, riconducibile alla scala temperata di toni e semitoni, facile da trascrivere sul pentagramma; la comunità nera controreagisce e produce un nuovo sottogenere, più nero fin dal nome che gli viene dato, di solito un “africanismo” sopravvissuto tra le pieghe del Black English. “Jazz” deriva dal mandingo Jasi (wolof: Yees; temne: Jasi), che significa “esagerare”, “andare fuori di testa”, “partire per la tangente”. “Boogie” deriva dallo hausa Buga (mandingo: Bugoh), che significa “battere”, “suonare il tamburo”. “Hip” deriva dal verbo wolof Hipi, che significa “tenere gli occhi aperti”, “essere consapevole”.
Di nuovo l’America bianca reagisce, e così via.
Il processo è ambivalente: ogni volta che l’establishment sbianca la musica nera, è comunque costretto a incorporarla, e quindi ad “annerire” la musica bianca, arricchirla di nuove influenze.
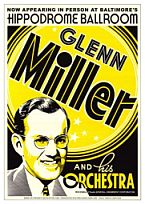 14. Negli anni Trenta, lo swing “slavato” delle grandi orchestre bianche (esito dello sbiancamento di dieci anni prima) produce due controreazioni: prima il “selvaggio” rhythm & blues (nel Midwest) e poi il “cervellotico” be-bop (a New York).
14. Negli anni Trenta, lo swing “slavato” delle grandi orchestre bianche (esito dello sbiancamento di dieci anni prima) produce due controreazioni: prima il “selvaggio” rhythm & blues (nel Midwest) e poi il “cervellotico” be-bop (a New York).
Il rhythm & blues è talmente rozzo e interno alla comunità nera da rimanere underground per vent’anni. Soltanto negli anni Cinquanta entrerà in rapporto dialettico con la musica bianca, e sarà una rivoluzione.
Il be-bop ha un’influenza immediata e irreversibile, ma nel giro di un lustro si semplifica e ammorbidisce, diventa cool jazz, West Coast jazz.
Nonostante la spinta iniziale l’abbia impressa Miles Davis, presto il cool diventa patrimonio di musicisti bianchi come Chet Baker, Gerry Mulligan, Shorty Rogers e il bianchissimo Dave Brubeck. L’uso dell’aggettivo cool, “freddo”, come sinonimo di “calmo e disteso”, pare essere di origine africana, dato che si riscontra in diverse lingue dell’Africa occidentale, es. il termine mandingo Suma. Ma presso i neri cool non significa “privo di asperità”, mentre il cool jazz bianco si fa sempre più levigato e “slavato”. Urge una nuova controreazione.
I jazzisti neri-neri rispondono con l’hard-bop, il “be-bop duro” che recupera blues, gospel e altre forme popolari.
Poi c’è una divaricazione: l’estremizzazione dei tratti neri dà vita al free jazz (Cecil Taylor usa il pianoforte come strumento percussivo prima ancora che melodico, Coltrane riempie la sua musica di africanismi, per non dire dell’Art Ensemble of Chicago etc.), mentre un ulteriore sbiancamento produce il cosiddetto “third stream” (jazz sinfonico, classicheggiante, “rispettabile”), incarnato dal Modern Jazz Quartet.
 13. Nel frattempo, a Sud e nel Midwest, il rhythm & blues si sposta dal cuore del ghetto e si avvicina al confine esterno, affascinando musicisti bianchi in cerca di emozioni. Nasce il rock’n’roll. Nello slang afroamericano, l’espressione indica l’atto sessuale.
13. Nel frattempo, a Sud e nel Midwest, il rhythm & blues si sposta dal cuore del ghetto e si avvicina al confine esterno, affascinando musicisti bianchi in cerca di emozioni. Nasce il rock’n’roll. Nello slang afroamericano, l’espressione indica l’atto sessuale.
Molti descrivono il rock’n’roll come esito di uno sbiancamento del rhythm & blues a colpi di musiche hillbilly, ma è vero anche (soprattutto) il contrario: il rhythm & blues contamina la musica bianca e la rende più nera. Lo sbiancamento del rock porta in auge soggetti come Pat Boone, ma a influenzare gli artisti del futuro sarà il rock’n’roll più vicino alle sue origini nere. I riff di Chuck Berry e Bo Diddley, gli strilli acuti e la presenza sul palco di Little Richard, Jerry Lee Lewis che suona il piano coi piedi (antic da vaudeville nero inserito in un nuovo contesto)… E’ questa la materia che sedimenta e diventa terreno fertile. Per quel viatico il rock’n’roll diventerà rock-e-basta, cioè una musica più variegata, sfaccettata e autoconsapevole. Anzi, una cultura, non soltanto una musica.
Sì, esiste anche un Jerry Lee Lewis bianco-bianco, che suona country & western melenso, ma chi se l’incula? Suona in fondo a un binario morto. Il country-rock e il country-punk dei decenni successivi batteranno altre strade, non nasceranno dal suo repertorio “nostalgico”.
Un momento, che ne è di Elvis?
A consegnare “The King” alla storia saranno il movimento pelvico (sintomo di contagio da Jes Grew) e i pezzi cantati con voce “nera” (That’s All Right, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock), non certo le ballads zuccherose né la cover di O’ sole mio. Per dirla con Antonio Tettamanti: la personalità-Pelvis conta più della personalità-Elvis.
Ogni volta che il rock si scorderà delle sue origini nere (o meglio: meticce) e guarderà soltanto alla metà europea/caucasoide del suo corredo genetico, diverrà musica pretenziosa, artificiosa, sganciata dalla realtà. Il nadir del rock secondo me? Gli album solisti di Rick Wakeman degli Yes, roba come The Six Wives of Henry VIII (1973) o Journey to the Centre of the Earth (1974). Nessuno è più riuscito a spingersi tanto in basso.
 12. Tempo al tempo. Torniamo alla dialettica individuata da Baraka, e prolunghiamola oltre il jazz e oltre i Sixties.
12. Tempo al tempo. Torniamo alla dialettica individuata da Baraka, e prolunghiamola oltre il jazz e oltre i Sixties.
C’è un rhythm & blues che non diventa rock’n’roll, rimane nero-nero ma pian piano si raffina, diventa più “orecchiabile”, si contamina con l’hard-bop, recupera gospel e spirituals. Questo r&b prende il nome di soul music, e il suo alfiere è Ray Charles.
A metà strada tra soul music e rock’n’roll si manifesta la moda del twist, che tanto colpirà lo stupratore Eldridge Cleaver rinchiuso a Folsom.
Negli anni Sessanta il soul si ingentilisce, il “suono Motown” che scala le charts riempie l’aere di voci angeliche e arrangiamenti d’archi. Tuttavia, c’è anche un soul che resta ancorato al rhythm & blues, ruvido, torrido, abrasivo: è il “suono della Stax”. Su questa base si appoggia la controreazione nera-nera, che in poco tempo produce il funk.
“Funk” è un termine afroamericano. In origine significa “tanfo”, “cattivo odore”. Come fa notare Amiri Baraka, il riferimento implicito è all’odore del nero percepito dal bianco. “Funk” è la puzza di negritudine, qui rivendicata con orgoglio.
La più intensa testimonianza del passaggio dal soul al funk sta nel doppio cd Live at the Apollo vol. II di James Brown (l’edizione Deluxe, Universal 2001). Si tratta di due esibizioni del giugno 1967. Il primo cd è tutto soul, più “canonico” e pulito, costruito sulle hit degli anni precedenti; il secondo spalanca le porte del futuro e immortala una delle più impressionanti cavalcate funk di tutti i tempi, la sequenza ininterrotta di Let Yourself Go, There Was A Time, I Feel All Right e Cold Sweat.
Nel giro di qualche anno, anche il funk subisce un parziale sbiancamento e diventa disco music, che è meno poliritmica, più squadrata, più pulita nell’esecuzione, eppure rimane abbastanza africana, molto più africana del “jazz” di Paul Whiteman negli anni Venti, dello swing anni Trenta o del cool jazz anni Cinquanta. Molto più africana dello stesso rock’n’roll.
Ma non abbastanza africana per chi vive nel ghetto. La controreazione nera-nera ricicla le frattaglie della disco e produce l’hip-hop, l’electro, la house, la techno di Detroit. Il (sempre più precario) sbiancamento di quelle musiche provocherà una nuova reazione nera-nera, che darà vita alla jungle, e via così.
Questa dialettica funziona lungo ogni direttrice della popular music: lo sbiancamento e la commercializzazione del reggae innescano la controreazione del dub, poi del raggamuffin etc.
 11. Dicevamo: al di sotto di queste oscillazioni si può leggere una tendenza lineare. Col passare degli anni, lo sbiancamento si fa meno duraturo ed efficace. Il bianco iniettato nella musica nera è sempre più sporco, è ormai beige, marroncino, fumo di londra. You can take niggers out of your neighborhood, but you can’t take the nigga out of you.
11. Dicevamo: al di sotto di queste oscillazioni si può leggere una tendenza lineare. Col passare degli anni, lo sbiancamento si fa meno duraturo ed efficace. Il bianco iniettato nella musica nera è sempre più sporco, è ormai beige, marroncino, fumo di londra. You can take niggers out of your neighborhood, but you can’t take the nigga out of you.
Difatti, gli ultimi cinquanta-sessant’anni hanno visto Jes Grew diventare pandemia irrefrenabile. Il contagio è iniziato col be-bop e il tipping point è arrivato col rock’n’roll. Eldridge Cleaver, all’inizio dei Sixties, assiste all’inizio dell’impennata: i bianchi dimenano le chiappe! In Italia Celentano (il “Molleggiato”), nell’agitarsi dà le spalle al pubblico di Sanremo, dei bar con tv, delle hall degli alberghi. Oltraggio!
Verso la fine del decennio, l’influenza nera sulla cultura americana non è più sotterranea. Jes Grew deborda in tutta la società e modifica il linguaggio del corpo in modo trasversale. E’ il periodo dell’afrocentrismo, del nazionalismo nero, del Black Power. Il pugno chiuso inguantato di nero, alzato sul podio delle Olimpiadi messicane (1968), segna il punto di non ritorno. Per la prima volta nella storia, tutti gli sguardi del mondo convergono su un role model nero.
Trent’anni dopo, i fascisti di Los Pedriches e i loro cugini USA vedono il picco di questa tendenza. Anzi, lo sentono su per il culo. Sono circondati dai wiggers e non sanno che fare.
Un bianco non può voler muoversi come un negro, checcazzo!
II. ROCK’N’ROLL NIGGER
Jimi Hendrix was a nigger.
Jesus Christ and Grandma, too.
Jackson Pollock was a nigger.
Nigger, nigger, nigger, nigger,
nigger, nigger, nigger.
– Patti Smith, Rock’n’roll Nigger, 1978
10. Abbiamo una testimonianza video dell’atterraggio degli alieni al Cincinnati Pop Festival, 13 giugno 1970. E’ sufficiente digitare “Stooges” su Youtube.
La clip dura cinque minuti e quattro secondi. Inizia con due commentatori televisivi, uno sui cinquant’anni, giacca e cravatta, tipica chioma bombata da anchorman americano. L’altro è giovane, scamiciato, capello né corto né lungo. Li cogliamo in medias res: il più vecchio, stupito, sta descrivendo il tempo fluido del festival, voragini di quarti d’ora tra un set e l’altro, il soundcheck che va per le lunghe e nessuna protesta da parte del pubblico. Le cose non vanno così nello “show business”, spiega. Nello “show business” i buchi si riempiono, finisce un set e se ne annuncia subito un altro. Quello dello “show business” è un tempo strutturato. Se fai aspettare troppo gli spettatori, quelli protestano.
Niente allusioni né malizie: l’uomo pare davvero all’oscuro della dieta lisergica e cannabinolica dei ragazzi che lo circondano. Non sa che il tempo fluido non è mai “vuoto”, che quei ragazzi nell’attesa non si annoiano.
La riflessione ad alta voce si interrompe, il tizio ha capito che la band è pronta: – I think we’ve got some action coming up now…
Fino a questo momento, non abbiamo mai visto il palco. La regia dell’epoca è povera e rozza, poco abituata a questo genere di eventi. Niente controcampi o cambi d’inquadratura, nessun indugiare su quel che fanno i musicisti quando non suonano. Se non stanno suonando, allora non stanno facendo niente, non stanno facendo rock, sono in pausa. La televisione è indietro di anni, non sa che le pause non esistono, che tutto quanto fa parte dello show e un musicista rock è tale anche quando cazzeggia, aspetta, fa il soundcheck, si scaccola o gratta il culo. La tv ragiona ancora come se alla fine di ogni atto calasse il sipario. Anni-luce da percorrere, prima dei reality show, degli inviati nel backstage, delle zoomate sul pubblico.
Finalmente l’annuncio: – Iggy and the Stooges!
Taglio.
9. E’ un salto brusco, capiamo che è trascorso qualche minuto. La band sta suonando TV Eye e Iggy è sul palco, chino in avanti. Torso nudo, guanti argentati, jeans. Guarda il pubblico e bercia nel microfono: – She got a TV eye on me… She got a TV eye… – poi prosegue inventando le parole. E’ magro come un chiodo, la pelle sembra la guaina di una lisca di pesce. Accenna qualche mossetta pelvica ma è perlopiù rigido, imbronciato, si appoggia all’asta del microfono come fosse una stampella. E’ talmente statico che una tipa del pubblico lo ritrae a matita su un grande foglio. Anche questo è un segno dei tempi: chi si sognerebbe, oggi, di mettersi a disegnare a un concerto rock, come fosse in un’aula dell’accademia di belle arti?
In quel momento (01:51 della clip) scatta qualcosa: Iggy si lancia in una danza jamesbrownesca/celentanoide fatta di spasmi velocissimi, convulsioni, ancheggiamenti. Una danza zippata, coreografia compressa in pochissimi secondi. Diagnosi rapida e incontrovertibile: Jes Grew.
Iggy si porta a bordo palco, scende tra gli spettatori e scompare. La telecamera non lo trova più. I commentatori sono sbigottiti. Schermo nero per un secondo o due.
Ritroviamo Iggy sul palco, a quattro zampe. Ora il pezzo è 1970. Dal blaterare dello speaker, capiamo che c’è stato uno stacco pubblicitario. Se l’occhio della telecamera non vede il cantante, a che pro continuare a trasmettere? Mica siamo qui per riprendere il pubblico!
Iggy ci offre il campionario di gesti per cui diverrà famoso: salta, si butta a terra, si afferra lembi di pelle, si percuote, agita le braccia, muove il pube avanti e indietro, e di nuovo si rituffa in mezzo al pubblico. Stavolta la telecamera lo cerca con insistenza, ma intorno a lui si forma un capannello.
– We seem to have lost him… – dice lo speaker.
– Ah feel awright! – si sente gridare Iggy.
– There they are! – dice lo speaker.
In quel momento, Steven Mackay parte con l’assolo di sax, ma nessuno lo inquadra. E’ tipico delle regìe dell’epoca non inquadrare il musicista che fa l’assolo.
Per gli standard odierni, il pubblico ci mette un sacco di tempo a interagire con Iggy. Noi veniamo da un quarto di secolo di cultura del mosh pit e dello stage diving, ma nel 1970 non si è ancora visto niente del genere. Immaginiamoci, quindi, lo sconcerto dei commentatori quando Iggy comincia a riemergere e si alza, si alza, si alza, in piedi sulle mani della gente.
Questo è il momento topico, quello che passerà alla leggenda. Iggy ha in mano un vaso bianco, ci ficca dentro le dita, si spalma sul petto una sostanza cremosa.
– That’s peanut butter! – dice lo speaker.
Infine, la folla ridepone Iggy a terra. Lui si porta sotto il palco e allunga una mano per essere tirato su. Il video si interrompe.
Iggy: antropomorfosi del punk e quintessenza della sua corporeità, anello di congiunzione fra tutto e tutti, è il frontman “negreggiante” di una band bluesy (qualche dubbio? Ascoltare Dirt), per giunta pencolante verso il free jazz (cfr. tutta la seconda facciata di Fun House).
 8. L’idea per queste note mi è venuta quando ho ricevuto, anni dopo aver letto l’originale, l’edizione italiana di Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk (d’ora in poi PKM), a cura di Legs McNeil e Gillian McCain. Nel giro di due-tre anni sono usciti in Italia – con enorme e colpevole ritardo – alcuni dei più importanti libri rock di sempre. Minimum Fax ha pubblicato le due antologie di scritti di Lester Bangs, Baldini Castoldi Dalai ha pubblicato PKM, Lain ha pubblicato Krautrocksampler di Julian Cope etc. L’arrivo (quasi) simultaneo di questi libri dà luogo a strani effetti, produce accostamenti che accendono idee.
8. L’idea per queste note mi è venuta quando ho ricevuto, anni dopo aver letto l’originale, l’edizione italiana di Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk (d’ora in poi PKM), a cura di Legs McNeil e Gillian McCain. Nel giro di due-tre anni sono usciti in Italia – con enorme e colpevole ritardo – alcuni dei più importanti libri rock di sempre. Minimum Fax ha pubblicato le due antologie di scritti di Lester Bangs, Baldini Castoldi Dalai ha pubblicato PKM, Lain ha pubblicato Krautrocksampler di Julian Cope etc. L’arrivo (quasi) simultaneo di questi libri dà luogo a strani effetti, produce accostamenti che accendono idee.
In PKM si cita di passaggio un episodio “increscioso”: l’uscita sul Village Voice di un lungo articolo di Lester Bangs intitolato “The White Noise Supremacists” (17 dicembre 1979). Lester metteva in guardia contro il razzismo (“di ritorno”, ma anche di andata) diffuso nella scena punk di NYC, che si ritenne messa alla gogna e reagì molto male. L’isolamento di Lester si accrebbe. Ancora oggi i superstiti non gliela perdonano, come non perdonano a Greil Marcus l’inclusione del pezzo in Psychotic Reactions and Carburetor Dung.
Il punto è: Lester aveva torto?
7. Ovunque nel mondo, è risaputo, la retorica punk fu – almeno all’inizio – una reazione all’ormai bollita retorica hippie (e prima ancora beat). Niente più sogni di empatia universale, niente “estati dell’amore”, niente “good vibes”. Quando l’establishment culturale si ammanta di fricchettonaggine, è tempo di riscoprire il disincanto, il cinismo, l’aggressività. Quando tutti ti esortano ad abbassare la guardia e “take it easy”, è tempo di irrigidirsi e formarsi una scorza sulla pelle. Se il potere ti chiede di rilassare lo sfintere, ecco il revival della ritenzione anale. Se c’è l’obbligo al “libero amore” (cioè: a contemplare passivamente il libero amore altrui, possibilmente quello delle rockstar), la resistenza è atteggiarsi da asessuati. E così via.
Solo col tempo la vecchia e la nuova retorica confluiranno in una o più sintesi. Solo il trascorrere dei decenni permetterà di vedere anche le continuità e non soltanto le rotture. Trent’anni dopo, possiamo distinguere e spiegare tutti i passaggi che dalle controculture Sixties portarono al punk. Vediamo pròdromi, precursori, mediatori, riciclaggi, eredità. I passaggi non sono lineari, ma ci sono, e abbondano i “caronti” che, ognuno a suo modo, traghettarono nel punk elementi della cultura antecedente: Patti Smith, Lenny Kaye, Kim Fowley, Rodney Bingenheimer, Mick Farren, Richard Meltzer, lo stesso Lester e tanti altri.
All’epoca, però, si enfatizzava la rottura, la discontinuità.
 6. Uno dei “vecchi temi” da cui prendere le distanze era il rapporto con la cultura nera. In epoca di disco music imperante, quindici anni dopo le riflessioni di Eldridge Cleaver sul twist, certo punk contestava esplicitamente la “negritudine dei bianchi”.
6. Uno dei “vecchi temi” da cui prendere le distanze era il rapporto con la cultura nera. In epoca di disco music imperante, quindici anni dopo le riflessioni di Eldridge Cleaver sul twist, certo punk contestava esplicitamente la “negritudine dei bianchi”.
Sentiamo John Holmstrom, co-fondatore con Legs McNeil (nel 1975) della rivista Punk:
Non eravamo razzisti. Ma, senza vergognarci, dicevamo: “Sono bianco e ne vado fiero”. Nel senso: loro sono neri e ne vanno fieri […] Ho sempre pensato: se sei nero e vuoi essere fico, allora fai la Pantera Nera, e mandi il muso bianco a fare in culo. E porti una pistola. Era quello, a sembrarmi cool. E se sei bianco, sei come noi. Mi sembrava stupido, per un bianco, cercare di comportarsi da nero. Come Lester. L’uso della parola “nigger” era il suo modo di provare a fare il nero. Voleva essere il white nigger. L’idea del “negro bianco” era di Norman Mailer, i suoi consigli per essere cool negli anni cinquanta. E noi rifiutavamo quella roba, rifiutavamo i consigli su come essere fichi risalenti agli anni cinquanta e sessanta.
Un approccio superficiale, che appiattiva sul passato prossimo un processo iniziato molto tempo prima, e aderiva all’ideologia dominante presupponendo (e ri-tracciando) linee di demarcazione netta tra “negritudine” e “bianchitudine”. Il “white nigger” (poi wigger) non è un’invenzione dei Fifties, né tantomeno è una trovata di Norman Mailer. Jes Grew è in America da secoli, è arrivato con gli schiavi, sulle navi del Middle Passage. Lo sbiancamento del punk era un (semi-inconsapevole) tentativo reazionario di “frenare il divenire”… e negare la propria identità meticcia.
Presso i punk divenne cool (non nel senso del cool jazz, ovviamente) adottare parole e retoriche razziste, politicamente – ante litteram – “scorrette”, tenendo però sgombra la via d’uscita, porta da aprire col passepartout dell’ironia. “Guarda che stavo scherzando!”. L’uso provocatorio della svastica e della galleria d’immagini nazista (non certo una novità, né tantomeno un’invenzione dei punk) mandò tutto in cortocircuito.
Lester individuò ed espose i rischi di una simile condotta, che sono poi i rischi del postmoderno, dell’ironia fine a se stessa, della fruizione culturale basata su un perenne, deresponsabilizzante detachment.
La situazione, com’è noto, sfuggì di mano. Qualche anno dopo, i Dead Kennedys ritennero doveroso scrivere e incidere Nazi Punks Fuck Off:
The real nazis run your schools
They’re coaches, businessmen and cops
In a real fourth reich you’ll be the first to go.
5. Il punk rock, come il rock in genere, non può evitare di fare i conti con le proprie origini nere. Un trito luogo comune lo descrive come sottogenere “più bianco della media”. Al suo interno i sotto-sottogeneri hardcore e Oi! sarebbero quelli a totale assenza di “negritudine”. Tutto falso.
Lo stesso Lester, nell’articolo di cui sopra, ricordava l’influenza di Chuck Berry sui riff dei Sex Pistols, le citazioni funk e jazz dei Contortions, il reggae presente nella musica di Clash, PIL, Pere Ubu e Police, le pose negroidi di Iggy…
Qui aggiungo: gli MC5 suonavano rhythm & blues elettrico e distorto ed erano il cavallo di troia musicale delle White Panthers, organizzazione che si ispirava alle Pantere Nere.
Tutta la discografia del Patti Smith Group è un omaggio alle radici nere e hipster del rock.
La musica dei Ramones è una versione più “quadrata” del garage rock alla Nuggets, che a sua volta era figlio del rhythm & blues (i Sonics erano a tutti gli effetti una band bianca di rhythm & blues, Psycho e Cinderella sono pezzi rhythm & blues etc.).
Tra le figure di spicco della prima scena punk losangelena troviamo Black Randy, vero e proprio “white nigger”, innamorato della musica nera. La sua band, i Metrosquad, è una specie di Blues Brothers Band + Germs + Gil Scott Heron.
I riff di Chuck Berry e Bo Diddley si ritrovano in molti pezzi Oi!, e persino nel rock razzista alla Skrewdriver, che infatti vive una contraddizione: solo una coda di paglia in fiamme può farti incidere una cover di Johnny B. Goode ribattezzata Johnny Joined The Klan.
Persino bands ritenute bianchissime come i Devo – la cui musica è senz’altro “cugina di primo grado” del punk rock – ammettono di aver subito l’influenza del blues deviante di Captain Beefheart, a sua volta influenzato dal jazz della “new thing” (soprattutto Albert Ayler).
Ancora: svariati musicisti hardcore-punk sono passati direttamente alla musica nera: prima di darsi al rap i Beastie Boys erano una punk band e si chiamavano The Young Aborigines. E’ successo anche in Italia: prima dei Sangue Misto, Deda era il cantante dei Rabid Duck e Neffa l’ultimo batterista dei Negazione. Prima di darsi al ragga, il Generale e Ludus Pinski erano negli I refuse it!
Infine (ma potremmo continuare): l’influenza dello ska (musica di origine afro-caraibica) ha trasformato in profondità il punk odierno. Innumerevoli le band citabili come esempi: Rancid, Voodoo Glow Skulls, Mighty Mighty Bosstones, Less Than Jake, Punkreas…
4. Torniamo su Youtube, ora. Digitiamo “MC5”, cerchiamo testimonianze video dell’altra band di Detroit ritenuta capostipite del punk.
Il video degli MC5 a Beat Club. Improvvisazione libera sul tema di Kick Out The Jams. Iggy ha il fisico del ruolo, ma è più interessante vedere come si muove Rob Tyner, che veste in modo ridicolo, ha la panza, la capigliatura (non a caso) afro, la faccia da culo, e si muove scoordinato sgraziato epilettico ebefrenico sghembo, a metà tra Jackie Wilson e Jack Nicholson che si finge rimbecillito dopo il primo elettroshock, in Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Ebbene, anche la mancanza di “grazia” di Rob Tyner, il suo muoversi dis-graziato e oggi ridicolo, superato, è quintessenzialmente punk. Di fianco a lui Wayne Kramer suona la chitarra dietro la nuca, ed è un bell’uomo, più o meno. Fred “Sonic” Smith (non ancora marito di Patti) è un bell’uomo anche lui, all’incirca. Tyner no, Tyner è orrendo, e in questo anticipa il senso punk del “sublime”, benché il suo look sia terribilmente fricchettone, un modo di agghindarsi che ai nuovi punk farà schifo.
In pratica, cos’ha di punk il modo di muoversi di Tyner?
E’ quello che chiamerei il “do-it-yourself del corpo”: non so ballare, a malapena so mettere i piedi uno davanti all’altro, ma ballo ballo ballo da capogiro, ballo ballo ballo senza respiro. Non so cantare, al massimo sbraito, ma faccio il cantante di rock’n’roll ed è in faccia che ti sbraito, vaffanculo! Sono orrendo ma faccio il sensualone, e così via.
Meravigliosamente punk: come scrisse Raul Mordenti del ’77 romano, il punk chiamerà in scena gli inetti, i mongoloidi, i troppo brutti (Shane McGowan!), gente che altrimenti non avrebbe avuto la minima possibilità di fare un cazzo. Il punk è il riscatto dello sfigato brutto come l’anno della fame. Il punk è l’anno della fame.
Più tardi, con certo hardcore muscolare, culturista e salutista epitomizzato da Henry Rollins, tutto questo bruttume si stempera, ma all’inizio è diverso.
Scrive Greil Marcus in Tracce di rossetto (1989):
Oggi… è difficile ricordarsi quanto erano brutti i primi punk. Erano brutti. Senza mediazioni… Erano grassi, anoressici, butterati, pieni di acne e cicatrici, balbettanti, sciancati e deformi, e quello che sottolineavano le loro nuove decorazioni era il fallimento già inciso sui loro volti.
Cosa spinge un “brutto senza mediazioni” a mettersi in mostra, esibirsi, scatenarsi ed esagerare (mandingo: “yasi”)?
Cosa spinge Rob Tyner a scuotersi in quel modo?
 3. C’è un tipping point della gestualità dei rocker bianchi, o meglio, c’è un tipping point dell’intera cultura di massa, ed è situato – che ve lo dico a fare? – intorno al 1968. Quell’anno, un po’ ovunque, saltano i freni inibitori.
3. C’è un tipping point della gestualità dei rocker bianchi, o meglio, c’è un tipping point dell’intera cultura di massa, ed è situato – che ve lo dico a fare? – intorno al 1968. Quell’anno, un po’ ovunque, saltano i freni inibitori.
La famigerata prima esibizione dei Rolling Stones all’Ed Sullivan Show (26 ottobre 1964), al termine della quale il conduttore chiede scusa al pubblico e promette che non ospiterà mai più la band (“I promise you, they will never be back on our show”, ma in realtà ci torneranno altre sei volte), mostra in realtà cinque musicisti calmi, “posati” per il metro di giudizio odierno. E relativamente “posati” appaiono gli Who del periodo My Generation, persino mentre distruggono gli strumenti.
Sul versante black, nello stesso periodo, c’è molta più presenza scenica e carica sensuale: James Brown, Otis Redding (la sua cover di Satisfaction è molto più torrida dell’originale), Jackie Wilson, Wilson Pickett… Persino Ray Charles, da seduto, si dimena più dei rocker bianchi ritenuti “spiritati”.
Ma già, se un nero si dimena non fa notizia, è il cane che morde l’uomo. La notizia è quando si dimena il bianco, come Elvis nel ’56, ma Elvis si è calmato da un pezzo, e i suoi eredi devono ancora farne, di strada.
Nel giro di tre-quattro anni, avremo in Iggy il prototipo del frontman-tarantolato-e-a-torso-nudo, fratello maggiore dei vari Jimmy Pursey, Darby Crash, Rudi Protrudi, Stiv Bators, Jello Biafra etc. Se Elvis era il Pithecanthropus erectus della corporeità rock… e se Mick Jagger è l’uomo di Neanderthal… e se Morrison è l’uomo di Cro-Magnon… di certo Iggy è l’Homo Sapiens Sapiens. Giusto?
2. Non del tutto, perché questa non è una faccenda interna al rock bianco, né tantomeno un processo lineare. E’ tutto molto più obliquo, accidentato, complicato, c’è una corrente parallela sotterranea che influenza fin dall’inizio l’evoluzione. Manco a dirlo, la musica nera.
Non si può non parlare di James Brown, non si può tacere la sua influenza sulla mimica di Jagger, Iggy, Tyner e tutti gli altri. E il corpo pre-glam di Little Richard, e Otis Redding, e il duck walk di Chuck Berry (che ispirerà la pantomima da palco di Angus Young)…
Il tipping point è il momento in cui i cantanti rock bianchi fanno tesoro di quel repertorio di danze ancestrali, spasmi, balli di S. Vito, fuochi di Sant’Antonio e di S. Elmo, che proviene dalla cultura nera del corpo. Lo stesso Jagger si lascia andare, sempre più esplicito nel pagare i debiti a James Brown, il suo modello di riferimento, il corpo che intende scolpire danzando.
“Muoversi come un negro”. Iggy si muove (e spesso canta) come un negro. Gli MC5 hanno nelle Black Panthers i loro role models.
Il tipping point della corporeità rock (e punk) coincide con quello dell’influenza nera nel periodo Black Power. Ho scritto “coincide”? Non è il verbo giusto, non si tratta di coincidenza, bensì di conseguenza. Il disinibirsi del corpo del rocker è l’ennesimo risultato del gioco di reazioni e controreazioni, dell’altalena tra polarità “bianca” e “nera” nella musica e nella cultura americana. L’arrivo di Iggy e dei suoi fratelli è il regalo che ci fa la pandemia Jes Grew.
Da qui in avanti, l’uso del corpo sarà più consapevole. Anche i brutti come Rob Tyner trarranno vantaggio dallo sciogliersi dei lacci. Il “do-it-yourself del corpo”: dimeno il culo anche se è grosso, dimeno i fianchi anche se sono flaccidi.
Anche il corpo punk, non solo la musica, nasce dall’incontro-scontro fra bianco e nero.
Quanto al culo strettamente inteso, non va dimenticato che “punk”, originariamente, è chi lo prende nel culo. So much per la ritenzione anale della cultura bianca!
1. Il rifiuto plateale del ’68, la polemica verso le controculture precedenti, il rigetto dei comportamenti da “white nigger”, l’apologia della componente bianca del rock… Nulla di tutto ciò è servito a sganciare il punk dalla sua matrice nera. Tuttavia, il tentativo ha seminato confusione e ambiguità su entrambe le sponde dell’Atlantico. Lester aveva ragione a metterci in guardia, Marcus ha visto giusto quando ha deciso di includere “The White Noise Supremacists” nell’antologia postuma (è un pezzo importante, e attualissimo), Holmstrom e McNeil hanno torto a rivangare quella polemica con superficialità. Quello rimane un punto nevralgico, oggi come mai prima, in tempi di globalizzazioni, nuovi meticciati, rivolte di banlieue, scontri di civiltà, cultura neo-popolare.
Ma te hai visto bbuono dint’ ‘o specchio ‘e che culore tiene ‘a faccia?
Look back, look back, punk rock was black.
 Altri interventi di Wu Ming su musica e cultura pop si trovano nella sezione POP WILL IT EATSELF del sito wumingfoundation.
Altri interventi di Wu Ming su musica e cultura pop si trovano nella sezione POP WILL IT EATSELF del sito wumingfoundation.




