di Girolamo De Michele 
qui la prima parte, qui la terza
Ci fanno ridere, sempre e comunque, i pennivendoli che eternamente dichiarano che questo o quel libro è più di un “poliziesco” (Jean-Patrick Manchette)
Il poliziesco è realistico
Torniamo alla definizione di “realismo thrilleristico”. Uno dei motivi per cui l’abuso di questa definizione lascia insoddisfatti è che non si chiarisce a quale tipo di realismo si intende far riferimento. Propongo, un po’ provocatoriamente, di considerare come modello negativo quello di Lukács: il poliziesco diventa negativo e criticabile quando aderisce ai criteri formulati da Lukács (9).
«Realismo significa riconoscimento del fatto che la creazione non si fonda […] su un principio individuale che dissolve se stesso e svanisce nel nulla, su un’espressione esasperata di ciò che è unico e irripetibile», ci dicono (parafrasando Hegel) i Saggi sul realismo. La categoria centrale del realismo è per Lukács il “tipo”, nel quale « confluiscono e si fondono tutti i momenti determinati, umanamente e socialmente essenziali, d’un periodo storico», che esso presenta «nel loro massimo sviluppo, nella piena realizzazione delle loro possibilità immanenti». In parole più semplici: la letteratura deve mostrare il “tipo” storicamente determinato, cioè l’Operaio, o il Borghese, o il Detective, quale storicamente è al massimo delle sue possibilità. Deve mostrare come da una potenza di essere si giunse all’atto, alla realizzazione ultima della forma perfetta (quella che Aristotele chiama entelechia). Deve mostrare il mondo com’è, e spiegare com’è che il mondo è diventato così com’è.
La categoria centrale del realismo è per Lukács il “tipo”, nel quale « confluiscono e si fondono tutti i momenti determinati, umanamente e socialmente essenziali, d’un periodo storico», che esso presenta «nel loro massimo sviluppo, nella piena realizzazione delle loro possibilità immanenti». In parole più semplici: la letteratura deve mostrare il “tipo” storicamente determinato, cioè l’Operaio, o il Borghese, o il Detective, quale storicamente è al massimo delle sue possibilità. Deve mostrare come da una potenza di essere si giunse all’atto, alla realizzazione ultima della forma perfetta (quella che Aristotele chiama entelechia). Deve mostrare il mondo com’è, e spiegare com’è che il mondo è diventato così com’è.
«Il realismo non è una faccenda che riguardi solamente la letteratura, è un’importante faccenda politica, filosofica e pratica», diceva Brecht. Studiare ed esprimere il mondo per come esso è significa non chiedersi come potrebbe diversamente essere; spiegare perché esso è necessariamente quello che è significa non chiedersi se avrebbe potuto essere diverso da quello che è. Significa non operare per un mondo diverso dallo stato di cose presenti, ed accettare la necessità storica. L’autore dei Saggi sul realismo è lo stesso intellettuale che, messo agli arresti domiciliari per aver partecipato alla Rivoluzione ungherese del 1956, riceveva nel suo studio János Kádár per dargli lezioni sulla Filosofia del diritto di Hegel. Le mani dei realisti lukácsiani grondano del sangue dei rivoluzionari di Kronstadt e degli anarchici spagnoli. Il lukácsismo è il togliattismo della critica letteraria, e come tale va combattuto by any means necessary.
La questione è: il romanzo poliziesco corre il rischio della tipizzazione realistica? Si. Perché il poliziesco classico — il giallo — ha un limite, messo in luce con insuperabile icasticità da Manchette: «Nel poliziesco classico (ossia il poliziesco a enigma), il delitto turba l’ordine del Diritto, che bisogna restaurare scoprendo il colpevole ed “eliminandolo” dalla scena sociale» (10). Nel giallo il conflitto di classe è inesistente, l’ordine regna sovrano, e il delitto non è che una turbativa momentanea cui il detective porrà rimedio usando lo stesso strumento del dominio: la logica deduttiva. Naturalmente anche questo limite negativo, come gli aspetti positivi del giallo, è una possibilità, non un destino. È però quantomeno possibile, se non probabile, che il giallo finisca, per dirla con Carlotto, per diventare socialdemocratico: cioè per riaffermare l’ordine esistente come “il migliore dei mondi possibili”. Nel giallo classico il detective, a dispetto delle sue particolarità e dei suoi tic, è sempre sull’orlo di diventare il Detective (il tipo del…), o il Poliziotto (il tipo del…). Ci si abitua a Miss Marple (non assomiglia alla condomina del piano di sotto o alla vecchia zia Edvige?), a Poirot (dài!, quello dell’ufficio vendite, uguale!), forse anche a Sherlock Holmes, sicuramente al noioso Ellery Queen (a Philo Vance meno, forse il suo irritante dandysmo lo tiene a distanza) ed abituandovisi li si erge a modelli, a Tipi Ideali. Che di Sherlock Holmes si ricordino raramente le “debolezze” (la cocaina, la misoginia) è in qualche modo sintomatico. L’uso stesso della logica deduttiva ci ricorda che esiste una logica che governa il mondo, che il mondo è dotato di un ordine e di un ordito buoni per il semplice fatto che esistono. Insomma, il poliziesco è un dramma (ricordate la definizione di “thriller”?), ma i drammi si concludono spesso con la reintegrazione dell’ordine infranto: la Danimarca sarà comunque governata meglio, anche se Amleto è morto, e in Scozia si pensa che Malcolm sarà un sovrano migliore di Macbeth. La catastrofe del romanzo poliziesco classico, o a enigma, o giallo è sempre provvisoria.
Col romanzo noir le cose stanno diversamente.
Il noir non è realistico, è induttivo e tragico
Diamo ancora la parola a Manchette: «Con minore evidenza [rispetto al giallo], ma in maniera assai chiara, il noir è caratterizzato dall’assenza o fiacchezza della lotta di classe, e dalla sua sostituzione con l’azione individuale (necessariamente disperata). Mentre i delinquenti e gli sfruttatori detengono il potere sociale e politico, gli altri, gli sfruttati, la massa, non sono più il soggetto della Storia, e ricoprono per lo più “ruoli secondari”, socialmente marginali […]. Qui però la lotta di classe non è assente come nel romanzo poliziesco a enigma; semplicemente, gli oppressi sono stati sconfitti e sono costretti a subire il regno del Male. Tale regno è la scena del noir, all’interno della quale e contro la quale prendono forma gli atti dell’eroe». Nel noir la catastrofe non è un incidente della storia, ma un fatto sociale. Il destino esiste, ma a posteriori: il noir ne presuppone non l’eternità, ma la sua creazione. L’hard boiled di Chandler presuppone l’avvenuta sconfitta dei movimenti sindacali americani e l’avvenuta pacificazione della società americana negli anni Trenta: che Chandler sia apparentemente impolitico, che di questo non si faccia esplicita menzione nei suoi romanzi, non deve ingannare: l’assenza della catastrofe occhieggia ovunque nella trama, come l’ordine sociale arbitrariamente imposto risalta per antifrasi dal confronto col poco di ordine che Marlowe riesce ad immettere nel mondo: «può raddrizzare qualche torto, ma non raddrizzerà mai l’iniquità complessiva di questo mondo, e lo sa; di qui la sua amarezza». Lo stesso vale per la trilogia nera di Fabio Montale di Jean-Claude Izzo (a destra), che fa i conti con la sconfitta dei movimenti degli anni ’60-’70. La Storia, nel noir, non è uno sfondo indifferente (come invece può benissimo essere nel giallo classico, che pure ci dà ottime descrizione dell’interno borghese, soprattutto in epoca vittoriana): è parte integrante dell’intreccio. A volte, soprattutto nell’ultimo decennio, il noir affronta a viso aperto la grande Storia: Ellroy, con la trilogia iniziata con American Tabloid, o De Cataldo con Romanzo criminale. Ma anche Didier Daeninckx, che con Meurtres pour mémoire ha rimesso in moto dapprima la ricerca storica, e poi l’accertamento giudiziario della verità sul massacro del 17 ottobre 1961. Ma anche in questi casi la Storia non è — non può essere — raccontata analiticamente, ma dev’essere accennata, lasciando al lettore la fatica di completare i tasselli mancanti. In un caso o nell’altro, siamo costretti a ricostruirla, questa Storia, o a rievocarla proprio quando credevamo, seduti in poltrona o in treno con in mano un romanzo “d’evasione”, di rimuoverla. Così facendo il noir aggiunge una terza ragione alle due ereditate dal giallo per legittimare la definizione di macchina pigra. Questa ragione coincide con la possibilità dell’impegno civile che è connaturata al noir:
che fa i conti con la sconfitta dei movimenti degli anni ’60-’70. La Storia, nel noir, non è uno sfondo indifferente (come invece può benissimo essere nel giallo classico, che pure ci dà ottime descrizione dell’interno borghese, soprattutto in epoca vittoriana): è parte integrante dell’intreccio. A volte, soprattutto nell’ultimo decennio, il noir affronta a viso aperto la grande Storia: Ellroy, con la trilogia iniziata con American Tabloid, o De Cataldo con Romanzo criminale. Ma anche Didier Daeninckx, che con Meurtres pour mémoire ha rimesso in moto dapprima la ricerca storica, e poi l’accertamento giudiziario della verità sul massacro del 17 ottobre 1961. Ma anche in questi casi la Storia non è — non può essere — raccontata analiticamente, ma dev’essere accennata, lasciando al lettore la fatica di completare i tasselli mancanti. In un caso o nell’altro, siamo costretti a ricostruirla, questa Storia, o a rievocarla proprio quando credevamo, seduti in poltrona o in treno con in mano un romanzo “d’evasione”, di rimuoverla. Così facendo il noir aggiunge una terza ragione alle due ereditate dal giallo per legittimare la definizione di macchina pigra. Questa ragione coincide con la possibilità dell’impegno civile che è connaturata al noir: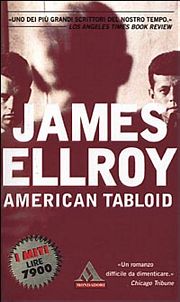 possibilità — sta poi all’autore attuarla, se ne è capace — che fa rientrare il genere a pieno titolo in quella narrativa che, secondo Salman Rushdie, ha il dovere della verità: «la narrativa dice la verità in un’epoca in cui le persone cui è demandato di dirla inventano storie. I politici, i media, coloro che creano le opinioni inventano storie. Allora è dovere dello scrittore di finzioni cominciare a dire la verità». Un’affermazione che, fatta da altri, suscita reazioni scomposte, simili a quella del (post-)fascista Landolfi, che rimproverò alla satira di informare, laddove il suo compito sarebbe solo quello di deformare (11).
possibilità — sta poi all’autore attuarla, se ne è capace — che fa rientrare il genere a pieno titolo in quella narrativa che, secondo Salman Rushdie, ha il dovere della verità: «la narrativa dice la verità in un’epoca in cui le persone cui è demandato di dirla inventano storie. I politici, i media, coloro che creano le opinioni inventano storie. Allora è dovere dello scrittore di finzioni cominciare a dire la verità». Un’affermazione che, fatta da altri, suscita reazioni scomposte, simili a quella del (post-)fascista Landolfi, che rimproverò alla satira di informare, laddove il suo compito sarebbe solo quello di deformare (11).
Il noir non è realistico perché sceglie di non aderire all’ordine esistente. Di più: il noir non mostra un ordine alternativo all’esistente, non difende una verità contro un falso. Il noir non fa altro che mostrare l’intera società nella più alta potenza del falso (Deleuze). I suoi protagonisti non sono mai Tipi Ideali: il noir immette nella trama del reale dosi massicce di individualità, di singolarità. La morte di Fabio Montale, solo nella sua barca, ne è l’esemplificazione. Anche quando i personaggi sono una folla, non si compone mai una figura generale, un simbolo universalizzabile, una metafora buone per tutte le stagioni. L’eroe del noir non usa la logica deduttiva: ad essa oppone l’induzione, che tiene conto di quante variabili casuali compongano il presunto ordine del mondo (da questo punto di vista Maigret, poliziotto induttivo per eccellenza, piccolo borghese mai a suo agio nella piccola borghesia francese, è già noir).
Il noir non è drammatico: è tragico. Nessun dio, sia esso il dio della logica o il dio-in-terra dell’ordine costituito, scende dai suoi cieli per allungare la mano e salvare l’eroe in procinto di annegare. Non è casuale che l’Izzo della trilogia marsigliese sia anche l’autore di due tragedie assolute come Il sole dei morenti e I marinai perduti, smentendo la profezia di Steiner sulla morte della tragedia.
Il noir è allegorico e paratattico
Nel noir, diversamente dal giallo classico, gli elementi indiziari sono meno importanti. La lezione di Chandler (che detestava tanto Il delitto della Rue Morgue quanto Il mastino dei Baskerville) ha segnato il prevalere dell’azione sulla catena deduttiva, sminuendo il ruolo degli oggetti. Ha depotenziato quella funzione metaforica implicita nel romanzo ad enigma. E del resto i personaggi del noir non sono, lo abbiamo già detto, metaforici. L’eroe del noir compare sempre senza adeguata introduzione, come se la sua figura fosse stata ritagliata da un’altra trama e trasposta nel libro che stiamo leggendo: basti pensare agli anarchici di La vita è uno schifo o di Nada. Il carattere non-riconciliato col mondo, la voluta estraneità all’ordine esistente, l’individualismo e il cinismo come difesa contro l’omologazione disciplinante accentuano la propensione del noir all’allegorico. Se nel giallo classico si assisteva a uno slittamento significante, col noir il significato in sé può essere fatto slittare altrove: col linguaggio del massimo teorico dell’allegoria, può essere esploso dal corso della storia — in questo opera ancora una macchina pigra. Non che l’allegoria sia propria solo del noir, o in esso si esprima al massimo grado: l’allegoria è una funzione naturale della mente libera da disciplinamenti, ed è insita nella struttura stessa del mondo dopo la fine delle “grandi narrazioni”. Il post-moderno, in generale, non fa che attingere liberamente a questa fonte, e il noir non è da meno. Ma l’allegoria è una funzione naturale della ragione critica: non c’è descrizione storicamente dettagliata (si pensi a Kubrick, o al primo Cimino) che non assuma valore allegorico, e non c’è modo di impedirlo. Il problema è solo se il narratore ne è cosciente, e se è in grado di operare piccole deviazioni nel corso della macchina allegoria. Il noir non fa eccezione, come romanzo post-moderno. Ma attenzione: il noir pre-esisteva al post-moderno. Come il romanzo gotico ha anticipato sotterraneamente la svolta anti-realistica del romanzo ottocentesco, il noir ha prefigurato il ruolo della funzione allegorica nel romanzo contemporanea. Non è un caso che Walter Benjamin abbia abbozzato (e ce ne ha lasciato gli appunti) un Kriminalromane che gli eventi gli hanno impedito di portare a compimento.
Un ulteriore elemento che fa del noir una macchina pigra è la sua forma espressiva. In genere non si indaga la scrittura di un noir: la critica si limita alla trama, come se la forma dell’espressione non fosse l’altra faccia della forma del contenuto, o come se questo assunto non valesse anche per il noir. Diversamente dal giallo classico, che tende a uno stile generalmente realistico, il noir fa un uso massiccio del linguaggio cronachistico. Importare all’interno del romanzo il linguaggio della cronaca giornalistica comporta uno slittamento della percezione temporale. La descrizione just in time della cronaca è coerente con l’oggetto-contesto del giornale, che viene fruito in tempo reale. Trasposto nel romanzo, il linguaggio giornalistico confligge con l’aspettativa del lettore, orientata sul tempo lungo della trama romanzesca, tempo lungo che il romanzo rende accettabile attraverso quei salti temporali che il romanzo demanda al lettore: non solo il salto di giorni o anni, ma anche l’omissione di brevi istanti. «L’uomo entrò nella stanza», ci viene detto senza descrivere l’apertura della porta, la rotazione della maniglia, ecc. Il noir invece indugia nel dettaglio giornalistico, sfasando il tempo del mondo narrato — che appare insopportabilmente statico — dal tempo della narrazione attesa, e creando uno stato di aspettativa che spinge il lettore ad anticipare l’azione narranda. È lo stesso meccanismo per cui in un film (diversamente dalla rappresentazione teatrale) per far salire la tensione basta far svolgere un’azione in tempo reale: l’orologio del timer che si avvicina allo 00.00 della deflagrazione, mentre l’eroe deve decidere se tagliare il filo rosso o quello blu; o, a un livello più alto, la Steadycam che segue il bambino sul triciclo nei corridoi dell’Overlook Hotel. Il paragone col cinema ci ricorda un altro elemento formale che il noir ha appreso dal cinema: il montaggio alla Dos Passos (12), che contribuisce a moltiplicare le prospettive e a rendere irrappresentabile l’unità del mondo, che dev’essere rincorsa dal lettore con la stessa fatica con la quale Sisifo spingeva il masso per vederlo poi nuovamente rotolare a valle.
Un secondo elemento, più marcato nel noir dell’ultimo ventennio, è l’uso massiccio della paratassi. Una sottrazione continua di elementi significanti, quasi che si cercasse il grado zero della significazione (come fecero gli Area nel Massacro di Brandeburgo n. 3 in sol maggiore). Notiamo che spesso questa sottrazione funziona come nella musica dub, dove lo spazio ottenuto svuotando una traccia musicale pre-esistente viene poi riempito da altri suoni: i dialoghi del noir sono volentieri ridotti all’osso, frequentemente incompiuti, e il loro completamento è affidato alla descrizione dei gesti dei parlanti. Che è la stessa tecnica narrativa che usava Dostoevskij (congiunta allo spiazzamento temporale causato dal racconto-feuilletton all’interno del giornale quotidiano), assieme all’uso del linguaggio giornalistico: a conferma della fondatezza del paragone manchettiano tra il noir e i romanzi di Dostoevskij.
La paratassi opera, a livello formale, allo stesso modo della narrazione romanzesca: costringe il lettore a riempire quei vuoti lasciati dalla scrittura, sia nel contenuto che nell’espressione. Quindi mette al lavoro, di nuovo, la capacità linguistica: capacità che è l’interfaccia della facoltà di giudizio, che subisce un nuovo stimolo. Il noir, insomma, ha la potenzialità di far pensare.
Il noir è giacobino
Eppure, anche il noir è costantemente sull’orlo dell’esaurimento. La morte del noir è come quella morte dell’arte che è annunciata da due secoli come prossima: in attesa del suo avvento, cerchiamo di capirne le ragioni. Come al solito è Manchette a darci l’imbeccata, là dove riconosce a Chandler di aver rappresentato «il momento della riconciliazione e della bellezza nella storia del genere». Ma, aggiunge subito il Maestro: la stilistica perfezione dei romanzi di Chandler (e oggi di Izzo ed Ellroy) «non deve farci dimenticare che il genere non può restare riconciliato, a rischio di diventare vuota forma». Il noir deve essere non-riconciliato: se ciò non accade, il noir scivola nello stilismo e ricade nei limiti del romanzo poliziesco classico. La serialità, ad esempio, è in genere nemica del noir (ma Malet non viola questa regola?): nella serialità l’eroe noir ridiventa Tipo, nella ripetizione l’induzione rischia di farsi deduzione, la sorpresa cede il posto all’anticipazione e questa alla conferma. L’andamento del noir è quasi ciclico: allo scadimento nella serialità o nella conciliazione stilistica succede sempre, prima o poi, l’avvento di un innovatore che rifluidifica la durata irrigidita nella ripetizione e inventa qualcosa di nuovo (o qualcosa di dimenticato che, estrapolato dal passato, opera come innovazione). Questo perché, come abbiamo sostenuto qui, il noir è una macchina pigra, e tutto ciò che di positivo può esserne detto si basa su una possibilità, non su un fatto.
Ma non ci interessano i critici controrivoluzionari che giudicano la Rivoluzione alla luce del Termidoro, preparandosi ad accogliere l’Impero e la restaurazione (contro la quale levano alte strida). Ci interessa sapere perché la Rivoluzione può germinare Termidoro, per evitare che accada. Ci interessa uscire dal Termidoro, il mese più crudele.
Soprattutto, ci interessano scrittori e libri che sfuggano alla crudeltà del presente. Quanto al resto, come diceva Brecht: torniamo ai romanzi polizieschi!
[2- continua]
(9) Ovvio che c’è di meglio: ad esempio ancora Brecht, che allarga il realismo includendovi il formalismo, l’intervento del narratore che divaga interrompendo il racconto del fatti nudi e crudi, ecc.: ma appunto, stiamo cercando un modello negativo.
(10) Jean-Patrick Manchette, Le ombre inquiete. Il giallo, il nero e gli altri colori del mistero, Cargo, 2006.
(11) La risposta di Daniele Luttazzi fu: «con buona pace di Landolfi la satira informa, deforma e fa il cazzo che le pare».
(12) Alla Dos Passos non perché il noir lo abbia appreso dall’autore di Manhattan Transfert: Dos Passos ha contribuito a rendere popolare una tecnica già faulkneriana, che l’hard boiled scopre per proprio conto là dov’è nata: nel cinema.



