 [L’articolo che segue, a firma di Gianni Clerici, è apparso a tutta pagina sul Domenicale de La Repubblica il 26 febbraio scorso.
[L’articolo che segue, a firma di Gianni Clerici, è apparso a tutta pagina sul Domenicale de La Repubblica il 26 febbraio scorso.
Il ritorno di interesse per la figura di Gian Carlo Fusco (1915-1984), scrittore e “gonzo journalist” nostrano, avventuriero e mitomane, è iniziato qualche anno fa, con la riepubblicazione dei suoi libri da parte di diversi editori (Sellerio, Laterza, Einaudi, Baldini Castoldi & Dalai…) Da lì in poi, la goccia ha scavato la pietra, l’acqua ha solcato la terra e il rivolo si è fatto fiume. C’è stato il film Gli indesiderabili di Pasquale Scimeca (con Vincent Gallo, Vincent Schiavelli e Antonio Catania nel ruolo di Fusco); c’è stata la ri-edizione del quintessenziale Duri a Marsiglia ad opera di Luigi Bernardi e Tommaso De Lorenzis (Einaudi Stile Libero Noir, 2005); infine, è da poco uscito L’incantatore, biografia scritta da Dario Biagi, qui magistralmente (non-) recensita da Clerici.
In questo meta-speciale riproponiamo:
– un’intervista a Tommaso De Lorenzis apparsa qualche mese fa nello "Speciale Fusco" su Blackmailmag
– la prefazione di Andrea Camilleri alla nuova edizione de Gli indesiderabili
– Lo streaming audio della trasmissione Fahreneit di Radio 3, che il 22 febbraio scorso ha dedicato ampio spazio a L’incantatore, intervistando l’autore Dario Biagi.]
L’UOMO CHE LOTTAVA A COLPI DI DENTIERA
Pugile dilettante, medium e fachiro, agit-prop e clochard, poi scrittore e straordinario regista di se stesso. Un libro racconta Gian Carlo Fusco e regala aneddoti sconosciuti a chi lo ha frequentato negli anni d’ oro
di Gianni Clerici
 “Ma sai cosa mi ha combinato ieri sera?”. Nella redazione del Giorno, fine anni Cinquanta, il mio collega non cessava di scuotere il capo, quasi non credesse a se stesso. “Usciamo, con il giornale in pratica chiuso, e Fusco inizia l’abituale pellegrinaggio ai night, scolandosi ad ogni fermata un grappino che ovviamente pago io. Ci facciamo il Caprice e La Porta d’oro, e, infine, sediamo ad un tavolo del Sir Anthony dove lui avvia la disamina delle entraineuses, classificandole secondo vari canoni e, soprattutto, secondo presunti talenti erotici, dei quali mima i contenuti alzandosi in piedi, e mettendosi, a un certo punto, addirittura a quattro zampe. Quando alfine, dopo un altro paio di cocktail, si sente abbastanza gasato per passare all’azione, prima che possa fermarlo punta dritto ad un tavolino presidiato da due tipi della mala, che stanno intrattenendo una delle signorine. Si inchina, per invitare la più carina. Con qualche disagio, la ragazza lo segue sulla pista, dove lui inizia un suo numero di boogie-woogie. Passano un paio di minuti, che uno di quei tipi si alza, per afferrare un gomito della entraineuse, e ricondurla al tavolo”.
“Ma sai cosa mi ha combinato ieri sera?”. Nella redazione del Giorno, fine anni Cinquanta, il mio collega non cessava di scuotere il capo, quasi non credesse a se stesso. “Usciamo, con il giornale in pratica chiuso, e Fusco inizia l’abituale pellegrinaggio ai night, scolandosi ad ogni fermata un grappino che ovviamente pago io. Ci facciamo il Caprice e La Porta d’oro, e, infine, sediamo ad un tavolo del Sir Anthony dove lui avvia la disamina delle entraineuses, classificandole secondo vari canoni e, soprattutto, secondo presunti talenti erotici, dei quali mima i contenuti alzandosi in piedi, e mettendosi, a un certo punto, addirittura a quattro zampe. Quando alfine, dopo un altro paio di cocktail, si sente abbastanza gasato per passare all’azione, prima che possa fermarlo punta dritto ad un tavolino presidiato da due tipi della mala, che stanno intrattenendo una delle signorine. Si inchina, per invitare la più carina. Con qualche disagio, la ragazza lo segue sulla pista, dove lui inizia un suo numero di boogie-woogie. Passano un paio di minuti, che uno di quei tipi si alza, per afferrare un gomito della entraineuse, e ricondurla al tavolo”.
“Solo, al centro della pista, Fusco oscilla, a metà tra il cobra e l’ubriaco. Si decide alfine a ritornare da me, che invano lo esorto alla calma. “Non mi conoscono ancora. Non conoscono Pepé le Fuscò” ripete, sinché “adesso gli faccio vedere io, a quei gangster da strapazzo”. Riparte e, mentre io trattengo il respiro, si pianta di fronte al tavolino, si porta la mano alla bocca, per estrarne la dentiera, e scagliarla in una coppa di champagne. Mentre i due, sbalorditi, non muovono muscolo, si dirige verso l’uscita, per scomparire nella notte. Dopo un minuto, sono andato a scusarmi con quei tipi, anche per recuperare la dentiera. Com’è noto è nuova, pagata dal direttore Gaetano Baldacci. Quella vecchia, in oro, l’aveva venduta in un momento di crisi: non lo sai? Ma è un’altra delle sue mille storie”.
Erano davvero mille le storie che Gian Carlo Fusco, che noi preferivamo chiamare Fusco tout court, raccontava, e scriveva, nella colonna quotidiana di quel nuovo giornale, uscito il 20 aprile del 1956. Un posto talmente divertente, da sottrarmi al mio destino di giovane petroliere, figlio unico di un concorrente dei Moratti. Era approdato lì, quel tipo straordinario, dopo vicende che definire picaresche sarebbe riduttivo eufemismo. Vicende che distribuiva generosamente ad un pubblico del quale facevo parte: pubblico diviso a metà, tra quanti ascoltavano ammirati, il direttore, l’uomo macchina Rozzoni, i giovani Settembrini, Madeo, Del Buono, e quanti rifiutavano la recita, come Gioan Brera e Giorgio Bocca.
A credergli, la sua lunga storia inizia con un “concepimento involontario” tra un padre contrammiraglio di origini beneventane e una mamma maestra comasca. “Stai attento Clerici al conformismo del tuo paese. Sei mezzo ebreo? Allora è meno grave. Mia madre lo era tutta, è di lì che viene il mio genio. I Nobel sono tutti ebrei”.
A tredici anni si segnala per la prima volta quale personaggio pubblico, offrendo un mazzetto di fiori e recitando il benvenuto in francese ad Hailè Selassié, il futuro Negus d’Etiopia. “L’avrei rivisto detronizzato, e avrebbe pianto nel riconoscermi”. Magnifica storia, destituita di ogni attendibilità.
Rinchiuso in collegio per disperazione paterna, viene ripetutamente bocciato, e non otterrà mai la maturità “ancorché abbia seguito corsi universitari nella mia Marsiglia”, affermazione onirica. Trova modo, peraltro, di sottoporre un racconto a Pirandello, ricevendone (chissà?) il suggerimento di riscriverlo. Inizia le frequentazioni della mala di La Spezia, dei bordelli, e “a Milano vinsi i campionati dilettanti dei pesi gallo, e ci rimisi tutti i denti e il naso” (affermazione smentita dallo storico Tommasi). “Costretto ad espatriare a Marsiglia per antifascismo “, ci raccontava. In realtà, ipnotizzato dalle gambe di una ballerina, tanto da tentare lui stesso una attività “di concorrente di Fred Astaire. Questo prima di aver convissuto con Corinne Luchaire” (diva cinematografica francese, che in quei tempi non aveva più di undici anni).
Dal presunto milieux di Marsiglia (a volte buttafuori, a volte maquereau, a volte pugile sotto lo pseudonimo di Charles Fiori) lo traggono i buoni uffici di famiglia, e ritorna a casa per vedersi sequestrato dalla censura fascista Biancheria, racconto definito disfattista. Mentre è in corso un giro dei night e dei casini italiani insieme al suo miglior amico e cantante, Rick Rolando detto Bubù, viene richiamato alle armi. Nel vantare alcune eroiche imprese quale telegrafista al seguito della Divisione Julia, rischiò l’aggressione da parte di un mio cugino, Pigi Tajana, che nella Julia c’era stato. Ma, per Fusco, la verità esiste in quanto racconto.
Contatti con i partigiani di Tito lo fanno condannare – a credergli – alla pena capitale per alto tradimento. Pare invece che, prigioniero dei tedeschi, sia stato effettivamente internato a Fellingbostel, presso Hannover, di dove lo trae d’impaccio una disinvolta firma per la Repubblica Sociale. Appena in Italia fugge, viene ripreso e rinchiuso a Marassi, e inscena una delle sue recite predilette. Si finge pazzo, “sino a che – racconta – dovetti subire dodici elettroshock”.
Prontamente rimessosi, fugge di nuovo, per trascorrere gli ultimi mesi di guerra quale segretario tuttofare del sommo attore Ermete Zacconi, segnalandosi anche in qualità di medium, tanto da evitare una retata con inclusa strage da parte tedesca. Nell’immediato dopoguerra si improvvisa fachiro, coadiuvato da un autentico serpente, in un night della Versilia. Ma non riuscirà a conciliare questo suo nuovo personaggio con quello diurno di agit-prop. Indignati, quei moralisti dei suoi compagni non gliela perdonano e, dopo un processo improvvisato, lo massacrano di botte, e lo espellono dal diletto Pci.
Privo di un mestiere qualsiasi, Fusco non tarda a trasformarsi in autentico barbone, ed è proprio lì che venderà la dentiera, rifinita in oro. Siamo ritornati, vedete, alla dentiera nuova, e all’inizio di quella che fu, controllabile sui suoi libri e le sue mille colonne, la fase attendibile – oh, in parte – della carriera di questo Fregoli straordinario. Di più: di questo inattendibile regista del personaggio di se stesso. Dopo le esperienze del Mondo, dell’Europeo, di Cronache, Fusco è cooptato al nuovissimo Giorno da Gaetano Baldacci, direttore anticonformista e lui stesso nottambulo. E, in quell’aprile del 1956, diviene presto il centrattacco di una redazione nella quale abbondano le star, da Bocca a Brera, dal giovanissimo Arbasino a Soldati. È lui il solo ad aprire ogni giorno una rubrica, La Colonna di Fusco, sulla quale campeggia un ritratto caricaturale e sgherro, tratteggiato da un pittore che ha in odio ogni aspetto figurativo, Roberto Crippa. Su quella colonna, novissima per le nostre terre, Fusco spazia dalle confidenze del suo portinaio, a quelle delle nobildonne con palco di famiglia alla Scala. Di molte sue incorreggibili birichinate sarà perdonato anche perché “io amo Milano. Mi piace starci, lavorarci, ancor di più divertirmici “. Saranno tre anni di gloria, ai quali il giovane Clerici ha la ventura di partecipare, divertito testimonio. Sinché il conformismo, nelle vesti dell’Eni e addirittura del ministero delle Partecipazioni statali, non interviene nel ruolo di autentico padrone, tramite un suo uomo d’ordine, il nuovo direttore Italo Pietra. Privato del suo sponsor Baldacci, Fusco spazia dal romanzo al teatro, ma nel 1962 il suo rapporto col Giorno si spezza definitivamente, in un banale casus belli su una nota spese stratosferica. Il taglio dal giornale lo costringerà ad emigrare a Roma, dove, pur lavorando per il cinema, non sarà più il Fusco degli anni d’oro.
Una sera che c’incontrammo da Poldo, il ristorante che rappresentava, di fatto, il suo ufficio, mi avrebbe preso sottobraccio per raccontarmi, sino a che il primo bar non si fosse aperto all’alba, una nuova versione della sua vita. Da quello straordinario conteur-viveur che ha avuto soltanto nel newyorchese Damon Runyon un avversario degno. Ma questi brandelli di ricordi sono piccola parte di quanto il lettore troverà in una biografia di Dario Biagi, uno troppo giovane per aver conosciuto Fusco, ma anche uno capace di offrircene un ritratto indimenticabile (L’incantatore, Avagliano Editore, 260 pagg., 14,50 euro). Si dice, ed è vero, che la nostra cronaca umana manchi di diaristi. Questa, di Biagi, è qualcosa più di una smentita.
INTERVISTA A TOMMASO DE LORENZIS
di Nino G. D’Attis e Bob Sinisi
Una conversazione cominciata al tavolino di un bar di Lecce e proseguita via e-mail. Un fiume in piena di parole intorno alla figura di Gian Carlo Fusco e alla scrittura.
Non abbiamo tagliato niente. Troppo bella, interessante, preziosa per mutilarla. Sul Blackmailmag si può fare senza problemi e siamo sicuri che apprezzerete.
Tommaso De Lorenzis (dicembre 1976) ha curato per Einaudi Stile libero Giap! Storie per attraversare il deserto (2003), antologia di scritti politico-letterari dell’atelier Wu Ming, e con Luigi Bernardi l’edizione critica di Duri a Marsiglia (2005), romanzo di Gian Carlo Fusco. Collabora a «Orizzonti», sezione culturale del quotidiano «l’Unità», e dal 2003 è redattore del magazine di narrazioni continentali «Frame. Città-Europa». Svolge attività di ricerca presso l’Istituto di Storia della Filosofia dell’Università di Bologna.
A quando risale il tuo primo incontro con Gian Carlo Fusco?
All’autunno del 2003. Al mese di ottobre, per essere precisi. Avevo appena cominciato una collaborazione con le pagine culturali de «l’Unità» e concordai con Stefania Scateni, che di quelle pagine è la responsabile, un pezzo su Marsiglia e sul suo milieu malavitoso. In quel periodo, «Orizzonti» ospitava contributi costruiti come disamine informali di archetipi e luoghi esemplari dell’Immaginario. Di solito partivamo da uno spunto d’attualità e ricostruivamo le modalità con cui un dato paradigma narrativo era stato recepito e impiegato nel cinema, in letteratura, nel fumetto, in musica, finanche nella saggistica storiografica. L’unica premessa vincolante era di non distinguere tra cultura alta e cultura bassa, e di rimbalzare continuamente dalla prima alla seconda.
Fai conto: si andava a cazzeggiare a La maledizione della prima luna, con un gigantesco Johnny Depp nella parte di capitan Jack Sparrow (primo pirata sfattone e naif della storia del cinema), e la situazione diventava lo spunto per un resoconto disinvolto sulle storie della Filibusta: dal Corsaro nero ai bellissimi saggi di Peter Partner sulle rotte corsare del Mediterraneo seicentesco.
Ricordo, per fare un altro esempio, un bel pezzo di Wu Ming 5 intorno alla figura del Guerriero d’Oriente, scritto, più meno nello stesso periodo, dopo l’uscita de L’Ultimo Samurai di Edward Zwick, con Tom Cruise nei panni di un capitano del settimo cavalleggeri (Nathan Algren) spedito in Giappone per addestrare le truppe dell’Imperatore. Insomma, era un modo ironico e autoironico per continuare a sviluppare una mitografia, leggera e accattivante, partendo da alcune manifestazioni — anche discutibili — della produzione pop.
Be’, tornando a Fusco, era successo che Einaudi Stile libero aveva pubblicato un romanzo di Clemente Tafuri intitolato Caino Lanferti. Si trattava di una storia criminale, stramba e allucinata, che aveva come sfondo gli ambienti della mala marsigliese. Volevo partire dal Lanferti. Poi seppi che la recensione era già stata commissionata e Stefania mi propose di affiancarle un generoso articolo di cornice che descrivesse una Marsiglia impastata di carta, inchiostro, vinile e celluloide.
La proposta mi piacque. Contavo di utilizzare come fonti la Trilogie de Marseille di Jean-Claude Izzo, la musica dei Massilia Sound System e i versi di Louis Brauquier, il poeta-marinaio citato spesso da Fabio Montale che è il protagonista del trittico izzoiano. Al più, ero convinto di ficcarci dentro qualche accenno al cinema francese. Immaginavo un pezzo di divulgazione che restituisse una Marsiglia metropolitana, sconvolta da feroci contrasti etnici, soffocata dalla simmetria dei fondamentalismi e devastata da orrendi ghetti di periferia.
Poi, casualmente, parlandone con un vecchio amico, mi ritrovai in mano un libro di cui ignoravo l’esistenza. Era il volume 394 dei Nuovi Coralli, un romanzo uscito a metà anni Settanta per un editore milanese (Bietti), che Einaudi aveva ripubblicato nel 1987. Si intitolava Duri a Marsiglia, e l’autore era Gian Carlo Fusco.
Alla fine, l’articolo uscì il 30 ottobre, ma in maniera del tutto diversa da come l’avevo concepito. Cominciava con una lunga descrizione del milieu del Vieux Port, ai tempi in cui l’anarchismo non era stato ancora annientato in Spagna, le mignotte si lasciavano corteggiare a suon di versi decadenti e Lucky Luciano non s’era inventato la globalizzazione dei mercati illegali. Era un mondo bollito, nato al Crepuscolo, gonfio di clichés, targato anni Trenta ma intriso di odori ottocenteschi, situato a metà strada tra mito e cronaca. Iniziai da lì per raccontare lo scivolamento di una città dalla leggenda dei Duri alla cruda durezza della Storia.
Quel libro, incontrato per caso, aveva lasciato il segno.
Come è nato il progetto di un’edizione critica del romanzo Duri a Marsiglia?
Quello è stato il passo successivo. Sono convinto che le operazioni editoriali funzionino come cocktail. Un terzo sono le idee, un terzo le relazioni di cui disponi e un terzo è culo. Se le idee vanno e vengono, e le relazioni si costruiscono, la fortuna o c’è oppure non se ne fa nulla.
Dopo aver letto Duri a Marsiglia, cominciai a divorare tutti i libri di Fusco che mi capitavano sotto mano. Va detto che Sellerio, grazie all’insostituibile lavoro di Beppe Benvenuto, ne aveva intrapreso la ristampa. Mi accorsi che Le rose del Ventennio, a mio giudizio uno dei libri più riusciti dello scrittore ligure, era stato pubblicato la prima volta — nel 1958 — proprio da Einaudi. Era possibile che l’editore fosse interessato a difendere l’altro titolo che aveva in catalogo e volesse contribuire alla rivalutazione della misconosciuta grandezza di questo figliol prodigo delle patrie lettere. Ne parlai a Luigi Bernardi, che dirigeva la Stile libero noir. Ne fu entusiasta e si preoccupò di verificare i termini del contratto di edizione. Scoprì che fino al 31 dicembre 2004 Duri a Marsiglia rimaneva a Einaudi: ecco il colpo di fortuna. Allora proponemmo la ripubblicazione ai responsabili di Stile libero.
Giudicavamo indispensabile che il romanzo fosse presentato come nuovo oggetto e non come ennesima ristampa o ulteriore edizione. L’idea era di confezionare qualcosa che mettesse le pagine di Fusco in una prospettiva inedita e le facesse interagire con i contesti storici che avevano attraversato.
Mi è capitato di scrivere che i libri non vengono mai ripubblicati, bensì pubblicati sempre e comunque per la prima volta. È il tentativo di trasferire dalla parte dell’editoria quell’impressione acutissima che coglie il lettore quando, a distanza di anni, torna su un libro. Alcuni significati hanno perso incisività, altri hanno guadagnato in efficacia. Ti ricordavi un certo tipo di lezione, e improvvisamente scopri indicazioni che avevi tralasciato. Amavi delle ambientazioni, mentre adesso ti nauseano. Certe frasi potenti ormai paiono tic; certi luoghi comuni, al contrario, risultano freschi come se fossero stati appena messi su pagina. Succede pure con la musica o i film. I libri sono organismi viventi, solo che — per loro fortuna o sfortuna, ma questo non so dirlo — vivono un’esistenza più lunga di quella concessa agli uomini.
Con Luigi, senza neppure dircelo, abbiamo condiviso la prospettiva e abbiamo voluto sancirla formalmente. In buona sostanza volevamo affiancare al romanzo una chiave di lettura. Non è l’unica — sia ben chiaro —, ma, tra le tante acquisibili, è quella che c’è parsa consona alla fase attuale. La posso riassumere con una battuta: «Lo comprerete pensando di avere tra le mani un noir, poi però provate a leggerlo come se non lo fosse: anche perché non lo è».
Quando il libro uscì per la prima volta negli anni Settanta, l’età dell’oro dei gangster romantici celebrata al cinema dai film con Jean Gabin e Lino Ventura era definitivamente passata di moda lasciando il posto a nuovi modi di raccontare l’universo criminale. Tu metti l’accento sulla “imperturbabile noncuranza” con la quale lo scrittore scelse di consegnare ai lettori dell’epoca la sua storia e fai notare subito dopo quanto, caduti i pregiudizi dei soliti pirla intellettuali, le avventure marsigliesi di Charles Fiori possano oggi andare incontro ad una migliore fortuna editoriale.
La storia di Duri a Marsiglia è la storia di un romanzo sempre e comunque fuori tempo, al di là del fatto che possa aver venduto discretamente nel catalogo Bietti o che i primi due anni dell’edizione Einaudi siano stati buoni. Nonostante ciò, continua a sfuggire, perché mobile è la materia che si agita sotto le impeccabili apparenze di un plot lieve e avventuroso.
Nel 1974, i modelli narrativi dei racconti criminali erano cambiati rispetto alle storie sulla malavita in bianco e nero scritte da Auguste Le Breton e Albert Simonin, e interpretate sul grande schermo proprio da Jean Gabin e Lino Ventura. Quegli intrecci si basavano su una sostanziale nobilitazione dei criminali. I protagonisti erano fuorilegge rispettosi di un antico codice non scritto, aristocratici sottoproletari che si consideravano gli ultimi sopravvissuti di un mondo glorioso in via d’estinzione. Erano eroi, foschi e sfortunati, per i quali le donne della borghesia potevano versare le stesse lacrime che le loro nonne avevano versato ascoltando la Bohème, o con cui le loro trisnonne avevano bagnato i fogli delle appendici domenicali. Erano intrecci che dovevano molto al feuilleton, alla mistica dei bassifondi e alla palpitante poesia della Decadenza.
A un certo punto, accade che questa sentimentale forma di marginalità sociale (probabilmente mai veramente esistita nei termini con cui si è scelto di rappresentarla), scompare innanzi all’affermarsi della modernità industriale post-bellica e alla conseguenza insorgenza di altri comportamenti illegali. Il Bandito che negli anni Settanta assalta le banche del Triangolo Industriale esprime un rifiuto del lavoro e della società di fabbrica che si declina su un’ampia gamma di comportamenti sovversivi e coinvolge settori sociali molteplici. Svaligiare un portavalori a Famagosta, rapinare una banca nel centro di Milano, sono attacchi diretti all’istituto della proprietà, ma soprattutto sono azioni che mettono in discussione il monopolio statale sui meccanismi di re-distribuzione della ricchezza. Processi di questo tipo non potevano che produrre la disgregazione delle vecchie sintesi culturali.
Così, il cinema finisce per dare sostanza alle paure di una «società legittima» che si percepisce minacciata davanti alla porta di casa, sulla soglia delle gioiellerie o all’uscita degli istituti di credito. Il Bandito dei «poliziotteschi» è generalmente una creatura indegna, feroce, abietta, cui si oppone il poliziotto che è costretto a violare la legge per difendere il diritto, o il cittadino che impugna la pistola per farsi giustizia. «Siamo arrivati a questo punto», sembrano ripetere certi «polizieschi trash».
Senti un po’ cosa si scriveva, il 16 marzo del 1971, sulla cronaca di Milano del «Corsera»: «Il parere del Procuratore Generale, dottor Domenico Riccomagno, in proposito è che le recrudescenze delle rapine, caratterizzate dall’audacia e dal disprezzo della vita umana, con la quale agiscono le nuove leve della malavita, sono i “frutti amari di quello spirito d’insofferenza, di sopraffazione e di violenza che trova, purtroppo, nel costume corrente, esaltatori e apologeti e che le innegabili ingiustizie di cui soffre la nostra società non valgono certo a giustificare”». Ti rendi conto? In realtà, i gruppi criminali in questione — le batterie come venivano chiamate all’epoca — hanno uno stile, dei riferimenti precisi, e rivelano un particolare modo di leggere il mondo. Ingaggiano sfide continue con le forze dell’ordine e sono soliti «andare ai resti», volendo citare il titolo di uno straordinario volume d’inchiesta (molto più noir o hard-boiled di tante cose che ci tocca leggere), redatto da Emilio Quadrelli per DeriveApprodi. Tutto sommato i membri delle batterie sono degli esteti dannunziani della rapina a mano armata. A guardarli con attenzione, si scopre che hanno gusto e riescono a produrre epica. Adorano gli spolverini di Sam Peckinpah e ammirano Sergio Leone.
L’opposizione tra queste due tendenze culturali — una consacrata dal cinema a vantaggio dei nuovi interessi securitari e legalitari della classe proprietaria; l’altra endemica, meravigliosamente pop e raccolta nelle liturgie dei sobborghi — determina la cancellazione dei modelli criminali usati da Gian Carlo Fusco, Fred Buscaglione, Auguste Le Breton, Albert Simonin e dallo stesso Antonio de Curtis (è impossibile dimenticare la parodia della mala in argot realizzata in Noi duri e Totò le Moko).
Posso dirti di più: il salto di paradigma narrativo attesta una vera e propria trasformazione urbanistica. I quartieri della «malavita d’una volta» sono i quartieri della città vecchia o i vicoli che lambiscono i porti. Sono gli anfratti che De André ha celebrato nelle sue canzoni. L’epopea malavitosa dei Settanta, invece, ha bisogno di altri spazi: degli svincoli autostradali, dei cavalcavia, delle tangenziali, delle strade di Quarto Oggiaro, Abbiategrasso o della Barona, tanto per dire. Ora, bisogna andare a tavoletta, mica squagliarsi nelle ombre del Panier o nella casbah di Cablanca.
È rispetto a questo processo ambivalente che si misura l’anacronismo di Gian Carlo Fusco, allorché decise, nel 1974, di pubblicare Duri a Marsiglia. Sorvolo sull’infelice tempistica della seconda edizione […]
Non so se oggi Duri a Marsiglia possa aver miglior esito editoriale. Me lo auguro, ma non conosco i dati di vendita. E se anche li conoscessi, dovrei compararli con i numeri di altre ristampe e con i risultati degli altri titoli della stessa collana. Di sicuro l’attuale centralità editoriale del «genere» permette di rendere le avventure di Charles Fiori appetibili per quegli amanti di Izzo che vogliono sapere com’era Marsiglia prima che i nazisti le rifacessero i connotati. Inoltre, spero che l’attuale rinascita di Fusco chiami a raccolta i suoi pasdaran, magari incuriositi dal fatto di trovare il romanzo in altra veste. DaM potrebbe anche stuzzicare quanti si stanno appassionando alla cosiddetta «letteratura territoriale», cioè alle narrazioni che indugiano sulle trasformazioni urbane. E poi c’è Stile libero, una collana che rappresenta il settore editoriale deputato all’innovazione di prodotto: può darsi che il pubblico di Stile libero, mobile e attento a certe operazioni anomale, gradisca un nuovo/vecchio salgarismo malavitoso. Ho augurato a Duri a Marsiglia una migliore fortuna editoriale perché giudico quest’edizione più plastica delle altre e, quindi, più adatta a incrociare differenti settori di pubblico.
Comunque, il riferimento ai pregiudizi intellettuali voleva alludere a tutta una serie di cose che vanno oltre il riscontro di mercato. Innanzitutto, la letteratura di genere non è più popolare, visto che quasi ogni grande casa editrice ha la sua bella collana noir e addirittura ne esistono di non-economiche. È una vera e propria contraddizione in termini per una letteratura che veniva definita «ferroviaria»: cioè divulgata a poco prezzo nelle edicole-librerie delle stazioni e divorata in treno, sui sedili di seconda. Non solo non c’è più un pregiudizio nei riguardi del «genere», ma dobbiamo addirittura registrare un ottimo giudizio commerciale che assume pigli dittatoriali.
C’è un secondo, nobile, pregiudizio — sostenuto ad esempio dall’Evangelisti annotatore di Manchette — che considera il noir il fronte estremo di un realismo critico di ascendenza americana.
Infine, c’è un pregiudizio in virtù del quale qualunque storia criminale diventa automaticamente — per ragioni di vendita — una storia nera.
Il «nostro» Duri a Marsiglia vorrebbe dimostrare che, pur allineando tutti i clichés di un filone, è possibile uscire dal «genere» o anticiparlo. Il noir è stato la più importante espressione di un’inquietudine che alberga nel cuore malato di un’Europa tenebrosa e che taglia trasversalmente molti campi: la letteratura d’appendice, gonfia di spietate vendette e amori non corrisposti, di torbidi passati ed equivoci presenti; le avventure picaresche dei vagabondi senza nome e dei cantastorie senza patria; lo spleen di poeti persi nelle fumerie di Soho o nei puttanai di Pigalle; l’onirismo surrealista; la ribellione solitaria dell’Anarchico stirneriano; le pulsioni inconsce che agitano la coscienza e trasformano talune vite in suicidi lunghi e premeditati.
Ecco, la terza edizione di DaM vorrebbe dimostrare — contro questi pregiudizi di diversa natura — che, senza scrivere un noir, ma con tutti gli ingredienti di un universo criminale al tramonto, con un sorriso scanzonato sulle labbra e una vaga ruga di mestizia sul volto, è possibile restituire buona parte del magma pulsante che si agita sotto la fissità di ciò che è reale e razionale.
Charles Fiori odiava l’Italia dei manigoldi cialtroni in camicia nera, perché vi si annoiava. Il buon Pilú ignorava, in nome di un amore sordo a ogni ragione, i saggi consigli che potevano frenare la sua ricerca di morte… Vorrei che fosse un libro per chi non considera la noia, il tedio, lo spleen, viziosi privilegi da ricchi e per tutti quelli di cui è stato detto: «se la sono cercata».
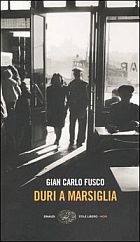 La lingua di Fusco fa scintille, come nota anche Luigi Bernardi nella postfazione del romanzo. Mi piace la descrizione della prostituta Velours: “il corpo guizzante come uno scudiscio, esalante quel sentore d’anice misto al sudore delle ascelle, oscure e profonde”.
La lingua di Fusco fa scintille, come nota anche Luigi Bernardi nella postfazione del romanzo. Mi piace la descrizione della prostituta Velours: “il corpo guizzante come uno scudiscio, esalante quel sentore d’anice misto al sudore delle ascelle, oscure e profonde”.
La questione della lingua, a Marsiglia e in Duri a Marsiglia, è problema archeologico che va disponendosi a strati.
Cominciamo col dire che il francese — quello che si impara nelle scuole — è un tenue sfondo. Nei gruppi criminali, quindi nelle famiglie del milieu, ma anche nelle vie dei quartieri, si parlavano i dialetti di provenienza: il catalano, il siciliano, il napoletano e il còrso, che però — in quanto ibrido — fa storia a sé. Più tardi, dal dopoguerra in avanti, si affermano i dialetti degli immigrati arabi. Basta andare a rivedere Izzo.
Di recente, uno studioso di Storia della Corsica, Marco Cini, ci parlava della penetrazione, a Marsiglia, dei gruppi cinesi e slavi, e dell’ulteriore arricchimento linguistico che i traffici illegali avevano determinato. Qualcosa di simile a quello che era accaduto, negli anni Trenta, al Vieux Port, con l’arrivo degli emissari di Don Salvatore Lucania e del loro inglese bastardo.
Il francese, in città, è una specie di lingua neutra, sporcata di accenti pesanti e integrata da espressioni gravide di senso. Non certo a caso, quando l’OM va a giocare in trasferta, viene accolto dal classico striscione che recita: «Benvenuti in Francia», a dimostrazione che l’extraterritorialità di Marsiglia e dei suoi costumi è riconosciuta, e odiata di conseguenza.
L’idioma cresce ulteriormente quando si frammischia con i gerghi criminali. La fonetica del marsigliese è portuale. Il lessico è stato felicemente insozzato nelle acque degli approdi mediterranei. La grammatica è dialettale. La sintassi risponde a un principio di economia: comunicare cose precise con poche frasi, tutte principali, poiché le subordinate irritano e fanno perdere tempo. Le figure predilette sono prese dal prontuario retorico malavitoso: sono metafore allusive che conviene capire al volo … Queste — come avrai capito — non sono considerazioni figlie di studi socio-linguistici, piuttosto sono un ulteriore elenco di luoghi comuni.
La lingua di Duri a Marsiglia è scoppiettante — considera Bernardi — ed ha ragione. Produce scintille che sprizzano da accostamenti muscolari e stridenti, da dialoghi meticci, da repentini cambi di registro e da sfiancanti rimbalzi lessicali. Scrivere in questa maniera, però, è molto difficile, perché occorre conservare la forza descrittiva, tenere l’efficacia dei dialoghi, fondare le situazioni in modo plausibile e poi ribaltare tutto in un gigantesco paradosso. Soprattutto: questa scrittura è un monumento al motto di spirito e al motteggiare in genere. Se te la dovessi definire correttamente, in termini di Teoria della Letteratura, direi che è un esempio del plurilinguismo di cui parlava Michail Bachtin a proposito delle epoche e dei luoghi caratterizzati dal manifestarsi di tensioni sociali centrifughe. L’anarchismo, gli esodi del contrabbando attraverso piste di montagne, le fughe clandestine nelle stive dei traghetti, la malavita come fonte di diritto extra-statuale, le pratiche resistenziali antinaziste del maquis noir compongono una tensione sociale strutturalmente centrifuga. Sarà per questo che i parigini odiano Marsiglia. Ma posso garantire che chi ama Marsiglia ricambia cordialmente il sentimento.
Ma, poi, la lingua del romanzo è realistica? Secondo me, è profondamente realistica, e quindi non può essere freddamente mimetica, bensì capace di scarti inattesi e spiazzamenti vertiginosi. È un gergo raccolto in strada, ma curato fino all’ossessione in quei laboratori della scrittura che, per Gian Carlo Fusco, erano i banconi dei night, i tavoli di redazioni fumose, le stanze di certi alberghetti versiliesi, i caffè meneghini o le osterie romane.
Ma torniamo a Velours, che in francese significa velluto (così — per inciso — dimmi chi non vorrebbe incontrare una donna che ti sussurra all’orecchio: «Mi chiamo Velluto», soffiandoti in faccia il fumo acre di una Gitane). D’accordo, lasciamo perdere…
Bisogna aver bevuto tanti pastis, occorre avere notizie certe sulle proprietà pedagogiche del cuoio, è necessario aver annusato numerose cavità femminili, ma è anche indispensabile conoscere gli arcani della scrittura per elaborare caratterizzazioni così potenti. L’attività meccanica di registrazione del parlato da sola serve a poco. Scrivere impiegando una lingua viva non significa scrivere come si parla, e tanti giovani «raga» che si misurano con la letteratura farebbero bene a ricordarlo. Tanto più se i «raga» in questione stanno per spegnere la quarantesima candelina.
In occasione della recente scomparsa di Hunter S. Thompson, l’edizione italiana di “Rolling Stone” ha dedicato un articolo a Fusco attribuendogli la paternità di quello che chiamiamo “Gonzo Journalism”. Di lui, lo scrittore Manlio Cancogni disse: «Il giornalismo era un mestiere al di sotto del suo talento». Mi sembra che tu sia d’accordo con entrambe le affermazioni, visto che nell’introduzione lo definisci “l’unico reporter gonzo della stampa italiana”.
Con la prima sono d’accordo al cento per cento, visto che nel ricordare Fusco, sempre su «l’Unità» e in occasione del ventennale della morte, scrivevo: «Divenne un mito della carta stampata e con vent’anni d’anticipo, dieci tipi di droghe in meno e dieci bicchieri di grappa in più si rivelò — a nostro avviso — l’unico vero interprete italiano di quella particolare forma di scrittura che fiorirà negli Stati Uniti sotto il nome di Gonzo Journalism». Era il 18 settembre del 2004, vent’anni e un giorno dopo la scomparsa dello scrittore e alcuni mesi prima della dipartita di Mister Gonzo. Ma non è importante. Anzi, il fatto che le idee circolino liberamente testimonia la vitalità di un’intelligenza collettiva diffusa lungo la filiera del lavoro immateriale. E gli aggettivi possessivi andrebbero banditi, insieme a tutti gli impedimenti che vincolano la diffusione dei saperi e delle conoscenze. E, comunque, può darsi che la medesima intuizione sia venuta casualmente, in tempi diversi, a persone diverse. Se fosse così, andrebbe ugualmente bene. In più, per pareggiare simpaticamente i conti, nell’«Introduzione» a DaM, recupero un passaggio che virgoletto, ma di cui non specifico la fonte secondo un impiego moderato della citazione criptica. A un certo punto sostengo che Fusco incarnò l’intuizione di Faulkner secondo la quale «la fiction migliore è di gran lunga più veritiera di qualsiasi tipo di giornalismo, e questo i giornalisti migliori l’hanno sempre saputo». Be’, quelle parole sono proprio di Sua Maestà Hunter Thompson. Le ho prese in prestito da un’intervista fattagli da Bill Borrows e pubblicata sul numero del settembre 2004 di «Rolling Stone» (edizione italiana).
Per quanto riguarda lo stile gonzo, devo rimandare alla «Prefazione» redatta da Wu Ming 1 per Guida ragionevole al frastuono più atroce (minimum fax, 2005) di Lester Bangs. Al contrario di quanto faccio io con Fusco, che abbandono piacevolmente — insieme ai suoi personaggi — nelle voluttuose atmosfere di una decadenza alcolica, WM1 riesce — anche grazie alle scelte biografiche di Lester — a uscire dal paradigma estetico-esistenziale del maledettismo. Se si accostano i testi, è possibile avere due esempi nettamente opposti di interpretazione dei clichés bohémien. Può risultare divertente.
Rispetto troppo la carta stampata, per considerare il giornalismo una gabbia della scrittura. Questo succede soltanto quando il livello dell’informazione — soprattutto il livello della cronaca giudiziaria — precipita drammaticamente. Sono convinto che se i cronisti dei giornali tornassero a scrivere dei bei pezzi, se riuscissero a farci capire cos’è davvero un campo rom o un quartiere dell’hinterland milanese o un paesino della Bassa, se componessero mosaici di situazioni e luoghi, cambierebbe molto anche per la scrittura di «genere», che ha cominciato a svolgere una sacrosanta funzione di supplenza e ha finito per occupare militarmente il campo dell’informazione e dell’approfondimento su determinati temi. Qualcuno deve spiegarmi perché, quando accade un fatto di nera, la televisione diventa la passerella su cui sfila il gotha della letteratura criminale italiana. Io farei in modo di procurarmi cronisti seri, anche perché se sei un bravo cronista e sei capace di buone intuizioni, forse — un giorno — puoi diventare uno scrittore. Ma se sei uno scrittore di successo e di giornalismo capisci poco, ci sono ottime possibilità di fare la fine del criminologo d’accatto o dell’esperto che non ne sa nulla.
Ridateci i cronisti: ne sarebbe felice anche Gian Carlo Fusco.
Intravedi nell’attuale panorama editoriale qualche autore che si avvicini, seppur lontanamente, allo stile di Fusco? Un personaggio che possieda lo stesso gusto tagliente, ironico e polemico, senza che questo scada nel becero? Penso soprattutto al Fusco de “La Colonna. La rubrica più caustica e umoristica di un’Italia che cambia”.
Tu definisci lo stile di Fusco «tagliente, ironico, polemico» ed è una definizione azzeccata. Tuttavia, proprio i bozzetti de «La colonna» riescono anche a comunicare dolcezza, equilibrio, curiosità, amore verso gli esseri umani e una gran voglia di comprendere l’Italia a partire dalle sfumature e dai dettagli che costituiscono l’essenza di un popolo, di una nazione e di una classe. Le vite malinconiche dei pugili suonati, gli ingredienti di una zuppa di pesce, i sapori di una granita palermitana, la storia di una palestra o di un cinematografo, le parabole biografiche delle puttane, un film appena trasmesso, i tic della piccola borghesia, i vizi della vecchia Italia, una vicenda di eredità o di corna, una canzone popolare, una mostra in provincia sono gli argomenti che Fusco tratta alternando sarcasmo e virile complicità. Non ci sono più penne in grado di tenere insieme pungente ironia e laica partecipazione. Siamo subissati, in letteratura, da trentenni lamentosi, ventenni trasgressivi, minorenni in calore e «spietati» scrittori di «genere» che fra poco proveranno a venderci come noir la drammatica scomparsa del loro canarino.
Il tenero amore di Fusco l’ho ritrovato nelle pagine della saggistica tondelliana, in libri come L’Abbandono o Un weekend postmoderno che stanno all’Italia degli Ottanta come «La Colonna» al Belpaese dei Cinquanta.
Per quanto riguarda la capacità di creare una letteratura mitopoietica della quotidianità, senza scivolare in monologhi segaioli o in potenti grattate d’ombelico, Emidio Clementi ha dimostrato di essere un maestro. La notte del Pratello (Fazi, 2002) è un vero e proprio Duri a Bologna anni Novanta. Giusto un po’ più allucinato.
A proposito di cronaca, invece, tengo — sulla scia delle «favole» fuschiane — certi buoni pezzi di giornalismo sportivo. Le digressioni di un ispirato Gianni Mura o alcune storie quasi fiabesche riportate da Darwin Pastorin ricalcano in parte quel tipo di lezione. Poi, su settori diversi del campo, si muovevano Gianni Brera e Osvaldo Soriano.
Un doveroso riconoscimento va tributato a Giancarlo De Cataldo e ai dialoghi degli uomini della Magliana. In Romanzo criminale, soprattutto nelle pagine iniziali, si respira un’atmosfera marsigliese trasportata sotto il cielo della Capitale. Ovviamente queste sono impressioni del tutto discutibili.
Riferendoci ancora ai giorni nostri, quale spazio si sarebbe guadagnato un Fusco Gian Carlo quarantenne nel 2005? Chi avrebbe concesso la possibilità allo scrittore di comunicare al pubblico italiano del terzo millennio? Personalmente, ritengo improbabile la televisione che da tempo ha “fatto fuori” uno dei suoi migliori amici, il mite Enzo Biagi. Ma le testate giornalistiche?
Questa domanda andrebbe rivolta a Luigi Bernardi che, peraltro, nella postfazione ha in parte risposto. Al contrario di quanto credi, sarebbe proprio la televisione a far parlare quest’ipotetico Gian Carlo Fusco quarantenne nell’Italia contemporanea. Luigi lo dice: «Avesse sbagliato a nascere di qualche decennio, il destino gli avrebbe riservato ospitate in serie nei talk-show, qualche fiction da sceneggiare, oppure un blog da compilare stancamente ogni giorno». Be’, le ospitate televisive le avrebbe organizzate un tipo che dell’altrui disagio psichico ha fatto mestiere. Mi sembra quasi di vederlo il faccione baffuto di Fusco negli studi Mediaset, e quasi la sento la voce di Maurizio Costanzo — nei soliti panni del Dracula psichiatrico de’ Porta Portese — che commenta: «Eh, sì, l’alcol è una brutta bestia e la depressione un male oscuro. Ma tu, Gian Ca’, sei forte e hai anche ripreso a lavorare». E, accanto a Fusco, ecco annuire con aria svampita Francesco Nuti, mentre lo psicologo di turno prende appunti. Costanzo è un genio, perché ha la capacità di portare chiunque in televisione, ma di non fargli dire una sola parola fuori da un copione accomodante, tutto intriso di rassicurazioni, che ripete il mantra del «se ce l’ha fatta lui, puoi farcela anche tu, spettatore depresso e sfigato». E, quindi, tante ospitate allo zoo-tv, ma niente comunicazione.
Giornali? neanche a parlarne. Non gli affiderebbero neppure il servizio sulla vecchietta scippata in centro. Ci sarebbe il rischio di capire che vita di merda ha fatto lo scippatore fino a quel momento e quant’è stronza la vecchietta proprietaria di dieci appartamenti tutti affittati a studenti o a lavoratori precari. Forse, ma non ne sono sicuro, qualche bozzetto estivo potrebbero pure pubblicarglielo, purché raccontasse le disavventure del tedesco bloccato per tre giorni su un qualsiasi cazzo di traghetto. E potrebbe essere pericoloso anche un pezzo così. Magari il tedesco ha l’amante e ha detto alla moglie che gli toccava viaggiare per lavoro pure d’estate.
«La Colonna» diventerebbe un blog perso nelle reti telematiche e fruito da un’utenza ristretta e colta. Ma visto che Fusco rimarrebbe il miglior dialoghista italiano, verrebbe di sicuro consultato da quegli scrittori che aspettano di veder tradotti in fiction i loro romanzi, anzi che prima pensano alle fiction e poi, forse — se rimane tempo — tirano fuori un romanzo.
Penso, però, che un Fusco del 2005 sgomiterebbe per partecipare a un reality show. L’attenzione per le sorti del sottoproletariato e per i declassati d’Italia lo spingerebbe su «L’isola dei famosi» a fare inchiesta. Merdasse, mes enfants!
Ed il nostro, in una nazione dove tutti scrivono e pochissimi leggono e dove, qualche tempo fa, il libro più venduto era quello delle barzellette del grande Francesco Totti, avrebbe ancora faticato “alla macchina da scrivere perché la parola scritta gli stava stretta, perché lui, indisciplinato, si struggeva dentro le regole piatte dell’articolo, nel terrore di essere un dilettante”?
Senza dubbio, sì. Fusco è uno dei migliori esempi di intellettuale che intende la scrittura come lavoro artigianale. Indipendentemente dalla condotta più o meno sana, più o meno maudit, che puoi tenere, scrivere comporta allenamento, esercizio, fatica. Più esageri di notte, più devi essere impeccabile di giorno, anche se hai dormito due ore e se la testa ti sta per scoppiare. Fusco era uno scrittore proprio perché era un artigiano impeccabile, che non lasciava niente al caso. Per questa ragione la sua prosa è così frizzante, perché riesce a confondere la ricca eccedenza della vita con l’equilibrio dello stile.
Verrebbe da pensare che l’ammirazione nutrita da Fusco per D’Annunzio sia da attribuirsi alla capacità con cui il poeta confondeva vita e letteratura o al modo di vivere un’esistenza avventurosa e fantastica. E invece, no. Guarda cosa scriveva proprio su «La Colonna» a proposito di D’Annunzio: «Fra esaltazioni e denigrazioni, entusiasmi e polemiche, nessuno finora ha indicato ai giovani una delle virtù che fanno di Gabriele un vivo esempio: l’instancabile, giornaliero attaccamento al suo lavoro, a dispetto di ogni preoccupazione e sofferenza fisica». Questo la dice lunga. Anzi, è molto probabile che oggi Fusco, per fronteggiare il dilettantismo dilagante, berrebbe qualche bottiglia di grappa in meno e faticherebbe qualche ora di più alla macchina per scrivere.
Fu anche sceneggiatore per il cinema oltre che faccia intravista nelle pellicole più disparate: da Capricci di Carmelo Bene (1969) a Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento, uscito un anno prima della morte.
Conosco poco le esperienze cinematografiche di Fusco. So che da Gli Indesiderabili è stato tratto un film e che per un certo periodo bazzicò il mondo del cinema. Mi limito a consigliare la lettura di A Roma con Bubù (Sellerio, 2005), che è un vero capolavoro. Un romanzo in cui il filone della mala vespertina si somma al tramonto della «dolce vita» e della Roma felliniana. Un grande libro sulla decadenza di più universi. Una storia capace di fare a pezzi miti diversi, opposti, senza cadere nella drammaticità, ma mantenendo viva un’ironia irresistibile che — nelle ultime venti pagine — rischia di mandare il lettore all’ospedale con la mandibola slogata.
Il cinema è — più della letteratura — il vero tempio della finzione, la sinagoga in cui la vita si confeziona come bugia e dove la verità non esiste. Fusco adorava il cinema, rispettava la fatica dei manovali eredi del sottoproletariato marsigliese, le nevrosi dei registi vittime di buffe manie artistiche e le minchiate dei produttori campioni di cialtroneria borghese. Chi ha avuto a che fare, anche di sfuggita, con un set o chi conosce quelli che ci lavorano sa che nel cinema tutto è possibile, ma niente succede per davvero. Racconta Fusco: «Nulla da fare. Tutto fermo, con notevole perdita di quattrini. Il regista fu irremovibile: sangue umano o nulla. Ogni supplica restò vana. Il direttore di produzione tornò, dopo due ore, con due donatori di sangue cinematografico reclutati in un baraccamento periferico». Questo è il cinema. Questo è Gian Carlo Fusco.
[…]
 QUELL’ITALIA: GLI INDESIDERABILI
QUELL’ITALIA: GLI INDESIDERABILI
di Andrea Camilleri
Le strade di Roma di cortei ne hanno visti migliaia, ma un corteo come quello del marzo 1955, composto da un centinaio di persone appena, sicuramente ancora non l’avevano visto, né l’avrebbero visto in seguito. I componenti erano tutti ultrasessantenni, e costituivano una fauna umana che avrebbe fatto la felicità di un disegnatore come Georg Grosz o di uno studioso come Lombroso: fronti basse, orecchie a foglia di cavolfiore, teste piene di bitorzoli, mani enormi e pelose. Una fauna della quale è possibile farsi un’idea osservando certe comparse del film Il padrino che, almeno da questo punto di vista, è attendibile. Marciando, non agitavano bandiere e non cantavano inni o canzoni. Una canzone rappresentativa della loro condizione avrebbe potuto essere quella che s’intitolava Spaghetti, pollo e insalatina e che paragonava una splendida e dispendiosa vita giovanile a Detroit alle ristrettezze e ai disagi dalla vecchiaia in patria. Ma Fred Bongusto non l’aveva ancora scritta. Perciò i manifestanti, guidati da un tale che si chiamava Frank Frigenti, si limitavano a distribuire in silenzio ai passanti foglietti ciclostilati, scritti in un italiano improbabile, nei quali erano esposte le loro richieste indirizzate alla “calorosa e generosa anima dell’Eccellentissimo Onorevole Mario Scelba, figlio prediletto di Cristo, onore e vanto della nobilissima terra di Trinacria” e all’ambasciatrice americana Claire Booth Luce, “angelo biondo che porta nel cognome suo stesso il simbolo di quel raggio di speranza che i derelitti aspettano con fiducia di figli pronti a ripagare col sangue il beneficio ricevuto“. Ma chi erano questi “derelitti”? Erano tutti ex gangster di origine italiana, perlopiù uomini-pistola, soldati semplici delle organizzazioni mafiose, bassa manovalanza, come si direbbe oggi. Nella loro vita non avevano fatto altro e altro non avrebbero saputo fare. Nel 1945 il governo degli Stati Uniti, assieme alle derrate alimentari del piano Marshall, aveva deciso di liberarsene rispedendoli in Italia con la qualifica di “indesiderabili”. Ne arrivarono, con navi diverse, quasi seicento. Avevano obbligo di residenza, vale a dire che ognuno di loro doveva andare ad abitare nel paese dov’era nato e dove oramai non aveva più parenti o amici dopo un’assenza ultraquarantennale (nella maggior parte, erano entrati clandestini negli Stati Uniti): non avevano risparmi o se l’ avevano quel poco che erano riusciti a mettere da parte sarebbe svanito in poco tempo per sopravvivere, dato che nessuno era disposto a concedere loro un qualsiasi lavoro. Chiedevano perciò un sussidio, un ricovero, un aiuto qualsiasi. Un rotocalco dell’epoca chiamò il corteo “la marcia delle tigri stanche”. Ma poteva essere concesso loro un sussidio per un lavoro (non entro in merito sulla particolarità di quel lavoro, se così si può chiamare) svolto all’estero? Forse qualche burocrate venne sollecitato a porre l’elegante questione, ma la cosa non ebbe seguito. Un frate francescano propose allora la creazione di un ospizio, come dire, esclusivo, dove gli ex gangster avrebbero trovato ospitalità e avrebbero trascorso le giornate meditando e pregando. Non se ne fece niente. Si trattava di una specie non solo non protetta, ma destinata a deliberata estinzione. “E chista è la raccanuscenza di l’amiricani pi avilli aiutati a sbarcari in Sicilia?” mi domandò un giorno uno di questi indesiderabili che avevo conosciuto. E concluse amaramente: “poviru e pazzu partii, poviru e pazzu turnai“. Il fatto è che la “raccunuscenza” ossia la riconoscenza per essere stati aiutati direttamente o indirettamente nello sbarco gli americani la dimostrarono a pochissimi mafiosi, i più potenti e i più furbi, che furono anche loro rispediti in Italia come indesiderabili, ma dotati di personali fortune (meglio non indagare come fatte) e in grado di passarsela meglio che negli Stati Uniti. Un caso esemplare è quello del famoso Lucky Luciano del quale si disse che nel giugno del 1943, un mese prima dello sbarco, fosse clandestinamente arrivato in Sicilia per preparare il terreno alle forze alleate. Di questa missione non esistono prove, all’epoca Luciano era ufficialmente nel carcere di Dannemora, condannato a trent’anni di reclusione. Ma a lui, nel 1942, si era rivolto il Naval Intelligence: “si trattava – scrive Fusco – di mettere al servizio della nazione in guerra la perfetta, capillare organizzazione portuale dell’onorata società”. Luciano, potentissimo anche tra le sbarre, accettò. L’operazione d’appoggio della mafia riuscì perfettamente, in soli due mesi i casi di sabotaggio e di passività antibellica si ridussero del settanta per cento. In “raccanuscenza” a Luciano vennero abbuonati i vent’anni di carcere che aveva ancora da scontare e a metà del febbraio 1946 venne imbarcato per l’Italia. Visse tra donne, cavalli e alberghi di lusso a Napoli, nel cui aeroporto morì nel 1962 colpito da collasso cardiaco. In definitiva però a GianCarlo Fusco – giornalista sì, ma soprattutto grande narratore – non interessano quei due o tre che, come Luciano, poterono usufruire di un trattamento particolare. La sorridente pietà di Fusco, non saprei come altrimenti definirla, lo porta a scegliere tra le tigri con meno denti e più spelacchiate. Come Frank Frigenti, appunto, che vive estorcendo qualche migliaio di lire a giornalisti creduloni o rassegnati (quest’ultimo è il caso di Fusco) con la promessa della cessione di una valigia piena di carte esplosive e documenti compromettenti o come Lu (Napoleone) Grisafi, rimpatriato nel 1952, che viene salvato dall’indigenza totale da un maresciallo dei carabinieri che gli procura un posto di guardiano in una masseria. Ma il maresciallo non riuscirà a salvarlo dalla morte: Lu Grisafi verrà ucciso nel 1955, ultimo anello di una catena di vendette iniziate trent’anni prima. A questi “indesiderabili” Fusco dedica i migliori capitoli del suo libro, essi hanno i toni e i modi di un racconto tanto magistrale da trasformare in personaggi, che paiono inventati con estro inesauribile, persone realmente esistite. Le ultime pagine sono dedicate a un “indesiderabile” che negli Stati Uniti combatté una certa mafia venendone sconfitto, il livornese Ezio Taddei. Nel 1921 era stato condannato a otto anni per partecipazione, non dimostrata, ad attentati dinamitardi. Stava per uscire dal carcere quando gli commutarono, per istigazione alla rivolta, altri cinque anni. Liberato, tentò di scappare in Svizzera. Lo sorpresero e si fece due anni di carcere, quindi fu inviato per quattro anni al confino. Nel 1938 riuscì ad arrivare in Svizzera, da qui passò in Francia e l’anno dopo s’imbarcò clandestinamente per gli Stati Uniti. Nel ’44 pubblicò a New York un libro, tradotto da Samuel Putnam, che alcuni critici definirono un romanzo straordinario. Si intitolava The Pine and the Mole, in italiano Il pino e la rufola. In quegli anni era diventato amico di Carlo Tresca, che pubblicava il giornale “Il Martello” e aspramente polemizzava con Generoso Pope, filofascista e proprietario del giornale “Il Progresso Italo-Americano”. Nel 1943 Tresca venne ammazzato a revolverate. Taddei fece una sua personale inchiesta portando alla luce un nido di vipere, un vischioso intreccio tra politica, giornalismo e mafia. Gli costò l’espulsione. Oltretutto era un anarchico e con gli anarchici (ricordate Sacco e Vanzetti?) gli Stati Uniti non hanno mai avuto molti riguardi.



