di Giuseppe Genna
 Tra i molti interventi (interventi d’arte?, interventi civili?, interventi incivili?) apparsi sul nuovo numero di Nuovi Argomenti, il 32, dedicato all’“Io so” di Pasolini in piena celebrazione della salma irrisolta di Colui Che Sapeva (in Rete ha quasi fastidiosamente debordato), scelgo di riportare sulle pagine di Carmilla il Cantico del dopoguerra nei Balcani scritto da Babsi Jones, perché vorrei ragionarci intorno. A coloro che, dei miei ragionamenti, poco o niente sanno farsi, l’invito è a scendere laddove il testo di Babsi Jones ha inizio.
Tra i molti interventi (interventi d’arte?, interventi civili?, interventi incivili?) apparsi sul nuovo numero di Nuovi Argomenti, il 32, dedicato all’“Io so” di Pasolini in piena celebrazione della salma irrisolta di Colui Che Sapeva (in Rete ha quasi fastidiosamente debordato), scelgo di riportare sulle pagine di Carmilla il Cantico del dopoguerra nei Balcani scritto da Babsi Jones, perché vorrei ragionarci intorno. A coloro che, dei miei ragionamenti, poco o niente sanno farsi, l’invito è a scendere laddove il testo di Babsi Jones ha inizio.
La guerra nei Balcani è un enorme, colossale, indecente rimosso di un decennio – i Novanta – che di per sé si è eretto sulla rimozione e sulla dissociazione collettiva, qui in Italia, perlomeno fino al manifestarsi dei Movimenti e alla complessa, dinamica storia che ne è derivata. Già in quanto traccia mnestica, dunque, il Cantico di Babsi Jones avrebbe un rilievo speciale, cioè mnemonico, contro cui fare strusciare le fronti lisce di molti italiani, persino di coloro che allora votarono e stanno per accingersi a votare a sinistra. Non è tuttavia di un simile rilievo che qui desidero parlare. Desidero qui parlare di lingua, pietà, consapevolezza e inconsapevolezza, e dello sguardo dello scrittore: il che costituisce l’eredità di quell’articolo scritto da Pasolini sul Corriere della Sera, il prestigioso quotidiano di via Solferino.
Comprese, egli, qualcosa che oggi si fatica a comprendere: che è nella lingua la nostra civiltà, e che è una civiltà in divenire (risolvendo qui il problema del supposto reazionariato pasoliniano: si trattava di una sensazione di sgradevolezza apicale, culminante in fantasmi apocalittici, ma non rivolta a un ritorno al passato, bensì tesa a un diverso divenire, a una fede assoluta nel divenire, per cui il destino non è dato fuori dell’umano: e, fermandomi un momento, mi domando quanta di questa fede io veda depositata nei libri a me contemporanei, a cominciare dai due capolavori di Don Luisito Bianchi, e soprattutto La messa dell’uomo disarmato – sì, e poi? Ho titoli in mente, ho in mente le parole ingenerose di chi di quei libri ha capito quanto voleva capire o pretendeva di capire o non ha capito niente, in perenne deviazione da un’empatia che, se non è elevata a poetica, respinge fuori dal cerchio dell’umanesimo e della letteratura in specifico). L’“Io so” è divenuto proverbiale, e a livello nazionale (ma anche l’urlo barbarico “Hàas-Fidàan-ken!” divenne poi proverbiale): fu anzitutto una mossa retorica, all’altezza di una comprensione profondissima di quali che siano i meccanismi in cui una lingua fluisce e si cristallizza. Flusso e cristallizzazione sono peraltro esattamente l’andamento linguistico (e, quindi, immaginale) di quell’intervento, che strappa dalle pagine di un quotidiano ciò che dalla carta stampata irresistibilmente è impossibile strappare: una memorabilità, una memorabilità letteraria. Lo scrittore che aveva coniato la metafora perfetta, sinteticissima e collassante su se stessa, cioè “il Palazzo”, qui estendeva quel colpo di genio linguistico, legandolo a doppio filo a un’intenzionale denuncia civile.
La letteratura non sa, lo scrittore non sa. Il crisma è sempre socratico, e mai cartesiano, quando si scrive davvero. L’imponderabilità dei cazzi propri è soltanto la superficie di un movimento tellurico che chi scrive conosce bene, sa bene avvenire sotto, in quello spazio buio e luminoso da cui provengono immagini, fantasmi, parole e segmenti ondulanti di pensamenti. Che uno scrittore affermi di sapere è un’operazione che segna un duplice destino: o l’irritazione o l’intercettazione di una verità che sta al di sotto di quel sapere sbandierato, peraltro sbandierato con una retorica tanto potente.
Cosa, dunque, sta sotto l’“Io so” di Pasolini?
Sta sotto l’impotenza, l’amore, la renitenza a continuare la propria apertura alla pietà, la visione che non giudica e sa di intervenire miracolisticamente, attraverso una trasmissione essa stessa amorosa, che è proprio la letteratura: questa grande incrinatura che avanza a ragnatela sul vetro gelido, passando per i punti che offrono minore resistenza, rinnovandosi negli stili, ma non nella generale poetica di tutta la letteratura, che è l’apertura pietosa. Io posso sapere cos’è successo, io posso additare i colpevoli, ma resta il fatto che non sono un giudice bensì uno scrittore, e che tuttavia non soltanto i giudici hanno a che vedere col giudizio e la sentenza: anche gli scrittori si formulano un giudizio intorno al mondo e sparano sentenze con una profusione che, essa medesima, o è irritante o è profondissima.
Il non saputo che Pasolini maschera con un atto di giornalismo civile è, tout court, la ragione per cui quel pezzo stampato sulla carta straccia di un quotidiano borghese diventa memorabile. Soltanto la pietà, questa dea misconosciuta che viene ben prima e ben dopo la speranza ultima dea, garantisce memorabilità: la pietà, dea laicissima che fa la lingua e che fa la letteratura.
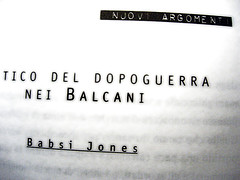 E ora vengo all’operazione che leggo nel Cantico del dopoguerra nei Balcani. Il ragionamento vale la candela, l’aggeggio fortunoso che salva la visibilità nel corso di un assedio bellico, l’unica luce plausibile di cui per sorte (e non sempre) ti trovi a disporre se sei l’assediato, se sei pressato da chi, desiderando la tua morte fisica e civile e culturale e perfino il tuo decesso nel raggio della memoria, illumina malcerta stanze in cui si consuma l’attesa e permette di vedere il crinale tremulo che abiti non sai fino a quando – non sapendo se i barbari arriveranno o meno o se sono già qui e che sarà di te, forse barbaro a tua volta. Quest’assoluta consapevolezza dell’ambiguità totale, che impedisce la censura ideologica, impedisce il sapere certificato sul mondo: l’eredità letteraria, il movimento inesausto della letteratura che si fa. Il ricorso alla candela, che è un topos celeberrimo della letteratura, come se il sego e la cera fossero consustanziali a metà della poesia e narrativa universali, è spesso un ricorso metaforico al tempo, alla brevità, alla parzialità della visione. L’immagine dunque centra il fuoco di una visione che vede e può dunque sapere, ma anche l’assenza di fuoco di una visione cieca, che non sa (eppure il cieco vede il non vedere, io al buio vedo che non vedo: è un sapere intimo e carnale, uno sguardo interno che ha sì rapporti col mondo, ma viene prima dello sguardo fisico, prima del sapere – so di non sapere, per l’appunto).
E ora vengo all’operazione che leggo nel Cantico del dopoguerra nei Balcani. Il ragionamento vale la candela, l’aggeggio fortunoso che salva la visibilità nel corso di un assedio bellico, l’unica luce plausibile di cui per sorte (e non sempre) ti trovi a disporre se sei l’assediato, se sei pressato da chi, desiderando la tua morte fisica e civile e culturale e perfino il tuo decesso nel raggio della memoria, illumina malcerta stanze in cui si consuma l’attesa e permette di vedere il crinale tremulo che abiti non sai fino a quando – non sapendo se i barbari arriveranno o meno o se sono già qui e che sarà di te, forse barbaro a tua volta. Quest’assoluta consapevolezza dell’ambiguità totale, che impedisce la censura ideologica, impedisce il sapere certificato sul mondo: l’eredità letteraria, il movimento inesausto della letteratura che si fa. Il ricorso alla candela, che è un topos celeberrimo della letteratura, come se il sego e la cera fossero consustanziali a metà della poesia e narrativa universali, è spesso un ricorso metaforico al tempo, alla brevità, alla parzialità della visione. L’immagine dunque centra il fuoco di una visione che vede e può dunque sapere, ma anche l’assenza di fuoco di una visione cieca, che non sa (eppure il cieco vede il non vedere, io al buio vedo che non vedo: è un sapere intimo e carnale, uno sguardo interno che ha sì rapporti col mondo, ma viene prima dello sguardo fisico, prima del sapere – so di non sapere, per l’appunto).
Al contrario di quanto fa Pasolini, la cantrice del Cantico del dopoguerra nei Balcani non assume su di sé questo trucco retorico, questa lingua di superficie con cui Pasolini ha incantato un Paese (peraltro dando inizio all’epoca della paranoia, l’esito più detestabile che matura un decennio dopo la sua morte nella landa in cui aveva vissuto, e rendendosi omogeneo, nella sua profezia di morte linguistica e civile, all’espropriazione della lingua che è stata messa in atto in trent’anni e a cui la letteratura soltanto da poco sta potentemente rispondendo: passando a una lingua e a una retorica più profonde).
Non è un “Io so” a ritmare, come un rosario di perle parlate, ma un “Loro sanno” o “non sanno” o, vertiginosamente, “Che cosa sanno, quello che sanno sanno, e non è niente”. Sono gli agenti dello sterminio a sapere, sono i plausibili protettori a sapere e a fare finta di non sapere, ed è la vecchia vittima, Zivorad Velikinac, a non sapere (questo nome di cui veniamo a sapere).
Tutti sanno e non sanno. E chi sa questo? Dov’è la scrittrice? E’, lei, lo sguardo che sa chi e cosa sa, e chi e cosa non sa. Questo rimbalzo è prodigioso. Questa sostanza non è onniscienza, poiché l’onniscienza conosce la pietà e conoscere la pietà prelude a un uso della pietà, a un’algebra della pietà. Babsi Jones oppone il cantico (genere di letteratura sacra, quindi artificio retorico, condensazione letteraria in ritmi precisi in cui modellare il flusso di lingua) all’emissione della sentenza – la sentenza che nasce dal sapere e perfino dalla confusione che fa ribollire la febbre nel corpo smunto di Zivorad Velikinac, morto per tutti coloro che non sanno, simbolo che, cantato, è simbolo di tutti gli altri corpi (altra condensazione della lingua in cristallizzazione letteraria – altra figura, la figura umana che diviene la figura di una totalità, sia pur essa una minoranza).
Questa opposizione tra cantico ed enunciazione, che è non casualmente opposizione di poesia e prosa, è soltanto un segnale di questo formidabile mandala di parole, che pone al proprio centro il vuoto: è al centro perfetto la coppia di aggettivi “innominato e incosciente”, come se i nomi e le forme trasformassero scelleratamente la corrente di pietà umana in figurazioni precise e calcolabili del sapere e del non sapere, cioè in cose mentali. Una vita vissuta secondo i canoni della pietà (di cui la cristianità, evidentemente, non detiene il monopolio, così come non lo detengono le Nazioni Unite) è ciò che sbalza da questo oggetto poetico e narrativo. Pietà che permette di riassumere, in una memoria che ha perso ogni saccenza, gesti che appartengono a un altro ordine dell’umano, così profondo e arcaico, così nutriente e sempre presente nella storia tramite le storie, la narrazione e il canto delle storie: i gesti pietosi del mito, il caro Anchise, il passo incerto del poeta cieco (Omero, da ò mè oròn, colui che non vede), il cieco che sa a partire appunto non dal sapere, bensì da un altro ordine dell’umano, tanto sbigottito, tanto vasto che il suo sguardo precede lo sguardo fisico e vede ciò che lo sguardo fisico vede e non vede, e accetta senza formulazione, emettendo radiofrequenze di un’umanità scevra dalle forme conosciute e riproducibili in retoriche.
Il Cantico di Babsi Jones è per me composto secondo modulazioni della sostanza radiante e non pronunciata che rende memorabile l’“Io so” di Pasolini, che soltanto per questa radianza dichiara inutile orpello il possesso delle prove. Altrimenti avremmo avuto un elzeviro di Montanelli e certo Nuovi Argomenti non può permettersi di fare variare i suoi scrittori su un elzeviro di Montanelli.
"Cantico del dopoguerra nei Balcani"
Babsi Jones/Nuovi Argomenti #32
Tutti i popoli erano stanchi di conflitti, tutti desideravano solo la pace!
“Sì”, commentò Jurat in tono rassegnato, “tutti sono stanchi, tranne i disgraziati. E i disgraziati siamo noi.”
Milos Crnjanski, “Migrazioni”
Quello che loro sanno, quando lo sanno, è quello che basta a governare queste contrade di relitti e di rovine che ancora si ostinano a non finire in briciole, ai margini di una città che ha due nomi in due alfabeti differenti; quello che sanno sanno, di una regione che nei carteggi delle amministrazioni postbelliche e sulle carte geografiche dell’Impero a stento ha un nome; quello che loro sanno, se lo sanno, è quel che basta a sorvegliare questi villaggi intorno ai quali i carrarmati di presidio vanno tracciando solchi sempre più profondi; sono venuti vestiti da soldati, sono venuti a grandi ondate di metallo: hanno distribuito ricche porzioni di pace contraffatta, di pace che somiglia a una galera; un denso strato di colla è colato e si è seccato sopra a noi venti vivi e vegetanti, a noi scampati scappati fra le granate dentro il mandala delle migrazioni, poi recintati in rioni blindati come lebbrosi dentro ai lazzaretti, come mucche, guardati a vista come se dagli zigomi sporgenti, dalle labbra stracciate come carta, dalle mani ghiacciate e tese per reclamare acqua potabile e insulina si potesse riconoscere il marchio dell’etnia di minoranza.
Quello che sanno, lo sanno per incombenza burocratica: hanno portato una pace catramosa e opaca dentro la quale giacciono i sommersi e gli scordati, e i morti di morte violenta e spaventosa che fanno vermi dentro le cantine. Quello che loro sanno, se lo sanno, è quello che serve a controllare quattro villaggi in croce di catapecchie e ovili: un materasso squarciato che troneggia in un cortile, a margine della carreggiata che comincia a somigliare a un acquitrino c’è un cesso rotto, e quello che resta di una modesta chiesa data alle fiamme, fra i colori immondi e trionfali delle bandiere altrui. Posti di blocco a Urosevac/Ferizaj, che segmentano una terra di nessuno: capolinea Balcani, si scende, si comincia a scavare, si crepa.
Che cosa sanno, loro, della città in cui nude centrali elettriche si fanno spazio fra i caseggiati dell’edilizia socialista, e dai balconi ciondolano padelle paraboliche, lenzuola a fiori, cavi elettrici; che cosa sanno dei pneumatici che vanno in fumo e a respirarlo si contraggono i bronchi in uno spasmo, degli sciancati che strusciano le stampelle in direzione degli urli acuminati dei ragazzini che annunciano l’arrivo dei trattori o dei carretti carichi di capre sonnolente; che cosa sanno degli stormi di corvi neri che hanno preso il posto delle rondini, del raglio di asino inascoltato fra le carcasse dei blindati di un esercito fuggito il giorno di un armistizio imposto con le bombe; e cosa sanno dei ghetti, che stanno dando vita a un territorio a parte, dimenticato da ogni dio e dalle nazioni troppo unite per inginocchiarsi a osservare lo squallore; che cosa sanno dei ghetti, per le cui strade melmose i reduci si muovono in drappelli rasentando i muri sbreccati dai proiettili e anneriti dal fuoco, e trasportando ceste colme di panni lerci e piccole sedie rubate negli asili dove i bambini della razza infetta non hanno più il diritto di sedere; e sbarre di acciaio, e lastre di compensato, portano avanti e indietro: quello che torna utile per ampliare i confini dell’oscena bidonville in cui si attende un Godot che consegni il pane, i secchi di acqua, e qualche mela rossa già ammaccata che lascia in bocca, a morderla, l’acido aroma della compassione umanitaria.
Che cosa sanno, quello che sanno sanno, e non è niente: è quello che basta e avanza per far rapporto ai gran congressi, per calcolare a spanne la sciagura che hanno chiamato ordine ristabilito; che cosa sanno e a cosa serve quello che sanno, fatto di cifre, di note a margine e di conteggi: i nomi degli appestati in inferiorità numerica in gabbia in una lista che vista da vicino sembra soltanto un formicaio di sbieche lettere a casaccio, segni diacritici sempre meno esatti, e qualche riga nera tirata al volo in un ufficio a Pristina per segnalare i decessi più recenti.
Quello che non sapeva è che sarebbe stato solo un cadavere fra i tanti, un bianco morto dentro un obitorio a Mitrovica, disteso a prendere aria in un mattino di sole pallido e di cielo piatto sul duro zinco di un lettino della civica morgue; cos’hanno scarabocchiato nel verbale che passa di mano in mano e di tasca in tasca e si impiastriccia di impronte digitali occidentali, di timbri infradiciati in un inchiostro unto come olio, un documento che va a Bruxelles e all’Aja, a impinguare archivi impolverati che nessun giudice avrà la voglia di sfogliare per domandarsi cosa succede a Urosevac/Ferizaj; che cosa scrivono sapendo di non sapere quello che io so, e che le vecchie intorno al corpo scarnificato sanno, e tengono in serbo come un segreto inutile: "cachessia senile, catabolismo, massiva disidratazione, naturalmente deceduto": morto di fame senza sapere come; "cachessia senile, catabolismo, massiva disidratazione, naturalmente deceduto": fin dove sono giunte le parole che lui di certo non sapeva articolare nella sua lingua secca di contadino a cui la terra è stata confiscata; quelle parole che questi forestieri in uniforme linda e inamidata e in doppiopetto sanno impugnare come sottili bisturi per non dover parlare al mondo di un posto ormai fottuto che ha l’odore igienico delle persecuzioni, di un fallimento chiamato Kosovo e Metohija dove un cristiano il diciassette ottobre duemilatre cade nel mucchio, crepa di fame e sete, innominato e incosciente: neppure il nome, sanno, e lo domandano a chi viene dalla enclave a vedere l’uomo rinsecchito e spoglio, con quelle chiazze porpora e vermiglio che macchiano il bacino e le ginocchia così in rilievo che pare che ora esplodano, e sono viola le coste e i malleoli, e quella bocca spalancata in un guaito muto, e le lunghe unghie delle mani artritiche; nemmeno il nome sanno, Zivorad Velikinac, morto di carestia e di omissione di soccorso, febbricitante, frastornato, scordato chiuso dentro una stamberga da quarantaquattro giorni lunghi e lenti ad aspettare che qualcuno lo chiamasse: Zivorad, cosa sapeva e cosa non sapeva della sua mediocre e solita bronchite, imbrattato dalla sua stessa merda sciolta e verdastra, sfinito a letto senza sapersi sollevare; la sua esistenza sconosciuta è attaccata a un filo e nelle orecchie ode il fragore di milioni di forbici affilate, e il bruciore sale a spirale nei polpacci; e non sapeva come venirne fuori, osare e uscire in strada dove scorrazzano i teppisti del terrore un tempo guerriglieri, quindi ribattezzati forza di controllo, e consacrati e armati e legittimati dalla NATO e dalle narcomafie; non lo sapeva, che era giunto il turno di spegnersi di sete e fame, obnubilato e allungato fra le lenzuola sudice, per non dover morire di sprangate e sassi scagliati sulla testa vuota, cadendo in una pozzanghera di sangue concentrato sulla sua terra arata, vegliata, custodita e poi perduta al poker delle etnie.
Quello che non sapeva e non avrebbe mai saputo è che il respiro delle donne in nero, strette fra loro e riunite in un cantone di una sbiancata saletta mortuaria, sarebbe riecheggiato come un risucchio, il fiato opprimente delle bestie braccate che cercano scampo in una guerra che non è più la loro, che è diventata a tutti i costi e per decreto una tregua pacifica e permanente e giusta e santa, in cui si spargono all’alba nei campi minati i semi di preghiere inefficaci e di bestemmie vane, e dai bastioni delle baraccopoli si attendono i militari umanitari, incompetenti figli di Godot, che forse porteranno pane raffermo, acqua potabile, insulina, piccole mele aspre; quello che lui sapeva dei miserabili e dei balordi che hanno tenuto duro sopra le barricate, che hanno accudito i ponti e i monasteri bizantini come bambini, e rinforzato gli argini dei fiumi pur di difendere quattro contrade in croce, pur di tenere in serbo macerie di ovili e stalle, è terminato in una riga nera tirata al volo in un ufficio a Pristina, per avvertire Bruxelles e l’Aja del suo trapasso senza ragione e senza conoscenza.
![]() Per Unità di crisi Babsi Jones ha preparato alcuni frammenti .mp3: testo + voce.
Per Unità di crisi Babsi Jones ha preparato alcuni frammenti .mp3: testo + voce.
* * *
Da, per, su Nuovi Argomenti 32 in rete potete leggere:
- Helena Janeczek [Umma di Gallarate]
- Roberto Saviano [Io so e ho le prove]
- Davide Bregola [Se le porte della percezione fossero ripulite tutte le cose sembrerebbero infinite]
- Matteo Fantuzzi [Ode al Lexotan]




