di Valerio Evangelisti
(Da AA.VV., Dieci decimi. Sguardi a ritroso sulla nostra letteratura, ed. Holden Maps / Scuola Holden, 2003. La presente stesura ha subito alcune modifiche.)
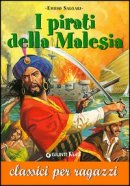
Centinaia di Salgari
Emilio Salgari gode oggi di ampio interesse da parte della critica. Si tratta però, nella maggior parte dei casi, di un interesse tra il bonario e il divertito, teso a inquadrare il «fenomeno Salgari» – che si impone come tale in virtù della sua capacità di parlare a intere generazioni, spesso condizionandone l’immaginario – in una nicchia ai margini della storia della letteratura italiana. Magari si destruttura la prosa salgariana, si cercano i meccanismi della sua «magia», ma quasi sempre si approda nell’individuarne il cuore nel colorito e nel pittoresco.
Secondo me c’è ben di più, ed è la connessione stretta tra l’opera di Salgari e l’intero universo della narrativa popolare, con la sua capacità di destare emozioni durature e di riproporle a dispetto del tempo trascorso.
Si consideri un dato che non trova facili riscontri nemmeno nell’ambito del feuilleton: accanto alle opere lasciateci dall’autore, un centinaio, ce n’è una cinquantina di apocrife, di scritte da presunti collaboratori postumi, di firmate da eredi con lo stesso cognome o da imitatori ansiosi di essere confusi con il maestro. Un simile destino, comune nel mondo televisivo (si pensi a «Star Trek»), è toccato in letteratura a Conan Doyle e a pochissimi altri. Perché è significativo? Perché indica la richiesta massiccia, imposta dai lettori, che l’universo salgariano si perpetui. Salvo poi scoprire che nessuno dei continuatori più o meno legittimi di Salgari possiede il suo tocco. Ma qual è questo «tocco»? Rispondervi è importante. Significa affondare il bisturi nelle viscere della narrativa alla ricerca di un elemento impalpabile come il sogno. Perché di questo si tratta, quando parlo di perpetuazione dell’universo salgariano: della prosecuzione di un sogno. E può legittimamente essere espunto dalla Letteratura con la maiuscola uno scrittore capace di tale forza onirica? Sì, può esserlo, ma per me è un errore.
I pirati della Malesia. Un romanzo coacervo
I pirati della Malesia è il più tipico romanzo salgariano, quello che condensa gli elementi di tutti gli altri. Non è affatto il migliore. Quest’ultima medaglia la riserverei a un altro romanzo del ciclo di Sandokan: il cupo, grandioso, a tratti malinconico Il Re del mare. Costruzione però solitaria quanto la potente nave da guerra che gli dà nome, e che sarà seguita da una serie di avventure banali e ripetitive, di volume in volume grondanti stanchezza.
Invece I pirati della Malesia è il culmine e al tempo stesso l’avvio di una produzione seriale di cui fornisce già tutti gli elementi: un Sandokan che più romantico non si può, uno Yanez che più ironico non si può (divertentissime, a metà libro, le sue vicissitudini in una locanda cinese), una vergine innamorata e infelice (Marianna Guillonk) convenientemente impazzita alla maniera di Eugène Sue e di Ponson du Terrail, un servitore devoto e astuto (Kammamuri), un attor giovane (Tremal-Naik), un cattivo che è così intelligente da non essere nemmeno tanto cattivo (il rajah di Sarawack), un manipolo di eroi di media stazza fedeli al loro signore (Sambigliong, Tanauduriam, altri pirati). E poi battaglie terrestri e navali, discettazioni su flora e fauna esotiche degne del National Geographic Channel, infiltrazioni in campo nemico alla maniera di Ulisse, fino a una conclusione frettolosissima, di tre pagine appena, che rivela come tutto il materiale accumulato stia per far crollare l’impalcatura.
Ci sono tutti gli elementi, insomma, per dare forma a uno dei peggiori romanzi che siano mai stati scritti. Invece Salgari non solo tiene assieme il mostruoso coacervo, ma crea l’opera fondatrice di un mito pertinace e ancora vivo, e senza ricorrere ad astuzie particolari. Capire come fa è il vero «mistero della jungla nera».
La narrazione «theta»
Secondo alcuni neuropsichiatri, esisterebbe uno stato di «veglia sognante» (detta «attività theta», dal tipo di onde elettriche che attraversano il lobo temporale) in cui figure immaginarie acquistano l’evidenza di cose reali. Ciò accade, per esempio, in caso di narrazioni ripetute, formulate su un medesimo schema. Ho idea che ciò avvenga con Salgari e con altri maestri della narrativa popolare. Non che siano ripetitivi (Salgari a volte lo è, ma altre volte è originalissimo), solo che pescano, più o meno consapevolmente, in forme di narrazione più antiche, e talora ancestrali. Rendendo così il lettore non solo immediatamente familiare con la materia, ma anche straordinariamente aperto a una suggestione che, legandosi ad altre già presenti nella sua mente, penetrerà a fondo nella sua fantasia e, forse, lo condizionerà in futuro.
Cerco di spiegarmi con un esempio. Dumas, ne I tre moschettieri, ci presenta quattro tipi umani: D’Artagnan, il romantico coraggioso; Porthos, l’ingenuo irruento; Aramis, il sottile e tortuoso; Athos, il nobile custode dei valori. Passiamo a «Star Trek», primo ciclo. Kirk è D’Artagnan. Il dottor McCoy è nel contempo Athos e Porthos. Spock è indubbiamente Aramis. Veniamo ora a Salgari. Sandokan è D’Artagnan e Athos (in parte), Yanez è Aramis e Porthos. Lo so, manca un pezzo di Athos, ma quello lo ritroviamo in un diverso contesto: il ciclo del Corsaro Nero. Dove il Corsaro, Emilio di Ventimiglia, è indubbiamente una replica di Athos con un pezzetto di D’Artagnan, mentre il ruolo di Porthos e Aramis è rivestito da due uomini della ciurma, Carmaux e Wan Stiller.
Potrei sbizzarrirmi a cercare infiniti esempi di questo ventaglio di caratteri, talora disteso su una pluralità di personaggi, talaltra chiuso su un paio appena; oppure dilungarmi sui due aspetti della femminilità, quello benevolo e dolce e quello fatale e perverso. Sta di fatto che simili figure si ritrovano pari pari nella Commedia dell’Arte, e prima ancora; fino a essere presenti nel Pantheon di tutte le mitologie a me note.
Insomma, Salgari, come mille scrittori popolari, ricalca tipologie antiche — tanto antiche che forse rinviano ad archetipi. A quel punto, se l’operazione è ben condotta (e in Salgari lo è), la suggestione è assicurata. I suoi eroi vivranno per sempre, perché erano vivi da sempre.
La letteratura popolare: cos’è cambiato in Italia dai tempi di Salgari?
L’Italia non fa testo, anche per lo scempio che l’accademia ha fatto di tutta la narrativa di genere, vilipesa fino all’odio. Però anche l’Italia ha infine dovuto aprire le frontiere e accogliere prodotti importati. Un veicolo importante è stato legato a una peculiarità tutta italiana: la vendita di libri in collezioni da edicola. Quando si dice che gli italiani non leggono si afferma una sciocchezza, perché si tiene conto solo degli acquisti in libreria. Senza considerare che gialli, fantascienza, romanzi d’amore ecc. raggiungevano, negli anni d’oro (cioè prima che l’universo mediatico cambiasse forma), tirature settimanali di quaranta-cinquantamila copie. Edicole e cartolibrerie sono stati veicoli importanti di alfabetizzazione del popolo italiano.
Tuttavia, per riallacciarmi al discorso precedente, chi ha raccolto l’eredità della letteratura popolare fondata sul mito e sull’archetipo è stato il cinema. E lo ha fatto del tutto consapevolmente, indagando sulle proprie azioni con una profondità quasi ignota in ambito letterario, dove ci si accontenta delle divagazioni di un Piero Citati.
Un testo base rivolto agli sceneggiatori, Il viaggio dell’eroe di Chris Vogler, potrebbe essere ottima base interpretativa dell’intera produzione salgariana. Provare per credere.
La creazione di un’epica
I pirati della Malesia è in apparenza una narrazione caotica, e si ha spesso l’impressione che Salgari non abbia in mente un progetto preciso, ma si lasci trascinare dagli eventi via via che gli escono dalla penna. In realtà non è così. Il racconto si struttura in tre agglomerati piuttosto ben definiti (anche se i capitoli sono raccolti in due parti). Il primo si svolge quasi tutto in mare, e culmina con la caccia alla cannoniera olandese Helgoland. Il secondo ha luogo a terra, e ha per protagonista assoluto Yanez, infiltrato in campo nemico (Sarawack). Il terzo è interamente dominato dalla vicenda di Ada Corishant, l’innamorata di Tremal-Naik divenuta pazza e che Sandokan guarisce facendole rivivere le situazioni che la condussero alla follia. Seguono la sconfitta del rajah James Brooke e la rivolta che lo rovescia, ma non si tratta di un quarto atto, bensì di un epilogo, vista la fretta con cui sono narrati gli eventi. La struttura dunque c’è, e si presta a considerazioni curiose.
Anzitutto, essa cela un condensato di tutta l’opera salgariana, relativamente al ciclo malese, antecedente e successiva. La parte marina è molto simile a quella dei romanzi in cui le battaglie navali prevalgono, tipo il pessimo La riconquista di Mompracem o l’ottimo Il Re del mare (dove il possente incrociatore è un po’ l’equivalente dell’Helgoland). Yanez «infiltrato» lo si era già visto ne Le tigri di Mompracem, e lo si rivedrà in Alla conquista di un impero. La terza parte è una pura e semplice replica de I misteri della jungla nera, con dettagliata descrizione dei cerimoniali dei thugs (presenti anche, in contesto parigino, nel romanzo Gli strangolatori di Ponson du Terrail). Potremmo quasi dire che chi legga I pirati della Malesia abbia in pratica letto l’intero ciclo di Sandokan. Da quel momento non si troverà di fronte che variazioni sul tema.
Fin qui, sembrerei dare ragione a chi sostiene che la paraletteratura si fondi sui cliché e sulla ripetitività esasperata. In realtà, non condivido affatto quel tanto di liquidatorio che è presente in questo giudizio.
Qui mi sostiene un saggio di Francesco Scardamaglia, uomo di cinema e psicanalista, apparso sulla rivista «Script». Scardamaglia vi sostiene che anche i sogni si strutturano in tre atti, e che la ricorrenza di tale schema, in forme occulte o palesi, nei tipi più popolari di narrazione, obbedisce a un’esigenza mentale recondita di organizzazione del racconto. Se ciò è vero — e credo che lo sia — la costruzione narrativa salgariana, in apparenza scombinata, va a sfiorare materiale inconscio e su esso si articola. Dunque si insinua nel profondo più di tanta prosa corrente. Se a ciò aggiungiamo il ricorrere a figure di protagonisti che hanno facili riscontri omerici, se non addirittura precedenti (Achille, Ulisse, Elena, ecc.), ci è facile desumere che Salgari attinge consapevolmente al mito per riproporlo sotto altro sembiante. Sa benissimo che sta creando un’epica destinata a durare, poiché è modellata su altre preesistenti.
Narrazione ancestrale
Guardiamo cosa accade ne I pirati della Malesia. Dopo le grandi imprese de Le tigri di Mompracem, Sandokan si è ritirato sul suo isolotto, affranto per la perdita dell’amata Marianna Guillonk. Si dedica alla pirateria di piccolo cabotaggio, tanto che in mare manda di preferenza Yanez. Ed ecco che un evento imprevisto, la cattura casuale dell’indiano Kammamuri, lo richiama in battaglia. Kammamuri gli svela le tragiche traversie della cugina di Marianna, Ada Corishant, ed evoca il nome del nemico supremo, Lord Guillonk. Sandokan torna dunque sul sentiero di guerra, ma lo attende una prima sconfitta in campo aperto. Non gli resta che attuare una lenta marcia di avvicinamento al nemico (che poi sono due: a Guillonk si è affiancato il rajah bianco di Sarawack), raccogliendo alleati lungo il percorso. Ci saranno una vittoria finale e una resurrezione (Ada / Tremal-Naik), poi il ritorno di Sandokan a Mompracem (e di Tremal-Naik in India).
A parte una duplicazione transitoria degli eroi e dei cattivi (Sandokan / Tremal-Naik, Guillonk / Brooke), siamo di fronte a un’applicazione tra le più fedeli e convincenti (un’altra è Il Signore degli Anelli) dello schema che Chris Vogler rintraccia in tutti i miti. Con in più agnizioni, pentimenti, una versione coloniale di Montecchi e Capuleti, audacie illimitate, astuzie illimitate, senso dell’onore e sete di vendetta frenata all’ultimo dall’umanità.
Un luogo che sta altrove
Se per decifrare Salgari dobbiamo fare ricorso ad autori che si occupano di cinema, è perché Salgari è cinema. L’azione è descritta con precisione scenografica, i paesaggi hanno una magnifica evidenza di colori, i dettagli più improbabili hanno sapore di verità. È vero: quando Salgari si lancia in una descrizione, questa ha tutta l’aria di un pedissequo elenco di piante e animali, magari ricalcato da altri autori (Gustave Aymard, soprattutto) o copiato da manuali, errori inclusi (da cui l’onnipresenza del misterioso babirussa, povera bestiolina che non ha mai frequentato le giungle indiane). Però in Salgari ogni elemento esotico si dilata a dismisura, assume proporzioni assurde, sconfina nel fantastico come in Marco Polo. Un elefante salgariano porta sul dorso non un baldacchino pencolante, ma una piccola reggia; un rinoceronte è più demone che bestia; una sua tigre ha istinti sanguinari degni di Dracula; e non parliamo dei coccodrilli, più colossali e famelici di quelli di certi film di serie B. Si legga quel piccolo capolavoro che è Sandokan alla riscossa: una specie di bestiario medioevale, per varietà e fantasia della fauna e della flora. Salgari scruta la sua giungla come Cristoforo Colombo, nel film 1492 – La conquista del Paradiso (Ridley Scott, 1992), scrutava la terra incognita oltre la nebbia: aspettandosi di tutto. E noi viviamo lo stesso sense of wonder, come se stessimo esplorando le mappe più segrete del nostro inconscio, personale ma soprattutto collettivo.
«Umiltà» immortale
Mettere in evidenza l’assonanza con il mito e con la sfera archetipica delle narrazioni salgariane, e di gran parte della letteratura di genere, non significa affatto rivolgere una critica a chi, scrivendo, non si attiene a quei capisaldi. Mi sembra ovvio. È chiaro che l’originalità è in sé un valore, mentre la ripetitività non lo è. Ma io sto qui combattendo una duplice battaglia: difensiva da un lato, di comprensione dall’altro.
Prendiamo il primo aspetto, quello della difesa. E accusa ricorrente, nei confronti della narrativa di genere o popolare, di essere effimera e in pratica priva di radici. Ho appena cercato di dimostrare come essa di radici ne abbia, eccome; semmai sono troppo antiche e profonde per essere scorte facilmente. Perfino il brillante prefatore di una recente riedizione salgariana, Sergio Campailla, scrive che «sarebbe sbagliato privarsi di Salgari, che rappresenta una quota umile del nostro patrimonio ideativo e letterario». «Umile»? Ma quando mai? Forse che l’immaginario di tante generazioni è stato nutrito più da Fogazzaro che da Salgari? Non scherziamo. Inquadrato Salgari entro i suoi limiti stilistici, assolutamente evidenti, è doveroso riconoscergli un’influenza sul fantasticare giovanile (e non solo) che pochissimi suoi contemporanei hanno avuto. Quanto alla battaglia per la conoscenza, essa riguarda una domanda cruciale: che cosa consacra un autore alla longevità, se non all’immortalità? La ribalto in altra forma, volutamente provocatoria: qualcuno pensa che il più recente vincitore del Premio Strega sopravviverà al 2015, al 2025, al 2035? Mi permetto di dubitarne. Invece l’effimero Salgari ci accompagna dalla fine dell’Ottocento e ancora non accenna a scomparire. Capirne la ragione dovrebbe importare a chiunque analizzi lo scrivere o scriva egli stesso. Attiene al motivo per cui, dall’alba dei tempi, gli esseri umani si raccontano storie e condividono l’immaginazione altrui.




