di Giuseppe Genna
 Di fronte all’infittirsi di attentati clamorosi (Londra, Sharm el Sheikh e, da non sottovalutare, Beirut pochi minuti dopo la partenza di Condoleeza Rice) si possono scatenare le più varie strategie della tensione interpretativa. Il proliferare di reazioni culturali, che spesso si scambia per enfatizzazione retorica, è un sintomo significativo della normalizzazione culturale rispetto a eventi tensivi – secondo le analisi correnti dei non specialisti. Le cose, però, stanno diversamente da come se le immaginano i non addetti ai lavori. I commenti (qui intesi come sintomatologia dell’elaborazione culturale delle minacce alla sopravvivenza) tendono a un’equalizzazione che fa da specchio alla continuità degli eventi terroristici (Post traumatic stress disorder. Dialogues in Clinical Neuroscience, R.C. Ware, 1995). Tutto si innalza a un grado zero, a un alzo zero: che è da obice non solo militare, ma soprattutto percettivo. Aggiungo, a questa omogenea intensità interpretativa dell’emergenza, mie personali considerazioni, che non hanno carattere né geopolotico né tecnicamente storico, ma unicamente psichiatrico.
Di fronte all’infittirsi di attentati clamorosi (Londra, Sharm el Sheikh e, da non sottovalutare, Beirut pochi minuti dopo la partenza di Condoleeza Rice) si possono scatenare le più varie strategie della tensione interpretativa. Il proliferare di reazioni culturali, che spesso si scambia per enfatizzazione retorica, è un sintomo significativo della normalizzazione culturale rispetto a eventi tensivi – secondo le analisi correnti dei non specialisti. Le cose, però, stanno diversamente da come se le immaginano i non addetti ai lavori. I commenti (qui intesi come sintomatologia dell’elaborazione culturale delle minacce alla sopravvivenza) tendono a un’equalizzazione che fa da specchio alla continuità degli eventi terroristici (Post traumatic stress disorder. Dialogues in Clinical Neuroscience, R.C. Ware, 1995). Tutto si innalza a un grado zero, a un alzo zero: che è da obice non solo militare, ma soprattutto percettivo. Aggiungo, a questa omogenea intensità interpretativa dell’emergenza, mie personali considerazioni, che non hanno carattere né geopolotico né tecnicamente storico, ma unicamente psichiatrico.
Per realizzare l’esito di un’autentica strategia della tensione bisogna disporre di una minima consapevolezza rispetto al fenomeno della tensione (buon resumé su cosa si intenda qui per “tensione” è reperibile in Neurodevelopmental Factors in the ‘Cycle of Violence’ di Bruce D. Perry, incluso in Children, Youth and Violence: The Search for Solutions, a cura di J. Osofsky, 2000). Qui però il problema è un nodo gordiano, un’osmosi quasi inesplicabile di contenitori individuali e collettivi – indurre una modificazione del sistema nervoso, da condursi su estensione collettiva e non topicamente. Questo salto quantico è fondamentale. Un conto è realizzare Abu Ghreib o Guantanamo. Mediante privazione del sonno, bombardamento o deprivazione delle percezioni, inoculazione di traumi ritmati da una precisa (studiatissima) continuità: si tratta di lavorare a un’unificazione delle informazioni e della risposta neurofisiologica a queste informazioni (Gordon Thomas, Journey Into Madness. The True Story of Secret CIA, Mind Control and Medical Abuse, 1989). Nel caso dell’individuo, è facile (Harold Bursztajn, “Mental Illness Creates Eligibility for a Lower Sentence”, in Forensic Psychiatry, 2004). Nel caso delle comunità da sottoporre a una simile devastante terapia, è molto diverso (note a margine del caso PTECH, in http://www.copvcia.com/free/ww3/012005_ptech_pt1.shtml). Qualunque studio psicologico sui gruppi e le comunità che si sia svolto negli ultimi vent’anni conferma questo assunto (per esempio, le valutazioni a margine in Rats’ preferences for an analgesic compared to water: an alternative to “killing the rat so it does not suffer”, Persinger MA, 2004).
Già un gruppo di venti persone non risulta, nell’effettività, essere assimilabile a un macrosoggetto. Esiste una funzionalità psichica del gruppo che sfrutta le inclinazioni individuali come parti di un grande, quasi eterico “sé” – ma ciò non è affatto assimilabile qualitativamente al “sé” funzionale dell’individuo. Con le masse, ci si trova in un ulteriore universo distinto. 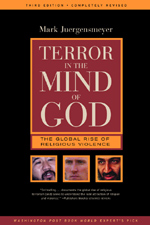 Con la massa supernazionale planetaria od occidentale, poi, si è saliti a un più distinto grado quantico. Nei gruppi di controllo, l’esposizione agli eventi di stress implica reazioni totalmente diverse da quelle espresse dai singoli individui, soprattutto quando lo scatenamento delle reazioni viene veicolato sui piani delle esperienze irrazionali come fede, caso, necessità (in prospettiva socioantropologica: Mark Juergensmeyer con Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence, 2000; in prospettiva neuroscientifica, vedi Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Clinical Neuroscience di Joseph Rhawn, e Is There Anybody Out There? The Fate of God in an Accidental World di Taner Edis, ma anche Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Clinical Neuroscience, sempre di Joseph Rhawn, 1996).
Con la massa supernazionale planetaria od occidentale, poi, si è saliti a un più distinto grado quantico. Nei gruppi di controllo, l’esposizione agli eventi di stress implica reazioni totalmente diverse da quelle espresse dai singoli individui, soprattutto quando lo scatenamento delle reazioni viene veicolato sui piani delle esperienze irrazionali come fede, caso, necessità (in prospettiva socioantropologica: Mark Juergensmeyer con Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence, 2000; in prospettiva neuroscientifica, vedi Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Clinical Neuroscience di Joseph Rhawn, e Is There Anybody Out There? The Fate of God in an Accidental World di Taner Edis, ma anche Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Clinical Neuroscience, sempre di Joseph Rhawn, 1996).
A spiegare in termini psichiatrici il momento attuale e a reclamare una ben diversa valorizzazione, c’è un’elaborazione trascurata della storia della psicologia mondiale ed è di marca italiana: sono gli scritti di Franco Fornari sulla paura atomica (essenzialmente il testo della conferenza La pace all’origine della specie umana, ovvero le origini psicoanalitiche della non violenza, 1985). Dalle valutazioni di Fornari, una linea di studi gruppali (soprattutto quelli di Spaltro e Vanni) ha fatto emergere alcuni importanti schemi interpretativi che sembrano spiegare con esattezza ciò che sta accadendo in queste ore in Europa sul piano delle reazioni agli attentati. Per esempio, lo stato di “adiabatizzazione” del soggetto collettivo (di cui il National Institute of Mental Health ha affrontato alcuni aspetti nella comunicazione su Nature Neuroscience dello scorso 10 luglio). E’ una difesa che potremmo paragonare all'”equalizzazione” e che, in termini di chiacchiera, viene tradotta con la frequente osservazione che, in tempo di guerra, crollano drasticamente le sindromi depressive (PSYCHOLOGICAL TRAUMA: Attachment, Neuroscience & Body Experience di Bessel A. van der Kolk, 2005). Il soggetto collettivo, in pratica, tende alla stabilizzazione, mentre il mondo lo aggredisce con bombardamenti tensivi, metaforici o militari. Ciò che accade è, detto in altri termini, una sorta di rimozione o, meglio, di fall out della consapevolezza di ciò che potrebbe accadere: la tensione non c’è. Lo sfondo si mangia la figura.
I gruppi attuano questa strategia di autoinduzione dell’ignoranza con metodiche assolutamente irriferibili alle difese del soggetto. La figura psichica del “capro espiatorio” o lo schema “Orazi-Curiazi” non sono affatto riconducibili a schemi individuali (Modelli mentali di gruppo di F. Vanni, 1988). La “madre-bomba” a cui allude Fornari è una funzione intraindividuale e intragruppale senza distinzione di sorta. La funzionalità di simili difese è quella di adattamento preculturale allo stato di omogeneità tensiva a cui è sottoposta la comunità, non il soggetto. E’, nei fatti, una constatazione banale: se uccidiamo, nell’arco di tre giorni, la madre, la moglie, i figli di un soggetto, otterremo risposte assolutamente diverse dal medesimo soggetto che, inserito in una comunità, si trova ad affrontare esplosioni quotidiane nelle linee metropolitane che usa. C’è un’abissale distanza affettiva tra queste serie di eventi e, quindi, ma non algebricamente o geometricamente, si riscontra un’abissale differenza di risposta affettiva – soprattutto in termini di stress (vedi per esempio Compassion Fatigue: Secondary Traumatic Stress Disorders di Charles Figley, 1995).
Queste sommarie considerazioni tentano di rispondere all’inefficacia ormai dimostrata di qualunque strategia della tensione. Lo stress gruppale emergerà quando il momento storico sarà cambiato. Se riflettiamo in termini psichiatrici sulla depressione concreta (testimoniata da un numero infinito di analisi scritte dai protagonisti del tempo) che colse il crogiolo plurinazionale dell’impero asburgico a fine XIX secolo (il brodo primordiale in cui si sviluppava il germe Hitler), comprenderemo come Weimar potesse emergere soltanto in seguito a uno stress identitario tanto esteso e collettivo, ma dopo che la tensione si era insinuata nella collettività: vent’anni circa di iato, per intenderci, includendo il trauma della grande guerra (è chiaro che non sto discettando in termini storici: il piano è unicamente quello della psichiatria di massa). La sintomatologia psichiatrica è probabilmente la specola più opportuna per spiegare metaforicamente zone storiche di reazione ed elaborazione comunitaria: dopo la tensione, il rilascio (la cecità isterica semestrale, di cui Hitler iniziò a soffrire all’indomani della sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale, per esempio, è una chance sintomatica e metaforica di notevole valore: vedi per esempio Michael A. Milburn e S. D. Conrad in The Politics of Denial, sul numero 23-1996 del Journal of Psychohistory). La strategia della tensione impone stress, certo, ma questo stress causa reazioni dopo che è passato il momento storico in cui quella strategia intendeva imporre effetti .
Altro piano è, ovviamente, quello politico. Una strategia della tensione comporta reazioni politiche, ma queste non hanno nulla a che vedere con la tensione a cui è sottoposta la comunità bersagliata. La risposta “fredda” degli inglesi alle bombe del 7 luglio è, a tutti gli effetti, un freezing collettivo che darà i suoi frutti fra parecchio tempo. La macrofesta con 8.000 invitati a Buckingham Palace la sera dopo la seconda giornata di bombe (quelle detonate male) non è affatto una risposta “coraggiosa” della comunità o delle istituzioni, bensì la dimostrazione di un congelamento emotivo con cui una massa (e non un vertice politico) vive il processo di equalizzazione della tensione. La psicologia di massa non muta sensibilmente in tempo di guerra: muta dopo.
L’impossibilità, soprattutto occidentale, di considerare che, in termini di topiche freudiane, prima del processo primario individuale sia esperibile uno stato di attivazione supersoggettiva, non intercettabile dal linguaggio né dall’esperienza formatasi attraverso il rapporto “soggetto-oggetto” – ecco il buco nero della nostra psicologia di massa. Buco nero che è perfettamente omologo a una falsa traduzione in termini politici delle cosiddette reazioni di massa. L’ipotesi è, a questo punto, non più che lo sfondo si mangi la figura, ma che lo sfondo sia la figura, per il tempo necessario a elaborare la possibilità che figure tornino a stagliarsi sullo sfondo: e sarà il momento in cui la tensione rimossa emergerà in affetti collettivi, a molta distanza dal momento in cui lo stress è stato indotto e non avvertito dalla comunità – o, come dicevo, adiabatizzato dalla comunità. La politica va in iato rispetto al “sentimento” collettivo della tensione, proponendosi quale figura unica che si staglia sullo sfondo: operazione di falsificazione psichica o, meglio, difesa superficiale. Questo iato tra politica e “sentimento” collettivo, per esempio, assume drammatica evidenza nel momento in cui l’Amministrazione Bush scatena la terza guerra mondiale in risposta all’offesa dell’11 settembre, oppure pretende di difendere uno “stile di vita” occidentale (che è, anzitutto e ben prima che un’evenienza materiale di condizioni socioeconomiche, uno stato psichico) con protocolli di controllo come il famigerato Freedom of Information Act (Sam Harris in The End Of Faith. Religion, Terror, And The Future Of Reason, 2003).
In questo iato tra stato della psiche collettiva e intervento politico si gioca tutta la storia del potere nell’interpretazione datane dall’occidente: è questo il vero nucleo della questione biopolitica.



