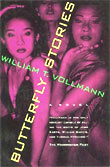 Tutto comincia con Afghanistan Picture Show – ovvero, come ho salvato il mondo (Alet, €. 18). Poi si spalanca l’abisso: un’ossessione dietro l’altra.
Tutto comincia con Afghanistan Picture Show – ovvero, come ho salvato il mondo (Alet, €. 18). Poi si spalanca l’abisso: un’ossessione dietro l’altra.
Afghanistan Picture Show ha avuto una storia complicata. Il viaggio, la visione della violenza allo stato puro. Molto prima di Bin Laden, intendo. Il ritorno in America. La stesura. Revisioni su revisioni. C’era una profondità, nel testo, che non riuscivo a scavare. Poi è stato un disastro: dico dal punto di vista esistenziale. Un periodo tragico, per me. Dico davvero. Mi sono messo a lavorare coi computer per sbarcare il lunario, ma non ne sapevo niente, e intanto revisionavo il libro. Poi la scrittura è esplosa, è stato irresistibile, non ho più smesso.
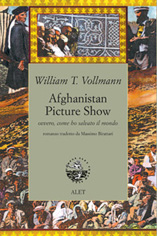 Alcune delle tue storie riguardano la morte di tua sorella. Invochi la memoria di un’infanzia stravolta, ma della tua infanzia non scrivi mai. Che infanzia ha avuto William Vollmann?
Alcune delle tue storie riguardano la morte di tua sorella. Invochi la memoria di un’infanzia stravolta, ma della tua infanzia non scrivi mai. Che infanzia ha avuto William Vollmann?
Sono nato a Los Angeles. Mio padre era uno studente appena laureato. Vivevamo in un ghetto, in una baracca metallica costruita per veterani di guerra. Faceva un caldo soffocante, d’estate. I miei coetanei erano gente violenta. Ne ho prese parecchie da loro. Mi sono fatto alcuni amici. A volte ero completamente terrorizzato e me ne stavo chiuso in casa. Siamo rimasti lì fino a che non ho compiuto i sei anni.
E poi?
E poi ci siamo trasferiti nel New Hampshire, dove mio padre aveva ottenuto un posto come insegnante. Adesso quella zona di baracche per veterani non esiste più: ci hanno costruito un’autostrada.
Quando hai iniziato a capire che avresti scritto?
Molto presto. A sei anni già sapevo scrivere e sapevo anche di cosa mi piaceva scrivere. Sognavo. Vivevo in mondi paralleli. E’ la scaturigine del racconto.
Ti sei diplomato. E poi?
 Ho iniziato a lavorare. Segretario in una piccola compagnia di assicurazioni, a san Francisco. Otto mesi, è durata. Tutto quello che dovevo fare era accogliere i clienti, farli accomodare, piazzare i loro soprabiti sull’attaccapanni, chiedere loro quanto zucchero desideravano nel caffè. Paga: ottocento dollari al mese. Ho messo via un po’ di soldi e sono partito per l’Afghanistan. Ho seguito per un po’ la resistenza, poi sono tornato. Per sopravvivere ho fatto il venditore porta a porta. Andava benissimo, all’inizio: era estate. Poi, d’inverno, ha cominciato a piovere, e, siccome tutti mi respingevano, ero sempre fradicio. Davvero, ti lasciavano tutti fuori dalla porta. A parte i papponi, i drogati, o consimili.
Ho iniziato a lavorare. Segretario in una piccola compagnia di assicurazioni, a san Francisco. Otto mesi, è durata. Tutto quello che dovevo fare era accogliere i clienti, farli accomodare, piazzare i loro soprabiti sull’attaccapanni, chiedere loro quanto zucchero desideravano nel caffè. Paga: ottocento dollari al mese. Ho messo via un po’ di soldi e sono partito per l’Afghanistan. Ho seguito per un po’ la resistenza, poi sono tornato. Per sopravvivere ho fatto il venditore porta a porta. Andava benissimo, all’inizio: era estate. Poi, d’inverno, ha cominciato a piovere, e, siccome tutti mi respingevano, ero sempre fradicio. Davvero, ti lasciavano tutti fuori dalla porta. A parte i papponi, i drogati, o consimili.
Quindi il libro sull’Afghanistan è il primo che hai scritto, ma non il primo che hai pubblicato.
Infatti. Il primo a uscire è stato You Bright and Risen Angels. L’ho scritto in maniera che chiunque definirebbe folle, e non a torto. Ero diventato programmatore per una software house. Mi è anche venuta la sindrome del tunnel carpale e a tutt’oggi non posso più scrivere al computer. Non so perché mi avessero scelto come programmatore: di computer non ne sapevo nulla. Comunque, all’orario di chiusura, quando tutti se ne andavano, io mi barricavo e mi piazzavo davanti al file del libro. Mangiavo dolciumi distribuiti dalla macchinetta dell’ufficio. Erano il mio pranzo, la mia cena, la mia colazione. Scrivevo e scrivevo, e poi crollavo.
Con Rainbow Stories sei passato, dalla scrittura psichedelica, a una fiction che sfiora il reportage. Tra l’altro, per documentarti, sei andadto da solo al Polo…
Un’esperienza traumatica e straordinaria… Devi portarti dietro parecchi abiti, moltissimo cibo, combustibile per riscaldarti. Scrivere è quasi impossibile. Il gelo è insopportabile e soporifero. Comunque il viaggio al Polo mi ha dato un metodo. Parte di quello che guadagno viene impiegato in viaggi di documentazione, per i prossimi libri.
Documentazione dal vivo, come nel caso delle prostitute malate di AIDS in Butterfly Story?
Esatto. Sono andato sul campo. Ho frequentato prostitute per una cifra. La storia era semplice. Un giornalista americano va in Cambogia, si innamora di una prostituta, torna negli USA, scopre di avere contratto l’AIDS dalla tipa. Allora torna in Cambogia, non riesce a trovarla, suppone sia morta, viene catturato dagli Khmer rossi, dai quali si fa uccidere per ricongiungersi nell’aldilà con la donna che ama. Io sono sieronegativo, però, e non sono stato catturato dagli Khmer rossi.
Sei tuttora alle prese con la saga di Seven Dreams.
Il progetto a cui tengo di più. Ho fatto viaggi in Alaska e Groenlandia per documentarmi. Questa specie di epica, che investiga la macrostoria di un popolo intero, o, meglio, di più popoli in un unico continente, mi ossessiona quasi come la figura della prostituta, un nodo tematico affascinante, il nucleo irriducibile in cui collassano il sesso, l’amore, i soldi, la malattia; da Whores for Gloria in poi, non mi sono più liberato da quest’ossessione.
[da dichiarazioni rilasciate a Larry McCaffery per ‘Dalkey Archive Press’, alla redazione di ‘ALT-X’ e a Steve Kettmann per ‘Salon’]



