elaborato da Serge Latouche
[nell’ambito del Cercle François Partant]
 La corrente di pensiero che si riferisce al doposviluppo ha conservato fino a oggi un carattere quasi
La corrente di pensiero che si riferisce al doposviluppo ha conservato fino a oggi un carattere quasi
confidenziale. Nel corso di una storia già lunga ha prodotto, ciò nonostante, una letteratura non
disprezzabile che si trova rappresentata in numerosi campi di ricerca e d’azione nel mondo.
Nata negli anni sessanta, il decennio dello sviluppo, da una riflessione critica sui presupposti
dell’economia e sul fallimento delle politiche di sviluppo, questa corrente riunisce ricercatori, attori
sociali del Nord come del Sud portatori di analisi e di esperienze innovatrici sul piano economico,
sociale e culturale. Nel corso degli anni si sono intrecciati dei legami spesso informali tra le sue
diverse componenti e le esperienze e le riflessioni si sono mutuamente alimentate. Il Réseau pour
l’après-developpement s’inscrive dunque nel movimento dell’International Network for Cultural
Alternatives to Development (INCAD) e si riconosce pienamente nella dichiarazione del 4 maggio
1992. Intende proseguire e ampliare il lavoro così cominciato.
Il Réseau mette al centro della sua analisi la critica radicale della nozione di sviluppo che,
nonostante le evoluzioni formali conosciute, resta il punto di rottura decisivo in seno al movimento
di critica al capitalismo e della globalizzazione. Ci sono da un lato quelli che, come noi, vogliono
uscire dallo sviluppo e dall’economicismo e, dall’altro, quelli che militano per un problematico
«altro» sviluppo (o una non meno problematica «altra» globalizzazione). A partire da questa critica,
la corrente procede a una vera e propria «decostruzione» del pensiero economico. Sono pertanto
rimesse in discussione le nozioni di crescita, povertà, bisogno, aiuto ecc.
Le associazioni e i membri della presente rete si riconoscono in tale impresa. Dopo il fallimento del
socialismo reale e il vergognoso scivolamento della socialdemocrazia verso il social-liberalismo,
noi pensiamo che solo queste analisi possano contribuire a un rinnovamento del pensiero e alla
costruzione di una società veramente alternativa alla società di mercato. Rimettere radicalmente in
questione il concetto di sviluppo è fare della sovversione cognitiva, e questa è la condizione
preliminare del sovvertimento politico, sociale e culturale.
Il momento ci sembra favorevole per uscire dalla semiclandestinità dove siamo stati relegati finora e
il grande successo del colloquio di La ligne d’horizon, «Défaire le développement, refaire le
monde», che si è tenuto presso l’UNESCO dal 28 febbraio al 3 marzo 2002, rafforza le nostre
convinzioni e le nostre speranze.
Rompere l’immaginario dello sviluppo e decolonizzare le menti
Di fronte alla globalizzazione, che non è altro che il trionfo planetario del mercato, bisogna
concepire e volere una società nella quale i valori economici non siano più centrali (o unici).
L’economia dev’essere rimessa al suo posto come semplice mezzo della vita umana e non come
fine ultimo. Bisogna rinunciare a questa folle corsa verso un consumo sempre maggiore. Ciò non è
solo necessario per evitare la distruzione definitiva delle condizioni di vita sulla Terra ma anche e
soprattutto per fare uscire l’umanità dalla miseria psichica e morale. Si tratta di una vera
decolonizzazione del nostro immaginario e di una diseconomicizzazione delle menti indispensabili
per cambiare davvero il mondo prima che il cambiamento del mondo ce lo imponga nel dolore.
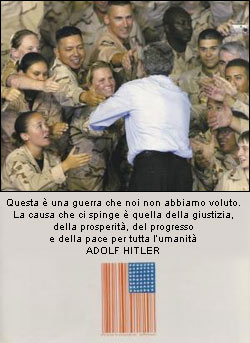 Bisogna cominciare con il vedere le cose in altro modo perché possano diventare altre, perché sia
Bisogna cominciare con il vedere le cose in altro modo perché possano diventare altre, perché sia
possibile concepire soluzioni veramente originali e innovatrici. Si tratta di mettere al centro della
vita umana altri significati e altre ragioni d’essere che l’espansione della produzione e del consumo.
La parola d’ordine della rete è dunque «resistenza e dissidenza». Resistenza e dissidenza con la
testa ma anche con i piedi. Resistenza e dissidenza come atteggiamento mentale di rifiuto, come
igiene di vita. Resistenza e dissidenza come atteggiamento concreto mediante tutte le forme di
autorganizzazione alternativa. Ciò significa anche il rifiuto della complicità e della collaborazione
con quella impresa dissennata e distruttiva che costituisce l’ideologia dello sviluppo.
Illusioni e rovine dello sviluppo
La mondializzazione attuale ci mostra quel che lo sviluppo è stato e che non abbiamo mai voluto
vedere. Essa è lo stadio supremo dello sviluppo realmente esistente e nello stesso tempo la
negazione della sua concezione mitica. Se lo sviluppo, effettivamente, non è stato altro che il
seguito della colonizzazione con altri mezzi, la nuova mondializzazione, a sua volta, non è altro che
il seguito dello sviluppo con altri mezzi. Conviene dunque distinguere lo sviluppo come mito dallo
sviluppo come realtà storica.
Si può definire lo sviluppo realmente esistente come una impresa che mira a trasformare in merci le
relazioni degli uomini tra loro e con la natura. Si tratta di sfruttare, di valorizzare, di trarre profitto
dalle risorse naturali e umane. Progetto aggressivo verso la natura e verso i popoli, è – come la
colonizzazione che la precede e la mondializzazione che la segue – un’opera al tempo stesso
economica e militare di dominazione e di conquista. È lo sviluppo realmente esistente, quello che
domina il pianeta da tre secoli, che causa i problemi sociali e ambientali attuali: esclusione,
sovrappopolazione, povertà, inquinamenti diversi ecc.
Quanto al concetto mitico di sviluppo, è nascosto in un dilemma: da una parte, esso designa tutto e
il suo contrario, in particolare l’insieme delle esperienze storiche e culturali dell’umanità, dalla Cina
degli Han all’impero degli Inca. In questo caso non designa nulla in particolare, non ha alcun
significato utile per promuovere una politica, ed è meglio sbarazzarsene. Dall’altra parte, esso ha un
contenuto proprio, il quale designa allora necessariamente ciò che possiede in comune con
l’avventura occidentale del decollo dell’economia così come si è organizzata dalla rivoluzione
industriale in Inghilterra negli anni 1750-1800. In questo caso, quale che sia l’aggettivo che gli si
affianca, il contenuto implicito o esplicito dello sviluppo è la crescita economica, l’accumulazione
del capitale con tutti gli effetti positivi e negativi che si conoscono. Ora, questo nucleo centrale che
tutti gli sviluppi hanno in comune con tale esperienza, è legato a rapporti sociali ben particolari che
sono quelli del modo di produzione capitalistico. Gli antagonisti di «classe» sono ampiamente
occultati dalla pregnanza di «valori» comuni ampiamente condivisi: il progresso, l’universalismo, il
dominio della natura, la razionalità quantificante. Questi valori sui quali si basa lo sviluppo, e in
particolare il progresso, non corrispondono affatto ad aspirazioni universali profonde. Sono legati
alla storia dell’Occidente e trovano scarsa eco nelle altre società. Al di fuori dei miti che la fondano,
l’idea di sviluppo è totalmente sprovvista di senso e le pratiche che le sono legate sono
rigorosamente impossibili perché impensabili e proibite. Oggi questi valori occidentali sono
precisamente quelli che bisogna rimettere in discussione per trovare una soluzione ai problemi del
mondo contemporaneo ed evitare le catastrofi verso le quali l’economia mondiale ci trascina. Il
doposviluppo è al contempo postcapitalismo e postmodernità.
I nuovi aspetti dello sviluppo
Per tentare di scongiurare magicamente gli effetti negativi dello sviluppo, siamo entrati nell’era
dello sviluppo aggettivato. Si è assistito alla nascita di nuovi sviluppi autocentranti, endogeni,
partecipativi, comunitari, integrati, autentici, autonomi e popolari, equi…senza parlare dello
sviluppo locale, del microsviluppo, dell’endosviluppo, dell’etnosviluppo! Affiancando un aggettivo
al concetto di sviluppo, non si tratta veramente di rimettere in discussione l’accumulazione
capitalistica; tutt’al più si pensa di aggiungere un risvolto sociale o una componente ecologica alla
crescita economica come un tempo si è potuto aggiungerle una dimensione culturale. Questo lavoro
di ridefinizione dello sviluppo riguarda, in effetti, sempre più o meno la cultura, la natura e la
giustizia sociale. In tutto ciò si tratta di guarire un male che colpirebbe lo sviluppo in modo
accidentale e non congenito. Per l’occasione è stato addirittura creato uno spauracchio, il
malsviluppo. Questo mostro è solo una chimera, poiché il male non può colpire lo sviluppo per la
buona ragione che lo sviluppo immaginario è per definizione l’incarnazione stessa del bene. Il buon
sviluppo è un pleonasmo perché lo sviluppo significa buona crescita, perché anche la crescita è un
bene contro il quale nessuna forza del male può prevalere.
È l’eccesso stesso delle prove del suo carattere benefico che meglio rivela la frode dello sviluppo.
Lo sviluppo sociale, lo sviluppo umano, lo sviluppo locale e lo sviluppo durevole non sono altro
che gli ultimi nati di una lunga serie di innovazioni concettuali tendenti a far entrare una parte di
sogno nella dura realtà della crescita economica. Se lo sviluppo sopravvive ancora lo deve
soprattutto ai suoi critici! Inaugurando l’era dello sviluppo aggettivato (umano, sociale ecc.), gli
umanisti canalizzano le aspirazioni delle vittime dello sviluppo del Nord e del Sud
strumentalizzandoli. Lo sviluppo durevole è il più bel successo di quest’arte di ringiovanimento di
vecchie cose. Esso illustra perfettamente il procedimento di eufemizzazione mediante aggettivo. Lo
sviluppo durevole, sostenibile o sopportabile (sustainable), portato alla ribalta alla Conferenza di
Rio del giugno 1992, è un tale «fai da te» concettuale, che cambia le parole invece di cambiare le
cose, una mostruosità verbale con la sua antinomia mistificatrice. Ma nello stesso tempo, con il suo
successo universale, attesta la dominazione della ideologia dello sviluppo. Ormai la questione dello
sviluppo non riguarda soltanto i paesi del Sud, ma anche quelli del Nord.
Se la retorica pura dello sviluppo con la pratica legata dell’espertocrazia volontarista non ha più
successo, il complesso delle credenze escatologiche in una prosperità materiale possibile per tutti e
rispettosa dell’ambiente resta intatto. L’ideologia dello sviluppo manifesta la logica economica in
tutto il suo rigore. Non c’è posto in questo paradigma per il rispetto della natura reclamato dagli
ecologisti né per il rispetto dell’uomo reclamato dagli umanisti. Lo sviluppo realmente esistente
appare allora nella sua verità. E lo sviluppo alternativo come un miraggio.
Oltre lo sviluppo
Parlare di doposviluppo non è soltanto lasciar correre l’immaginazione su ciò che potrebbe accadere
in caso di implosione del sistema, fare della fantapolitica o esaminare un problema accademico. È
parlare della situazione di coloro che attualmente al Nord come al Sud sono esclusi o sono in
procinto di diventarlo, di tutti coloro, dunque, per i quali il progresso è un’ingiuria e una ingiustizia,
e che sono indubbiamente i più numerosi sulla faccia della Terra. Il doposviluppo si delinea già tra
noi e si annuncia nella diversità.
Il doposviluppo, in effetti, è necessariamente plurale. Si tratta della ricerca di modalità di
espansione collettiva nelle quali non sarebbe privilegiato un benessere materiale distruttore
dell’ambiente e del legame sociale. L’obiettivo della buona vita si declina in molti modi a seconda
dei contesti. In altre parole, si tratta di ricostruire nuove culture. Questo obiettivo può essere
chiamato l’humran (crescita/rigoglio) come in Ibn Khaldūn, swadeshi-sarvo-daya (miglioramento
delle condizioni sociali di tutti) come in Gandhi, o bamtaare (stare bene assieme) come dicono i
toucouleurs, o in altro modo. L’importante è esprimere la rottura con l’impresa di distruzione che si
perpetua sotto il nome di sviluppo oppure, oggi, di mondializzazione. Per gli esclusi, per i naufraghi
dello sviluppo, può trattarsi soltanto di una sorta di sintesi tra la tradizione perduta e la modernità
inaccessibile. Queste creazioni originali di cui si possono trovare qua e là degli inizi di realizzazione
aprono la speranza di un doposviluppo. Bisogna al tempo stesso pensare e agire globalmente e
localmente. È solo nella mutua fecondazione dei due approcci che si può tentare di sormontare
l’ostacolo della mancanza di prospettive immediate. Il doposviluppo e la costruzione di una società
alternativa non si declinano necessariamente nello stesso modo al Nord e al Sud. Proporre la
decrescita conviviale come uno degli obiettivi globali urgenti e identificabili attualmente e mettere
in opera alternative concrete localmente sono prospettive complementari.
Decrescere e abbellire
La decrescita dovrebbe essere organizzata non soltanto per preservare l’ambiente ma anche per
ripristinare il minimo di giustizia sociale senza la quale il pianeta è condannato all’esplosione.
Sopravvivenza sociale e sopravvivenza biologica sembrano dunque strettamente legate. I limiti del
patrimonio naturale non pongono soltanto un problema di equità intergenerazionale nel condividere
le disponibilità, ma anche un problema di giusta ripartizione tra gli esseri attualmente viventi
dell’umanità.
La decrescita non significa un immobilismo conservatore. La saggezza tradizionale considerava che
la felicità si realizzasse nel soddisfare un numero ragionevolmente limitato di bisogni. L’evoluzione
e la crescita lenta delle società antiche si integravano in una riproduzione allargata ben temperata,
sempre adattata ai vincoli naturali.
Organizzare la decrescita significa, in altre parole, rinunciare all’immaginario economico, vale a
dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi
minori. Riscoprire la vera ricchezza nel fiorire di rapporti sociali conviviali in un mondo sano può
ottenersi con serenità nella frugalità, nella sobrietà e addirittura con una certa austerità nel consumo
materiale.
La parola d’ordine della decrescita ha soprattutto come fine il segnare con fermezza l’abbandono
dell’obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la
ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale. Evidentemente, non si prefigge un
rovesciamento caricaturale che consisterebbe nel raccomandare la decrescita per la decrescita.
In particolare, la decrescita non è la crescita negativa. Si sa che il semplice rallentamento della
crescita sprofonda le nostre società nel disordine con riferimento alla disoccupazione e
all’abbandono dei programmi sociali, culturali e ambientali che assicurano un minimo di qualità
della vita. Si può immaginare quale catastrofe sarebbe un tasso di crescita negativa! Allo stesso
modo non c’è cosa peggiore di una società lavoristica senza lavoro e, peggio ancora, di una società
della crescita senza crescita. La decrescita è dunque auspicabile soltanto in una «società di
decrescita». Ciò presuppone tutt’altra organizzazione in cui il tempo libero è valorizzato al posto
del lavoro, dove le relazioni sociali prevalgono sulla produzione e sul consumo dei prodotti inutili o
nocivi. La riduzione drastica del tempo dedicato al lavoro, imposta per assicurare a tutti un impiego
soddisfacente, è una condizione preliminare. Ispirandosi alla carta su «consumi e stili di vita»
proposta al Forum delle ONG di Rio, è possibile sintetizzare il tutto in un programma di sei «R»:
rivalutare, ristrutturare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Questi sono i sei obiettivi
interdipendenti un circolo virtuoso di decrescita conviviale e sostenibile. Rivalutare significa
rivedere i valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita, nonché cambiare i
valori che devono essere cambiati. Ristrutturare significa adattare la produzione e i rapporti sociali
in funzione del cambiamento dei valori. Per ridistribuire s’intende la ridistribuzione delle ricchezze
e dell’accesso al patrimonio naturale. Ridurre vuol dire diminuire l’impatto sulla biosfera dei nostri
modi di produrre e di consumare. Per fare ciò bisogna riutilizzare gli oggetti e i beni d’uso invece di
gettarli e sicuramente riciclare i rifiuti non compressibili che produciamo.
Tutto ciò non è necessariamente antiprogressista e antiscientifico. Si potrebbe, nello stesso tempo,
parlare di un’altra crescita in vista del bene comune, se il termine non fosse troppo alternativo.
Noi non rinneghiamo la nostra appartenenza all’Occidente, di cui condividiamo il sogno
progressista, sogno che ci ossessiona. Tuttavia, aspiriamo a un miglioramento della qualità della
vita e non a una crescita illimitata del PIL. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, la
purezza delle falde freatiche e l’accesso all’acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli
oceani. Esigiamo un miglioramento dell’aria che respiriamo, del sapore degli alimenti che
mangiamo. C’è ancora molta strada da fare per lottare contro l’invasione del rumore, per ampliare
gli spazi verdi, per preservare la fauna e la flora selvatiche, per salvare il patrimonio naturale e
culturale dell’umanità, senza parlare dei progressi da fare nella democrazia. La realizzazione di
questo programma è parte integrante dell’ideologia del progresso e presuppone il ricorso a tecniche
sofisticate alcune delle quali sono ancora da inventare. Sarebbe ingiusto tacciarci come tecnofobi e
antiprogressisti con il solo pretesto che reclamiamo un «diritto di inventario» sul progresso e sulla
tecnica. Questa rivendicazione è un minimo per l’esercizio della cittadinanza.
Semplicemente, per i paesi del Sud, colpiti in pieno dalle conseguenze negative della crescita del
Nord, non si tratta tanto di decrescere (o di crescere, d’altra parte), quanto di riannodare il filo della
loro storia rotto dalla colonizzazione, dall’imperialismo e dal neoimperialismo militare, politico,
economico e culturale. La riappropriazione delle loro identità è preliminare per dare ai loro
problemi le soluzioni appropriate. Può essere sensato ridurre la produzione di certe colture destinate
all’esportazione (caffè, cacao, arachidi, cotone ecc., ma anche fiori recisi, gamberi di allevamento,
frutta e verdure come primizie ecc.), come può risultare necessario aumentare la produzione delle
colture per uso alimentare. Si può pensare inoltre a rinunciare all’agricoltura produttivista come al
Nord per ricostituire i suoli e le qualità nutrizionali, ma anche, senza dubbio, fare delle riforme
agrarie, riabilitare l’artigianato che si è rifugiato nell’informale ecc. Spetta ai nostri amici del Sud
precisare quale senso può assumere per loro la costruzione del doposviluppo.
In nessun caso, la rimessa in discussione dello sviluppo può ne deve apparire come una impresa
paternalista e universalista che la assimilerebbe a una nuova forma di colonizzazione (ecologista,
umanitaria…) Il rischio è tanto più forte in quanto gli ex colonizzati hanno interiorizzato i valori del
colonizzatore. L’immaginario economico, e in particolare l’immaginario dello sviluppo, è senza
dubbio ancora più pregnante al Sud che al Nord. Le vittime dello sviluppo hanno la tendenza a non
vedere altro rimedio alle loro disgrazie che un aggravarsi del male. Penano che l’economia sia il
solo mezzo per risolvere la povertà quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l’economia
sono il problema e non la soluzione; continuare a pretendere e volere il contrario fa parte del
problema.
Una decrescita accettata e ben meditata non impone alcuna limitazione nel dispendio di sentimenti e
nella produzione di una vita festosa o addirittura dionisiaca.
Sopravvivere localmente
Si tratta di essere attenti al reperimento delle innovazioni alternative: imprese cooperative in
autogestione, comunità neorurali, LETS e SEL3, autorganizzazione degli esclusi del Sud. Queste
esperienze che noi intendiamo sostenere o promuovere ci interessano non tanto per se stesse, quanto
come forme di resistenza e di dissidenza al processo di aumento della mercificazione totale del
mondo. Senza cercare di proporre un modello unico, noi ci sforziamo di realizzare in teoria e in
pratica una coerenza globale dell’insieme di queste iniziative.
Il pericolo della maggior parte delle iniziative alternative è, in effetti, di chiudersi nella nicchia che
hanno trovato all’inizio invece di lavorare alla costruzione e al rafforzamento di un insieme più
vasto. L’impresa alternativa vive o sopravvive in un ambiente che è e dev’essere diverso dal
mercato mondializzato. È questo ambiente dissidente che bisogna definire, proteggere, conservare,
rinforzare sviluppare attraverso la resistenza. Piuttosto che battersi disperatamente per conservare la
propria nicchia nell’ambito del mercato mondiale, bisogna militare per allargare e approfondire una
vera società autonoma ai margini dell’economia dominante.
Il mercato mondializzato con la sua concorrenza accanita e spesso sleale non è l’universo dove di
muove e deve muoversi l’organizzazione alternativa. Essa deve cercare una vera democrazia
associativa per sfociare in una società autonoma. Una catena di complicità deve legare tutte le parti.
Come nell’informale africano, nutrire la rete dei «collegati» è la base del successo. L’allargamento
e l’approfondimento del tessuto di base è il segreto del successo e deve essere il primo pensiero
delle sue iniziative. È questa coerenza che rappresenta una vera alternativa al sistema.
Al Nord, si pensa prima ai progetti volontari e volontaristici di costruzione di mondi differenti.
Alcuni individui, rifiutando in tutto o in parte il mondo in cui vivono, tentano di mettere in atto
qualcos’altro, di vivere altrimenti: di lavorare o di produrre altrimenti in seno a imprese diverse, di
riappropriarsi della moneta anche per servirsene per un uso diverso, secondo una logica altra
rispetto a quella dell’accumulazione illimitata e dell’esclusione massiccia dei perdenti.
Al Sud, dove l’economia mondiale, con l’aiuto delle istituzioni di Bretton Woods, ha cacciato dalle
campagne milioni e milioni di persone, ha distrutto il loro modo di vita ancestrale, soppresso i loro
mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonvilles e nelle periferie Terzo mondo,
l’alternativa è spesso una condizione di sopravvivenza. I «naufraghi dello sviluppo», abbandonati a
loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire, non hanno scelta per restare a galla che
organizzarsi secondo un’altra logica. Devono inventare, e almeno alcuni inventano effettivamente,
un altro sistema, un’altra vita.
Questa seconda forma dell’altra società non è totalmente separata dalla prima, e ciò per due ragioni.
Innanzitutto, perché l’autorganizzazione spontanea degli esclusi del Sud non è mai totalmente
spontanea. Ci sono aspirazioni, progetti, modelli, o anche utopie che informano più o meno questi
«fai da te» della sopravvivenza informale. Poi, perché, simmetricamente, gli «alternativi» del Nord
non sempre hanno possibilità di scegliere. Anch’essi sono spesso degli esclusi, degli abbandonati,
dei disoccupati o candidati potenziali alla disoccupazione, o semplicemente degli esclusi per
disgusto… Ci sono dunque possibilità di contatto tra le due forme che possono e devono fecondarsi
reciprocamente. Questa coerenza d’insieme realizza un certo modo, certi aspetti che François
Partant attribuiva alla sua proposta centrale:
dare a dei disoccupati, a dei contadini rovinati e a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di vivere del loro lavoro,
producendo, al di fuori dell’economia di mercato e nelle condizioni da loro stessi determinate, ciò di cui ritengono di
aver bisogno.
Rafforzare la costruzione di tali altri mondi possibili passa per la presa di coscienza del significato
storico di queste iniziative. Numerose sono già state le riconquiste da parte delle forze dello
sviluppo delle imprese alternative isolate, e sarebbe pericoloso sottovalutare le capacità di recupero
del sistema. Per contrastare la manipolazione e il lavaggio del cervello permanente a cui siamo
sottoposti, la costruzione di una vasta rete sembra essenziale per condurre la battaglia del buon
senso.



