di Giuseppe Genna
 Fausto Melotti pubblica nel 1975, per Adelphi, un sorprendente libro che è una compattissima e sbalorditiva deflagrazione della letteratura: si intitola Linee, procede per aforismi (che vengono via via teorizzati, nella loro forma “vibratoria”, secondo la definizione di Melotti stesso), poesie, dialoghi, addirittura canzonette. Non desidero intraprendere parallelismi, che non sono in grado né di sostenere né di fare coincidere all’infinito, tra la produzione artistica “figurale” (o “transfigurale”) di Fausto Melotti e la sua opera letteraria. Mi è consentito invece riportare un’impressione, per quanto epidermica e, per stare nel cerchio magnetico che lo stesso Melotti definisce “vibratorio”, intercettiva: Melotti supera l’arte (nelle sue eterne contraddizioni formali, contenutistiche, figurative) con un movimento di sussunzione (non di sintesi: per allontanare Melotti da ogni sistematica di ordine filosofico occidentale) che ha un corrispettivo identico nei modi in cui Melotti stesso supera la letteratura.
Fausto Melotti pubblica nel 1975, per Adelphi, un sorprendente libro che è una compattissima e sbalorditiva deflagrazione della letteratura: si intitola Linee, procede per aforismi (che vengono via via teorizzati, nella loro forma “vibratoria”, secondo la definizione di Melotti stesso), poesie, dialoghi, addirittura canzonette. Non desidero intraprendere parallelismi, che non sono in grado né di sostenere né di fare coincidere all’infinito, tra la produzione artistica “figurale” (o “transfigurale”) di Fausto Melotti e la sua opera letteraria. Mi è consentito invece riportare un’impressione, per quanto epidermica e, per stare nel cerchio magnetico che lo stesso Melotti definisce “vibratorio”, intercettiva: Melotti supera l’arte (nelle sue eterne contraddizioni formali, contenutistiche, figurative) con un movimento di sussunzione (non di sintesi: per allontanare Melotti da ogni sistematica di ordine filosofico occidentale) che ha un corrispettivo identico nei modi in cui Melotti stesso supera la letteratura.
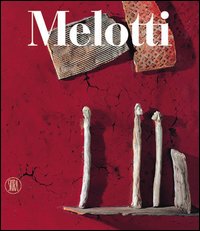 Questo movimento è un movimento di ordine spirituale. Per sgomberare definitivamente il discorso da ogni appiglio citazionista: qui non si parla dello spirituale dell’arte in termini che la storia dell’estetica ha almanaccato nei suoi tentativi di evasione dalla stessa materia dell’arte. Qui, ingaggiando il termine “spirituale”, si ricorre proprio a una tradizione che, per parte sua, con l’arte ha poco a che fare, ma con cui l’arte, per parte propria, ha molto a che fare: è la tradizione che connette le grandi Scritture Sacre e che, rispetto ai nostri referenti storici e geografici più prossimi, risale direttamente a Platone e a Plotino, a Ficino e a Bruno. E’ perciò imbarazzante mettersi a parlare di trascendenza o di immanenza a proposito del lavoro di Melotti. Occorre un atteggiamento estetico che non è più estetico, ma che risulta ugualmente rigoroso e, se proprio non si può fare a meno della presenza di quest’ingombrante aggettivo, scientifico: il rigore e la scientificità del giudizio sull’opera melottiana sono assicurati dal fatto che la sostanza della sua arte è ciò che causa il giudizio rigoroso e scientifico. Si tratta della sostanza stessa della scienza e dell’estetica, còlta e percepita (poiché è possibile percepirla) prima che essa si cristallizzi in forma di scienza e di estetica.
Questo movimento è un movimento di ordine spirituale. Per sgomberare definitivamente il discorso da ogni appiglio citazionista: qui non si parla dello spirituale dell’arte in termini che la storia dell’estetica ha almanaccato nei suoi tentativi di evasione dalla stessa materia dell’arte. Qui, ingaggiando il termine “spirituale”, si ricorre proprio a una tradizione che, per parte sua, con l’arte ha poco a che fare, ma con cui l’arte, per parte propria, ha molto a che fare: è la tradizione che connette le grandi Scritture Sacre e che, rispetto ai nostri referenti storici e geografici più prossimi, risale direttamente a Platone e a Plotino, a Ficino e a Bruno. E’ perciò imbarazzante mettersi a parlare di trascendenza o di immanenza a proposito del lavoro di Melotti. Occorre un atteggiamento estetico che non è più estetico, ma che risulta ugualmente rigoroso e, se proprio non si può fare a meno della presenza di quest’ingombrante aggettivo, scientifico: il rigore e la scientificità del giudizio sull’opera melottiana sono assicurati dal fatto che la sostanza della sua arte è ciò che causa il giudizio rigoroso e scientifico. Si tratta della sostanza stessa della scienza e dell’estetica, còlta e percepita (poiché è possibile percepirla) prima che essa si cristallizzi in forma di scienza e di estetica.
Proprio quest’affermazione, che peraltro garantisco non essere in nulla fideistica o messianicamente sconvolgente, dà corpo a una tesi che cercherò di chiarire: Melotti effettua un tentativo di superare l’estetica, di andare oltre l’estetica, ma in senso causale, entrando nel regno della percezione sottile, dello spirito che si fa carne, dell’indifferenziato muto che non è per nulla muto, ma che lo sembra, poiché la nostra percezione ordinaria e grossolana non si è ancora orientata a coglierne l’infinitudine di variazioni e significati. Il superamento dell’arte tentato da Melotti introduce alla prospettiva che udire o leggere quei “significati vibratori” è soltanto questione di tempo, cioè di nulla: siamo pronti a percepire l’universo sottile della sostanza di coscienza nel suo stato liquido, antecedente al suo depositarsi in noi in forma di pensiero.
I momenti decisivi della svolta artistica, ma direi di tutta la svolta umanistica, sono per tradizione confusi, difficilmente categorizzabili: soprattutto se si cerca di definire un’eventuale svolta da posizione prossimale, essendole contemporanei. Gli equivoci e le incomprensioni che i contemporanei di Petrarca proiettarono o ricavarono dalla sua colossale opera di risistemazione della cultura occidentale furono, in questo senso, non soltanto giustificabili a posteriori, ma addirittura euristici, per una felicissima serendipity attraverso la quale procede la storia dello spirito umano: salti, deviazioni, sbagli, misinterpretazioni che fanno fruttare altri stati germinali. Il caso di Leopardi è significativo, visto che ancora non abbiamo potuto osservare la fioritura di deviazioni fruttuose dal suo abissale e sconvolgente affondo. Non intendo, ovviamente, affermare che l’importanza letteraria di Melotti per la cultura italiana sia equivalente a quella che esercitarono Petrarca o Leopardi. Certo è che la sua opera – e la critica, oltre che il mercato dell’arte, sta accorgendosi di questo in maniera clamorosa oggidì – sembra avere attinenze con l’influenza, determinante per il nostro Novecento letterario e linguistico, che la poesia di Montale ha espresso nel corso del secolo passato. Montale innova una lingua esaurita, ma non riesce a penetrare ideologicamente nel tessuto connettivo del secolo. Melotti non influenza la lingua, ma ciò che raggiunge influenza in maniera determinante l’ideologia artistica che oggi è pronta ad avere rappresentazione: anzi, come chiarirò, è pronta a superare la rappresentazione.
Che cosa sarebbe quest’antideologia che oggi, prescindendo dalla conoscenza dell’opera di Melotti epperò da lui anticipata, si fa largo come la scoperta e la sensibilità dilagante nella creazione artistica contemporanea? E’, se si vuole, una lezione antichissima che Holderlin aveva impartito con lo slogan “seconda vita”. La “seconda vita” dell’opera è un piano a cui pochi e profondissimi genii riescono a pervenire e quasi nessuno dei loro contemporanei coglie in ciò che hanno fatto. Senza mezzi termini: essa è la vita di ciò che anticipa la sensibilità estetica, il giudizio scientifico, la forma concreta del pensiero. E’ un regno incontaminato, che lo scrittore Robert Walser caratterizza con tautologie inquietanti e incantevoli, e che Andrea Zanzotto ha raggiunto nella sua catabasi naturali ne La beltà , ne Il galateo in bosco e in Fosfeni. Qui non c’è più soltanto la forma, sebbene ci sia la coscienza. E’ qualcosa di molto diverso dalla retorica dello spazio bianco generata dall’ermeneutica. E’ distante dalla teoria del lapsus o da quella del trauma immaginario avanzata da Freud. Non c’entra nulla con l’intrattenimento infinito di Blanchot, e nemmeno con l’indefinibile itinerario simbolico di Lacan. Momenti simili della teoresi filosofica e letteraria del nostro recente passato si iscrivono, per così dire, in un àmbito orizzontale: sono squarci che si aprono sul foglio, ma che non portano a piani successivi — magari conducono al foglio sottostante, ma nulla di più.
Ciò che Melotti compie sul piano letterario e soprattutto sul piano plastico, invece, è un’opera al bianco che imprime un salto di qualità alla rappresentazione artistica. Date tutte le forme, non contano più le forme. Non contano più i pieni o i vuoti del testo, sebbene la prestidigitazione venga raggiunta proprio grazie ai ritmi esercitati con la pagina. E’, come annota lo stesso Melotti, una “vibrazione” di fondo. E’ uno sfondo. E – questo è il fantastico — si tratta di uno sfondo percepibile. E’ un ganzfeldt indicibile ma sensibile, il che è di per sé sorprendente, poiché la percezione, in questo caso, prescinde da qualunque organo di percezione. Non si ascolta, non si tocca, non si vede, non si odora. Non ha nulla a che fare col miracolo sinestesico a cui giunge qualunque grande scrittore. Ha molto a che vedere, invece, con i vertici della narrativa di Thomas Pynchon, per esempio col “volto bianco di Katje, uno zero assoluto” ne L’arcobaleno della gravità: non casualmente, un altro scrittore a cui gli ingegneri statunitensi hanno tributato convegni, visto il suo discorso sotterraneo, di ordine matematico e statistico, esattamente come accaduto a Melotti, ingegnere laureato al Politecnico di Milano.
Tutto ciò è noto a coloro che hanno lungamente meditato circa il fantastico nell’arte: cioè, circa i fantasmi. E’ ciò che si dice spirituale: totale inappartenenza alle categorie dialettiche che oppongono figura e non-figura, necessità e libertà, stasi e movimento, causa ed effetto e, infine, immanenza e trascendenza.
Se io mi mettessi ad applicare una categoria critica che i critici italiani, quasi tutti di matrice stilistica, si guardano bene dall’utilizzare, potrei utilizzare il repertorio di Warburg e dei suoi allievi, che dimostrano l’evenienza di immagini e simboli secondo un’aggressione che lo spirito porta contro la mente umana, attraverso il continuo ripresentarsi di forme che, a questo punto, non condividono alcunché con gli archetipi (infatti Warburg le definisce pathosforme). Se io effettuassi una ricerca à la Warburg sull’opera transfigurativa di Melotti sono certo che rinverrei tracce e presenze delle stazioni simboliche che alludono o realizzano la Grande Opera alchemica, come del resto accade in Brancusi, un artista che percepisco assai convergente rispetto alla traiettoria dello scultore italiano. La sensazione che le opere di Melotti siano identiche a certe opere del tantrismo indiano del settimo secolo è sconcertante: ci sentiremmo di affermare che il tantrismo indiano del settimo secolo è astratto o simbolico? Queste categorie critiche non reggono più, in arte come in letteratura, ed è venuto il momento di affermarlo con forza. Si trapassa in una zona in cui non ha senso nemmeno parlare di arcaico o di contemporaneo: qui siamo a contatto con la gelida e bruciante sostanza del pensiero vivo, ciò che la coscienza è prima di depositarsi nei fossili formali del pensiero e che è dopo essere stata assoluto.
Le finte allegorie di Parmenide, i finti miti platonici (ma direi: i finti dialoghi platonici), le finte figurazioni di Ficino e di Bruno, i finti epigrammi di Scardanelli-Holderlin, le finte figure retoriche di Leopardi, la finta matematica di Guénon, i finti raccontini di Walser, i finti emblemi di Kafka, le finte variazioni transfigurali — artistiche e letterarie — di Fausto Melotti: tutte queste finte rappresentazioni, che sconquassano la forma stessa di ogni plausibile rappresentazione o negazione della stessa, altro non sono che, per dirla con Melotti, “canali vibratori”, porte d’accesso per coscienze dedite al superamento di sé in se stesse o, come annotava Agostino, impegnate a “noli foras ire, in interiore homine habitat veritas” (un aforisma a cui sembra avere attinto lo stesso Melotti).
Le Linee di Fausto Melotti ribadiscono proprio questa possibilità: nell’interiorità dell’uomo abita la verità. Beninteso: non la nostra verità, ma la verità tout court – una verità che non esiste. Di solito, chi non è abituato a cercare il buco nero che permette di percepire la “seconda vita” dell’opera, si ferma a questo punto e dice: “Qui siamo in presenza di un religioso, di uno spiritualista. Aspettiamo un attimo, e costui ci dirà che Dio esiste”. Questo, di solito, è il muro di gomma di uno che non accederà mai in vita sua alla “seconda vita” che è il significato più autentico dell’opera di Fausto Melotti: cioè, la possibilità di uscita da ogni significato formalizzabile. Se invece ci si inabissa concretamente — ed è possibile farlo — in questa fenditura holderliniana della “seconda vita” (corrispondente esattamente allo spazio che sta tra pensiero e pensiero) la grammatica è un’altra, la critica si rivoluziona, l’alfabeto di riferimento cambia e, finora ma presto ci riuscirà, la scienza stessa non riesce a parlare. Spazio apparentemente vuoto, e invece più pieno di quello in cui ci illudiamo di risiedere, questa zona di coscienza per ora indifferenziata può essere soltanto sentita. Cambiano le percezioni, ma la cosa è sempre identica a sé. Per questo esiste una scienza che si occupa di questa zona, con estremo rigore e indefettibile precisione. Questa scienza, è la scienza delle opere di immaginario, che noi conosciamo con un nome diverso: quello di “grande arte”.



