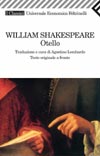 di Alessandro Portelli
di Alessandro Portelli
Agostino Lombardo, uno dei più grandi studiosi italiani di letteratura inglese, magistrale traduttore e critico shakespeariano, fondatore degli studi americani nell’università italiana, è morto il 23 gennaio scorso a Roma. Dell’anglista e del filologo shakespeariano dovranno parlare altri. Io voglio raccontare il mio Agostino Lombardo, con cui ho condiviso le passioni americane. Perché dobbiamo soprattutto a lui se gli studi americani in Italia hanno una prevalente impronta democratica e di sinistra, e se abbiamo imparato a essere critici anche feroci dell’America senza diventare mai banalmente antiamericani.
Correva l’anno 1970. Io uscivo di soppiatto dall’ufficio dove allora lavoravo per andare all’università e sentire le lezioni di Agostino Lombardo – i racconti di Hawthorne, Moby Dick, il romanzo inglese del dopoguerra, la lettura del Macbeth… Un giorno, come allora accadeva, entrarono in classe dei compagni, annunciarono un’altra tragedia in Vietnam e chiesero molto civilmente di interrompere le lezioni. Molto civilmente, Agostino Lombardo rispose che il suo modo di rispondere a quegli orrori era di fare con serietà e impegno il proprio lavoro. Fummo in due ad alzarci e uscire lo stesso dall’aula. Ma capii subito che aveva ragione anche lui, e me l’ha confermato nei trenta e più anni in cui è stato maestro, qualche volta antagonista, sempre punto di riferimento per me, e per generazioni intere dell’anglistica e dell’americanistica più vivaci.
Non ho conosciuto mai nessuno che come Agostino Lombardo avesse il senso delle istituzioni e dell’università come servizio, un servizio per la società nel suo complesso e per gli studenti nell’immediato. Per questo, insegnare – lavorare – era un atto politico, una testimonianza per una società più responsabile, più seria – una democrazia fondata sul lavoro. Per questo, chiedergli di interrompere la lezione era ai suoi occhi la stessa cosa che chiedergli di smettere di fare politica, di smettere di esistere (e per questo è stato uno dei pochi professori che ascoltarono il `68 e – senza demagogie, con qualche turbamento – lo accettarono). Così, anche se ha continuato fino alla fine a venire all’università, a insegnare e a tradurre, tuttavia la pensione, la fine della sua vita istituzionale di lavoro, è stata una privazione forse insopportabile.
Questo senso quasi di missione si vedeva nella passione didattica, nel modo in cui riusciva a trasmettere, a noi che l’ascoltavamo, il suo amore per Joyce o Melville – tanto più che era sorretto da un’idea alta, certo tradizionale ma solidissima, della cultura, della letteratura, del teatro come spazi di libertà e di critica. Questo approccio lo riversava soprattutto nello studio della letteratura americana, che fu il primo a insegnare in Italia all’università. Sosteneva che tutta la cultura letteraria americana è cultura critica, di opposizione; e per questo insisteva sul fatto che più di quella inglese la letteratura americana andava letta nei suoi rapporti con la storia, con la società, con le culture popolari, le culture di minoranza. Io la vedevo un po’ più complicata; ma è grazie a questa sua convinzione che dentro la “letteratura” è stato possibile farci rientrare – all’inizio degli anni `70, quando non andava di moda – Woody Guthrie e il blues.
L’avevo conosciuto nel 1970, dopo un viaggio in America alla ricerca del Black Power, da cui mi ero portato dietro un carico, magari un sovraccarico, di certezze contestative e “correttezze politiche.” Agostino Lombardo di queste cose non si occupava, ma mi diede subito ascolto e spazio; e fu lui a organizzare tra il 1969 e il 1970, per la prima volta nella nostra università, un memorabile seminario biennale sulla letteratura afroamericana, in cui chiamò tutti, docenti e studenti, a confrontarsi con quell’esperienza, a leggere quei testi. Non si allontanò mai dai suoi interessi fondanti – i classici, Shakespeare, quello che abbiamo cominciato a chiamare il “canone” – e da un suo approccio critico sospettoso verso le novità teoriche e metodologiche e le superficiali interdisciplinarità. Ma apriva porte, creava spazi, ascoltava voracemente. Fu tra i primi a accogliere le letterature postcoloniali come terreno di ricerca e di insegnamento. Non se ne occupava direttamente, tuttavia sapeva riconoscere subito, anche in questi ambiti, la qualità letteraria, e distingueva i grandi anche prima che fossero riconosciuti ufficialmente. Non pretendeva, come tanti baroni della sua generazione, che i suoi allievi fossero suoi cloni; la nostra diversità era la sua ricchezza; la sua solidità era il nostro polo Nord, a cui facevamo riferimento anche per prenderne le distanze, e ci dava la misura della strada percorsa.
Un giorno gli feci vedere un articolo su Woody Guthrie che avevo scritto sul manifesto , e lui mi disse, scherzando solo un po’, che non gli stava bene perché di Woody Guthrie si sarebbe dovuto parlare sull’Unità. Io gli dissi, ma come, se il primo a parlarne in Italia sono stato io, e io sono del manifesto (allora gruppo politico)? E lui: sì, ma in quale dipartimento lo hai fatto? Insomma: la pluralità di ricerche, di passioni, di approcci che nei suoi anni migliori ha vissuto nel dipartimento che lui ha fondato si deve al fatto che lui poi riassumeva tutto, un po’ baronalmente e un po’ paternamente, e non separava la sua passione universitaria dalla sua passione politica di comunista liberale.
Penso a quel giorno che aveva accettato di far tenere un incontro con un certo poeta canadese che lui non conosceva e si ritrovò l’aula 1 di lettere piena come un uovo, perché lo sconosciuto poeta canadese si chiamava Leonard Cohen e si era portato dietro la chitarra e gli studenti che lo conoscevano meglio di lui erano eccitatissimi, e lui contentissimo come se l’avesse saputo fin dall’inizio (però quando invitò Allen Ginsberg sapeva bene quello che faceva).
Per tutto questo, Agostino Lombardo è stato ancora più decisivo come insegnante che come critico. Un tempo, queste figure le chiamavano “maestro”. Era un intellettuale pubblico, animato da una grande voglia di comunicare, che aveva impresso alla sua vita due indirizzi fondamentali: il teatro e la traduzione. Era capace di far parlare i testi, renderli vivi, renderli accessibili (quando finalmente si decise a fare i conti con lo strutturalismo e i suoi dintorni, scrisse un memorabile saggio intitolato Il testo e la sua performance ). Il grande progetto a cui ha lavorato fino all’ultimo, naturalmente, era la traduzione integrale di Shakespeare.
Un giorno, non molto tempo fa, andai nel suo studio e gli dissi: guarda che tutto quello che ci hai insegnato era sbagliato. E lui, senza scomporsi – si scomponeva di rado: spiegami. Tu ci hai insegnato – gli dissi – che i grandi classici americani, Hawthorne, Melville, erano pieni di momenti di grande teatro (il palco della gogna nella Lettera scarlatta, il cassero della nave in Moby Dick) perché, in assenza del teatro nell’America puritana, la teatralità veniva assunta dal romanzo. Invece, ho scoperto che questi libri sono pieni di teatro perché i loro autori stavano a teatro dalla mattina alla sera: non c’era un grande teatro letterario, non c’era uno Shakespeare d’America (e neanche uno Sheridan, se è per questo), ma c’era una scena teatrale vivacissima (magari con Amleto mischiato a macchiette e avanspettacolo) e loro ne facevano parte e inevitabilmente la riversavano nella loro prosa. Gli raccontai che la prima strage operaia d’America, a New York nel 1852, era avvenuta a seguito di uno scontro su due diverse messe in scena di Macbeth. Un “barone” vero si sarebbe offeso; io sapevo che a lui si poteva parlare anche così. E fu contento lo stesso, perché comunque, per altra via, si confermava la sostanza della sua ipotesi: la centralità del teatro, e la centralità di Shakespeare. In un modo o nell’altro, Macbeth era davvero questione di vita e di morte.
[da il manifesto, 25.1.05]



