di Leonardo Colombati
 [Scrittore romano, Leonardo Colombati – nella foto a destra – è autore del monumentale e splendido Perceber, un iper-romanzo à la Pynchon che è in uscita a febbraio 2005 presso l’editore Sironi, e a cui Carmilla on line darà ampio risalto. L’intervento che qui sotto pubblichiamo è tratto dal blog di Colombati]
[Scrittore romano, Leonardo Colombati – nella foto a destra – è autore del monumentale e splendido Perceber, un iper-romanzo à la Pynchon che è in uscita a febbraio 2005 presso l’editore Sironi, e a cui Carmilla on line darà ampio risalto. L’intervento che qui sotto pubblichiamo è tratto dal blog di Colombati]
Nel ’44 i partigiani non cantavano ancora Bandiera rossa ma un brano di Raffaelli e De Freo:
 Figli dell’officina, o figli della terra
Figli dell’officina, o figli della terra
già l’ora s’avvicina della più giusta guerra,
la guerra proletaria, guerra senza frontiere,
innalzeremo al vento bandiere rosse e nere!
Avanti, siam ribelli, fiori vendicator
d’un mondo di fratelli, di pace e di lavor!
Figli dell’officina non è ancora una “canzone di fabbrica” — anche perché questo genere non è mai esistito. È esistito, semmai un “romanzo di fabbrica”: a Torino, in Einaudi, Calvino ne riceveva decine di abbozzi, sul finire degli anni ’50; e nei Gettoni finì per pubblicarne qualcuno.
La cosiddetta “letteratura industriale” (che verrà “canonizzata” proprio da Calvino in un saggio dal titolo La “tematica industriale”, pubblicato nel 1962) ha partorito in Italia una serie di libri raramente buoni, in gran misura mortalmente noiosi. Tra i primi, sicuramente La chiave a stella di Primo Levi, che è però un caso atipico: innanzitutto per essere uscito, rispetto al periodo “aureo” del genere, fuori tempo massimo, e cioè nel 1978; e poi perché la vicenda di Tino Faussone che lascia la catena di montaggio per girare il mondo costruendo impianti, ponti e gru è troppo allegra ed ottimista per poterla inserire nel solco tracciato da certi polverosissimi romanzi di Bianciardi, Ottieri e Volponi. 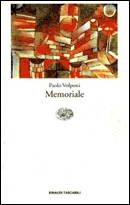 Quest’ultimo, sin dal suo esordio, Memoriale (1962), è stato per certi versi il traghettatore della letteratura “politica” dalla dimensione della civiltà contadina a quella industriale post-boom, con i suoi ritratti di operai travolti dall’ingranaggio oppressivo e totalizzante della fabbrica. L’anarchico e visionario protagonista del suo libro più famoso, La macchina mondiale (1965), è una sorta di antagonista della civiltà contemporanea: neoluddista lo chiameremmo noi, oggi. E Albino Saluggia (l’io narrante del romanzo d’esordio) è un operaio schiacciato anche fisicamente dalla disumanità del lavoro; la malattia inciderà sul suo rendimento e inevitabilmente egli sarà licenziato. La fabbrica in cui è ambientato il racconto è in Piemonte. Facile riconoscervi l’Olivetti di Ivrea, dove Volponi per vent’anni arrivava alle otto del mattino, difendeva gli interessi del padrone con metodo, tenacia ed inflessibilità dall’alto della sua carica di direttore del personale, e ne usciva alle otto di sera per rileggere Il capitale. In Olivetti (l’azienda che credeva nei manager intellettuali: Pampaloni, Giudici, Fortini) lavorò brevemente anche Ottieri, che dal 1948 al 1958 tenne un diario pubblicato nel 1961 in lunghi brani sul quarto numero de Il Menabò — la rivista di Vittorini e Calvino — con il titolo Taccuino industriale (l’intero diario sarà pubblicato due anni dopo da Bompiani con il titolo La linea gotica).
Quest’ultimo, sin dal suo esordio, Memoriale (1962), è stato per certi versi il traghettatore della letteratura “politica” dalla dimensione della civiltà contadina a quella industriale post-boom, con i suoi ritratti di operai travolti dall’ingranaggio oppressivo e totalizzante della fabbrica. L’anarchico e visionario protagonista del suo libro più famoso, La macchina mondiale (1965), è una sorta di antagonista della civiltà contemporanea: neoluddista lo chiameremmo noi, oggi. E Albino Saluggia (l’io narrante del romanzo d’esordio) è un operaio schiacciato anche fisicamente dalla disumanità del lavoro; la malattia inciderà sul suo rendimento e inevitabilmente egli sarà licenziato. La fabbrica in cui è ambientato il racconto è in Piemonte. Facile riconoscervi l’Olivetti di Ivrea, dove Volponi per vent’anni arrivava alle otto del mattino, difendeva gli interessi del padrone con metodo, tenacia ed inflessibilità dall’alto della sua carica di direttore del personale, e ne usciva alle otto di sera per rileggere Il capitale. In Olivetti (l’azienda che credeva nei manager intellettuali: Pampaloni, Giudici, Fortini) lavorò brevemente anche Ottieri, che dal 1948 al 1958 tenne un diario pubblicato nel 1961 in lunghi brani sul quarto numero de Il Menabò — la rivista di Vittorini e Calvino — con il titolo Taccuino industriale (l’intero diario sarà pubblicato due anni dopo da Bompiani con il titolo La linea gotica).
 Nella musica leggera italiana non c’è alcun Paolo Volponi. Rimane, però, una manciata di canzoni; e un album, Mio caro padrone domani ti sparo. Quest’ultimo fu non a caso pubblicato nel 1969, in autunno; quell’autunno. Il suo autore, Paolo Pietrangeli, era già noto per avere offerto un anno prima tre canzoni come colonna sonora del movimento studentesco: Valle Giulia, Rossini e soprattutto Contessa, scritta nel 1966:,
Nella musica leggera italiana non c’è alcun Paolo Volponi. Rimane, però, una manciata di canzoni; e un album, Mio caro padrone domani ti sparo. Quest’ultimo fu non a caso pubblicato nel 1969, in autunno; quell’autunno. Il suo autore, Paolo Pietrangeli, era già noto per avere offerto un anno prima tre canzoni come colonna sonora del movimento studentesco: Valle Giulia, Rossini e soprattutto Contessa, scritta nel 1966:,
“Che roba contessa, all’industria di Aldo
han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti;
volevano avere i salari aumentati,
gridavano, pensi, di esser sfruttati.
E quando è arrivata la polizia
quei pazzi straccioni han gridato più forte,
di sangue han sporcato il cortile e le porte,
chissà quanto tempo ci vorrà per pulire…”.
Compagni, dai campi e dalle officine
prendete la falce, portate il martello,
scendete giù in piazza, picchiate con quello,
scendete giù in piazza, affossate il sistema.
Voi gente per bene che pace cercate,
la pace per far quello che voi volete,
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra,
vogliamo vedervi finir sotto terra,
ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato,
nessuno più al mondo dev’essere sfruttato.
“Sapesse, mia cara che cosa mi ha detto
un caro parente, dell’occupazione;
che quella gentaglia rinchiusa lì dentro
di libero amore facea professione…
Del resto, mia cara, di che si stupisce?
Anche l’operaio vuole il figlio dottore
e pensi che ambiente che può venir fuori:
non c’è più morale, contessa…”
Se il vento fischiava ora fischia più forte,
le idee di rivolta non sono mai morte;
se c’è chi lo afferma non state a sentire,
è uno che vuole soltanto tradire;
se c’è chi lo afferma sputategli addosso:
la bandiera rossa ha gettato in un fosso.
Voi gente per bene che pace cercate,
la pace per far quello che voi volete,
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra,
vogliamo vedervi finir sotto terra,
ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato,
nessuno più al mondo dev’essere sfruttato.
Classe 1948, iscritto alla FGCI dal 1963, Pietrangeli non replicò più il successo che incontrò in quegli anni caldi. Il suo secondo album, Karlmarxstrasse (1974), vendette pochissimo. Per tutti gli anni Settanta continuò a fare serate a pugno chiuso nelle feste di partito e dischi in cui mescolava il Trattato di semiologia di Umberto Eco a prolisse analisi della lotta di classe. Si riciclò nel cinema: prima come aiuto regista di Visconti, Zurlino e Bolognini, poi come regista (suo è Porci con le ali). Da più di vent’anni è il regista del Maurizio Costanzo Show.
 Di otto anni più vecchio è il lucchese Ivan Della Mea. Anche lui fa il suo esordio nel 1966 con l’album Io so che un giorno, in cui è inclusa O cara moglie:
Di otto anni più vecchio è il lucchese Ivan Della Mea. Anche lui fa il suo esordio nel 1966 con l’album Io so che un giorno, in cui è inclusa O cara moglie:
O cara moglie stasera ti prego,
di’ a mio figlio che vada a dormire
perchè le cose che io ho da dire
non sono cose che deve sentire.
Proprio stamane, là sul lavoro,
con il sorriso del caposezione
mi è arrivata la liquidazione:
mi han licenziato senza pietà.
E la ragione è perchè ho scioperato,
per la difesa dei nostri diritti,
per la difesa del mio sindacato,
del mio lavoro e della libertà.
Quando la lotta è di tutti per tutti,
il padrone vedrai cederà;
se invece vince è perchè i crumiri
gli dan la forza che lui non ha.
Questo si è visto davanti ai cancelli:
noi si chiamava i compagni alla lotta,
quando il padrone fa un cenno, una mossa:
l’un dopo l’altro cominciano a entrare.
O cara moglie dovevi vederli!
Quei poveretti facevano pena,
ma dietro a loro il porco padrone…
Li ho maledetti senza pietà.
O cara moglie io prima ho sbagliato:
di’ a mio figlio che venga a sentire.
Deve capire che cosa vuol dire
lottare per la libertà.
Bisogna attendere quasi dieci anni per trovare nuove canzoni che parlino di fabbrica. Dieci anni in cui in fabbrica è successo di tutto. In un libricino uscito per Einaudi nel 1976, Lotte operaie e ambiente di lavoro: Mirafiori 1968-1974, Alfredo Milanaccio e Luca Ricolfi descrivevano minuziosamente le lavorazioni di verniciatura che venivano eseguite nell’officina 54 di Mirafiori. Le scocche delle Fiat 500, 850, 126, 127, 124 e 132 passavano in due circuiti distinti: mano di fondo e mano di smalto.
La mansione della mano di fondo è svolta da 1 operaio. Con un punteruolo apre i fori nel fondo della scocca: questi fori serviranno, nelle operazioni successive, a far defluire dal fondo della scocca l’acqua dei lavaggi. (…) Inoltre questo operaio esegue una grossolana pulitura dell’interno e blocca, con ganci, le portiere in posizione “socchiusa”. (…) La cadenza è, in media, di 73-75 scocche-ora. (…) Più avanti 5 operai compiono la pulitura della scocca. Con pennelli intinti in secchi che contengono eptano e deossidina tolgono le macchie (di grasso, di sporco, ecc.) che sono rimaste dalle lavorazioni precedenti. Questi operai lavorano sopra un vascone grigliato, che si trova a 30-40 centimetri sotto il pavimento, in cui si raccolgono e da cui defluiscono, insieme con l’acqua, i solventi e gli acidi usati per la pulitura. Il mascone e i secchi (aperti) provocano un’alta concentrazione di solventi in sospensione; l’acqua, molta umidità. Non ci sono aspiratori.
Nei primi mesi del 1970 alla 54 iniziano le lotte. I verniciatori prima richiedono un aumento del salario poi spostano il problema direttamente sulla nocività. La vertenza viene chiusa provvisoriamente con l’accordo concluso il 5 agosto 1971, riguardante l’ambiente di lavoro. È un risultato importante, vista l’assoluta rigidità della Fiat in tema di condizioni ambientali. Ecco i principali sintomi lamentati dai verniciatori della 54: difficoltà di digestione, mal di testa, irritazione agli occhi, congiuntivite cronica, laringotracheite, artriti, reumatismi, eczemi, disturbi all’udito, nausee, dermatiti, tremori, bronchiti.
Nel 1974 esce nelle sale cinematografiche un nuovo film di Monicelli, Romanzo popolare. Il non più giovane operaio milanese Giulio Basletti (Ugo Tognazzi) sposa la sua figlioccia diciottenne, Vincenzina Rotunno (Ornella Muti), originaria di Montecagnano in provincia di Avellino. Sindacalista, politicamente impegnato, Giulio si fa il mazzo in fabbrica per assicurare alla splendida mogliettina un appartamento nuovo, il frigorifero, la tv e la 750. Entra in scena, però, il poliziotto Pizzuto Giovanni (Michele Placido): è giovane e terrone come Vincenzina e tra i due sboccia la simpatia. Seguono l’adulterio, la lettera anonima, la gelosia, la cacciata dell’adultera pentita. Giulio andrà in pensione; il poliziotto si farà una famiglia; e Vincenzina verrà inghiottita dalla fabbrica, “normalizzandosi” come anonima operaia milanesizzata.
Romanzo popolare, scritto da Monicelli con la coppia Age-Scarpelli, rifugge dal realismo per puntare tutto sul melodramma. È essenzialmente una commedia. Gli spunti “naturalistici” vengono dalla koiné linguistica usata dai protagonisti, un miscuglio di cadenze lombarde, dialetti meridionali e gergo calcistico. Grandi artefici di questa lingua posticcia sono Beppe Viola ed Enzo Jannacci. Quest’ultimo firma la canzone che fa da colonna sonora al finale del film.
Vincenzina davanti alla fabbrica…
Vincenzina, il foulard non si mette più…
Una faccia davanti a un cancello che si apre già.
Vincenzina, hai guardato la fabbrica
come se non c’è altro che fabbrica
e hai sentito anche odor di pulito e la fatica, dentro là.
«Zero a zero anche ieri ‘sto Milan qui,
‘sto Rivera che ormai non mi gioca più.
Che tristezza! il padrone non c’ha neanche ‘sti problemi qui».
Vincenzina davanti alla fabbrica…
Vincenzina vuol bene alla fabbrica
e non sa che la vita giù in fabbrica non c’è
com’è?
cos’è?
Finalmente, in Vincenzina e la fabbrica, quest’ultima smette di essere soltanto un simbolo. Non c’è più quel tono di rivendicazione a tutti i costi; ma solo il ritratto di un’operaia. Il proletario non parla più con Marx e Marcuse sottobraccio — così come falsamente pretendevano certi frequentatori del Canzoniere italiano. Egli è inconsapevole. E in ciò sta il dramma. In più, qui ci si libera del rischio dello stereotipo, attraverso la costruzione di una protagonista femminile.
In quegli anni, si sa, il femminismo conosce il suo apogeo. E nel mondo delle sette note irrompe Anna Identici. Nata come cantante acqua e sapone — il classico prodotto sanremese — in riviera si presenta sei volte, dal 1966 al 1973, con canzoncine sciape come gli stessi titoli danno ad intendere: Una rosa da Vienna, Quando m’innamoro, Era bello il mio ragazzo… Poi, di colpo, la “conversione”. Andando incontro ad un sicuro suicidio commerciale, la Identici pubblica sette album dedicati a rivisitazioni di canzoni popolari e a vere e proprie “operine” dedicate alla condizione femminile. I testi sono tutti di Pier Paolo Preti, le musiche di Gianni Guarnirei. Il brano più noto, del 1975, è Amore stanco, amore d’officina:
Amore stanco, amore d’officina,
amore che si spegne goccia a goccia
mentre corre veloce la catena
e tu perdi ogni giorno un po’ di noi.
Amore stanco, amore che la sera
non sa più ritrovare il suo sorriso,
ci guardiamo dietro l’ultimo boccone,
ma troppo stanchi per vederci ancora.
Amore stanco, che abbiamo barattato
per il miraggio di una vita bella…
e resta un’etichetta sulla porta
come il coperchio di una bara vuota.
Amore stanco, povero amore mio,
sei costato soltanto un po’ di cuore;
forse per questo noi ti abbiamo ucciso
per qualche ora in più di straordinario.
Gli ultimi due versi sono un passo indietro rispetto al “naturalismo” di Jannacci. Molto, molto meglio, allora, giocare la carta “surrealista”, così come fecero Lucio Dalla e il poeta Roberto Roversi costruendo quel capolavoro di album che fu Automobili. Qui il “toro” (la Fiat) è finalmente preso per le corna e spernacchiato per bene, come nella strepitosa Intervista con l’avvocato:
Buongiorno, grazie Avvocato,
sono del Manchester Guardian.
Non le farò perdere tempo;
questa la prima domanda:
la Fiat nella sola Torino
ha centoventimila operai,
quindicimila le industrie
legate a questo destino.
L’aria dell’intera città
tanto densa da fare pietà…
Ora sbaracca Volvera,
la fabbrica con i ricambi,
la fonderia a Crescentino.
…………………………
…………………………
Bene, molto bene Avvocato,
il suo inglese è perfetto;
io ho tutto annotato,
la stringo ancora fra i denti.
Da tutti è oramai confermato:
l’auto è in crisi profonda,
l’auto non ha futuro
— stecco di legno sull’onda.
Dopo l’assestamento
le auto saranno più rare
e finiranno per scomparire
come lampare sul mare.
Corre l’obbligo di precisare che la risposta dell’Avvocato (dove abbiamo messo i puntini di sospensione) è resa da Dalla con un’esplosione dei suoi tipici grammelot jazzistico-schizoidi…
È il 1976, e l’universo-fabbrica sta per dire addio alla canzone italiana. Quello che veniva definito generalmente come “impegno” non tira più. Dalla e De Gregori stanno per salpare, come fanno i marinai, verso Banana Republic; all’orizzonte si intravedono le farse di Rino Geatano e di Renato Zero… L’ultima canzone sulla fabbrica è del 1977. Ne è autore un insospettabile: Claudio Baglioni. Duecento lire di castagne, malgrado (o forse proprio in virtù del) tanto rinfacciato gozzanismo baglioniano, rischia di essere la più bella canzone sul tema:
Duecento lire di castagne sopra il cavalcavia,
fiocchi di cenere nel cielo, l’inverno bussa già.
Presa a contare le corriere che stan sfrecciando via
l’intervallo lei lo passa qui, sola senza compagnia.
Le sue colline son lontane e non le vede più;
soltanto i nidi di cemento della periferia.
Strapparsi il camice di dosso e rotolare giù
e sporcarsi il volto d’allegria per non sospirare più
e nascondersi nel vento e non tornare mai…
E mai più le ciminiere, le sirene, la città,
i cancelli e i capannoni bagnati di foschia e di umidità;
e mai più sedersi a mensa tra malinconia e purée:
la catena, il nastro, i giorni che vanno via col carrello del caffè.
Ma un sole pallido e malato è la sua realtà.
Domani è festa e finalmente potrà svagarsi un po’.
Sorride quasi nel pensare a quello che farà.
Le corriere stan sfrecciando via e l’inverno bussa già;
qualche buccia di castagna sul cavalcavia.



