
Via via che il conflitto tra Israele e palestinesi si insanguina e si imbarbarisce, si moltiplicano le informazioni distorte con cui il governo israeliano e i suoi sostenitori cercano di attribuire alla sola controparte la responsabilità delle violenze. Ciò si innesta in un’offensiva mediatica ampiamente documentata nel volume di Joss Dray e Denis Sieffert La guerre israélienne de l’information (ed. La Découverte, Paris, 2002), tesa a neutralizzare l’effetto shock delle immagini di case demolite, di ulivi sradicati, di uccisioni quotidiane — in una parola, del progressivo soffocamento dell’identità palestinese da parte del governo Sharon, culminato nella decisione folle di racchiudere ciò che resta della Palestina autonoma entro un muro. Un obbrobrio che all’interno stesso di Israele trova, per fortuna, accesi oppositori.
Tra le menzogne di guerra divulgate ad arte, ha il primo posto quella secondo la quale i negoziati di Taba, seguiti al tentativo di accordo di Camp David (luglio 2000), sarebbero falliti solo per colpa dei palestinesi, per cui solo questi sarebbero all’origine della tragedia che è seguita. Pian piano, la bugia è diventata quasi luogo comune. Ci sembra dunque opportuno riproporre un articolo di Alain Gresh apparso sull’edizione italiana di Le Monde Diplomatique nel settembre 2001, in cui la realtà dei fatti è ristabilita in maniera incontrovertibile. Rimandando al testo di Dray e Sieffert per un’analisi dettagliata di come una bugia madornale possa trasformarsi in “verità” largamente accettata dai media.
Esiste naturalmente il rischio dell’accusa di antisemitismo, che i sostenitori del governo israeliano sparano attorno con noncuranza ogni volta che l’operato di Sharon è messo in discussione. Un’accusa da cui non vanno esenti né Alain Gresh, malgrado l’origine ebraica, né un buon numero di ebrei sparsi per il mondo, né tantissimi cittadini israeliani. In realtà, nella misura in cui i difensori a oltranza della politica dello Stato di Israele difendono l’indifendibile e si collegano alla xenofobia contro gli arabi di qualsiasi confessione, età o contesto (vedi in Italia la sintonia tra Fiamma Nierenstein e Oriana Fallaci), non fanno che alimentare reazioni antisemite sempre più accese. Negare che esista un popolo palestinese, per dirne una, non è meno razzista che assimilare ogni ebreo del mondo a Israele e alla sua politica.
In Palestina (chiamiamola così, tanto per intenderci) la storia ha messo l’uno accanto all’altro due popoli più simili di quanto non credano essi stessi (in proposito, raccomando la lettura di Yoram Binur, Io, il mio nemico, Leonardo editore, Milano 1989: vicenda istruttiva di un israeliano che si finge palestinese e va a vivere in mezzo ai suoi presunti avversari “ancestrali”). I contendenti potranno uscire dai vicoli ciechi in cui si sono perduti solo se riconosceranno questa loro parentela di fondo, e sapranno rinunciare agli odi confessionali per cui un aggregato di genti è scambiato per una stirpe, e una cultura per una razza.
Altrimenti, come dice Alain Gresh, il loro presente sanguinoso diventerà il futuro di tutti, dentro e fuori l’area mediorientale.
Chi dissemina menzogne punta proprio a questo fine. Siamo realistici: al momento un simile esito è il più probabile. Però minoranze illuminate esistono sia tra gli israeliani che tra i palestinesi. Personalmente punto proprio su queste minoranze, pur sapendo di avere tutte le probabilità a mio sfavore. (VE)
MEDIORIENTE, LA PACE MANCATA
di Alain Gresh
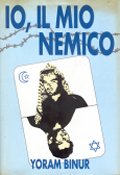
È passato un anno da quando, il 28 settembre 2000, la visita provocatoria condotta da Ariel Sharon alla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio degli ebrei) con l’intenzione politica di coprire i nuovi insediamenti di coloni in terra palestinese, scatenava la seconda Intifada e la repressione israeliana, con un progressivo rafforzamento dell’occupazione e un bilancio di centinaia vittime. Dopo la vittoria di Sharon alle elezioni del 6 febbraio scorso per il posto di primo ministro – nonostante le sue accertate responsabilità in molteplici eccidi di palestinesi, fra cui il massacro di Sabra e Chatila del 1982 – la situazione appare ormai senza via d’uscita. Tutto il Medioriente sembra avvilupparsi in una logica di guerra, determinata dall’intransigenza di Tel Aviv, dal suo rifiuto di restituire la terra ai palestinesi e dalla disperata risposta di questi ultimi, che moltiplicano gli attacchi terroristici e suicidi nello stato ebraico. Eppure, nel gennaio scorso, le delegazioni palestinese e israeliana, riunite a Taba per un ultimo disperato tentativo negoziale, si sono trovate ad un passo dall’accordo di pace.
«Il problema dei rifugiati palestinesi è centrale nelle relazioni israelo-palestinesi. La sua soluzione globale e giusta è essenziale per costituire una pace durevole e moralmente irreprensibile (…).
Lo stato di Israele esprime solennemente la propria tristezza per la tragedia dei rifugiati palestinesi, per le loro sofferenze e le perdite subite e sarà un partner attivo per chiudere questo terribile capitolo aperto 53 anni fa (…)» Incredulo, un leader palestinese prosegue la lettura del documento che è appena stato consegnato alla sua delegazione dai rappresentanti israeliani. La scena si è svolta a Taba, una stazione baleare sul golfo di Aqaba, all’inizio del 2001. In questa enclave di un chilometro quadrato restituita da Israele all’Egitto nel 1998, alla fine di un lungo contenzioso, sono rinchiusi dal 21 gennaio rappresentanti israeliani e palestinesi per tentare di «salvare la pace».
«Malgrado l’accettazione della risoluzione 181 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite del novembre 1947 [che raccomanda la spartizione della Palestina in due stati, uno ebreo e l’altro arabo], il nascente stato di Israele è stato coinvolto nella guerra e nello spargimento di sangue del 1948-1949, che ha fatto vittime e provocato sofferenze da entrambe le parti,con il conseguente trasferimento e l’espropriazione della popolazione civile palestinese divenuta così rifugiata (…)».
«Una giusta soluzione del problema dei rifugiati palestinesi, in accordo con la risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, deve condurre all’applicazione della risoluzione 194 del’Assemblea generale delle Nazioni unite (…)».
Il dirigente palestinese in questione si ricorda della propria reazione quando ha finito di prendere conoscenza di questo testo. «Sono diviso tra due sentimenti: la gioia per questo passo avanti significativo nei negoziati e la tristezza perché sono convinto che sia ormai troppo tardi». Per la prima volta, in effetti, Israele riconosce di essere in parte responsabile del dramma dei rifugiati palestinesi, accetta di contribuire direttamente alla soluzione del problema e afferma che questa deve portare all’applicazione della risoluzione 194 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, riconfermata tutti gli anni dal dicembre 1948 e che in particolare stipula che «è il caso di permettere ai rifugiati che lo desiderino di rientrare nelle loro case il più presto possibile e di vivere in pace con i vicini». Questo documento israeliano, pubblicato qui per la prima volta (vedi il testo integrale qui in basso), altri documenti e conversazioni tenute con numerosi protagonisti, attestano i progressi compiuti durante i mesi di trattative che hanno seguito il fallimento del vertice di Camp David nel luglio 2000.
Tuttavia, tutti i partecipanti di Taba sanno che nulla può ormai evitare a Ehud Barak la disfatta alle elezioni del successivo 6 febbraio: nei sondaggi è molto distanziato da Ariel Sharon, con un handicap di più del 20%. In effetti, qualche giorno dopo, il responsabile dei massacri di Sabra e Chatila, il falco impenitente, diventerà primo ministro.
Sette mesi dopo, il fossato tra i due popoli non sembra essere stato mai così profondo e la pace mai così lontana. La repressione contro i palestinesi ha toccato picchi mai visti. Ogni giorno ci sono morti e invalidi, case distrutte e campi devastati. Le incursioni israeliane nei territori hanno ancora ridotto la sostanza dell’autonomia. Il blocco di città e villaggi, meno spettacolare dei bombardamenti degli aerei F 16, affama una popolazione costretta alla miseria, che soffoca in enclave disperse, isolate, tagliate fuori le une dalle altre.
I maltrattamenti, la tortura – anche sui bambini (1) – gli assassinii di dirigenti, le umiliazioni ai check point illustrano il martirio di tutta una popolazione che resiste contro l’occupante, abbandonata dalla comunità internazionale. In queste condizioni, possiamo quasi stupirci che la percentuale di appoggio a Hamas e alle altre forze islamiste in un anno non sia passata che dal 15 al 25% della popolazione.
Nell’altro campo, la paura ha preso il sopravvento, alimentata dagli attentati suicidi. Chiunque scenda per strada, teme per sé e per i propri figli. Insensibili alle sofferenze altrui, gli israeliani si sentono una volta di più minacciati, malgrado la loro immensa superiorità militare. Come si è arrivati a questo punto, mentre all’inizio del 2001, a Taba, un accordo era stato sfiorato?
Torniamo indietro. Per la schiacciante maggioranza degli israeliani, rigettando la «generosa offerta» avanzata al vertice di Camp David nel luglio 2000, Yasser Arafat avrebbe, secondo un’affermazione di Ehud Barak, «gettato la maschera» ; appoggiandolo, i palestinesi avrebbero confermato il loro segreto disegno di distruggere Israele.
«Una generosa offerta»? Da quale punto di vista? Certamente non quello del diritto internazionale, che impone a Israele di ritirarsi da tutti i territori occupati nel 1967 e di smantellare tutte le colonie, comprese quelle di Gerusalemme est. L’espressione stessa la dice lunga: è quella di un vincitore, che il vinto deve ratificare umilmente.
Esprime la visione di una pace imposta dal più forte al più debole.
Per diversi mesi, con sparate a raffica sui media si è occultata questa realtà, accollando ai palestinesi la responsabilità del fiasco del vertice.
Un anno dopo, conosciamo i particolari dell’incontro di Camp David che rivelano il carattere iniquo delle offerte israeliane (2).
«Prendere o lasciare» Lo stato palestinese concesso allora da Ehud Barak non avrebbe disposto che di una sovranità limitata. La vita dei palestinesi avrebbe continuato ad essere subordinata all’occupante. Il 9,5% della superficie della Cisgiordania doveva venire annesso e circa il 10%, lungo il Giordano, affittato a «lungo termine» a Israele. La Cisgiordania sarebbe rimasta praticamente tagliata in tre da due grandi blocchi di colonie, un lungo corridoio avrebbe addirittura permesso un accesso diretto di Israele a Kiryat Arba e al cuore di Hebron (si veda la mappa nella pagina a fianco). Israele avrebbe conservato il controllo delle frontiere esterne dello stato palestinese. Non era stata prevista nessuna soluzione per i rifugiati. Su Gerusalemme, invece, Ehud Barak aveva reso più elastico un dogma inamovibile: per la prima volta aveva delineato la partizione di «Gerusalemme unificata», decretata nel 1967 «capitale eterna» di Israele. La città poteva diventare la capitale dei due stati, anche se restava ancora da determinare cosa apparteneva a chi.
Ma il dialogo non è stato avviato a Camp David. Il primo ministro rifiutò di incontrare Arafat in tête-à-tête, mentre il leader palestinese diffidava del proprio interlocutore. Barak, eletto nel maggio 1999, non aveva difatti sotterrato per un anno il fascicolo palestinese per negoziare, invano, con Damasco? Non aveva aggiornato sine die il terzo ridispiegamento delle truppe in Cisgiordania che aveva lui stesso negoziato? Non aveva rifiutato di trasferire ai palestinesi vari villaggi attorno a Gerusalemme (Abu Dis, El Eyzaria, Sawahra e Anata), trasferimento tuttavia approvato dal suo governo e dal parlamento?
Più in generale, la filosofia delle proposte israeliane a Camp David rifletteva una certa idea della pace e degli accordi di Oslo. Israele, sia il governo che l’opinione pubblica, trovava normale che il diritto dei palestinesi (alla dignità, alla libertà, alla sicurezza, all’indipendenza ecc.) venisse subordinato al diritto degli israeliani. Non lo si sottolineerà mai abbastanza: gli accordi di Oslo non erano un contratto di matrimonio tra due sposi con eguali diritti e doveri, ma un compromesso tra un occupante e un occupato. E l’occupante ha voluto imporre, ad ogni tappa e con l’appoggio degli Stati uniti, il suo solo punto di vista. Benché una decina di accordi siano stati firmati tra il settembre 1993 e il 2000, solo una piccola percentuale degli obblighi inscritti nei testi verrà applicata e sovente con ritardo. «Nessuna data è sacra», aveva proclamato Itzhak Rabin. I ritardi e i rinvii accumulati lacereranno la pazienza dei palestinesi…
Malgrado tutto, e a dispetto di tutto, la popolazione palestinese ha continuato, per parecchi anni, a credere che l’indipendenza e la libertà risplendessero alla fine del cammino. L’influenza delle organizzazioni radicali e islamiste rimaneva limitata. Ma, trascorso un anno dalla scadenza del termine previsto per l’autonomia, le proposte israeliane a Camp David provano che Israele non ha abbandonato l’idea di un controllo dei palestinesi. Tanto più che, sul terreno, la colonizzazione avanza inesorabilmente…
Senza dubbio, Barak sarà sorpreso dal rifiuto di Arafat a Camp David.
Ricalcando le proprie proposte su ciò che sembrava accettabile dalla classe politica israeliana, nel disprezzo del diritto internazionale, pensava che i palestinesi si sarebbero piegati. È pur vero che, dal 1993, l’Autorità palestinese era passata di concessione in concessione.
Ma, questa volta, si trattava dello status definitivo. Arafat aveva avvertito: mentre passi indietro sugli accordi transitori erano possibili, la «soluzione definitiva» doveva rispecchiare la risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza, che chiedeva la fine dell’occupazione della Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, e di Gaza (3). Ma, resi sordi da un sentimento di superiorità rispetto ai «colonizzati», i leader israeliani non ascoltavano…
Il rifiuto di Arafat di cedere a Camp David sui pricipi ha trovato un appoggio totale nell’opinione pubblica palestinese, che prendeva sul serio la parola d’ordine «la pace in cambio dei territori». Questo vertice si concluse quindi con un fallimento parziale. Ma bisognava proprio far suonare le trombe dell’apocalisse? Le trattative proseguivano, passi avanti erano sempre possibili.
Ma la pazienza della popolazione palestinese era arrivata al limite.
La scintilla che ha dato fuoco alle polveri è venuta dalla cucina elettorale israeliana. Il 28 settembre 2000, Ariel Sharon si è presentato in modo provocatorio sulla spianata delle Moschee, a Gerusalemme.
Autorizzando questa escursione, Ehud Barak sperava di rafforzare la posizione del dirigente del Likud rispetto… al suo rivale di partito, Benyamin Netanyahu. Nella prospettiva di elezioni anticipate, il primo ministro israeliano avrebbe preferito trovarsi in competizione con Sharon, che contava di battere facilmente. Ma i palestinesi hanno recepito la «visita» come una provocazione e hanno manifestato la loro rabbia. In tre giorni, mentre nessuna arma era stata utilizzata contro di esso, l’esercito israeliano uccise trenta persone e ne ferì cinquecento. I palestinesi, senza alcuna direttiva proveniente dal centro, si sono rivoltati. Reclamavano, né più né meno, la fine immediata dell’occupazione. In questo modo è iniziata la seconda Intifada di una popolazione palestinese esasperata da sette anni di rinvii, di promesse non mantenute, di sogni spezzati.
Anche se il governo israeliano ha la principale responsabilità dell’esplosione, la direzione palestinese non può essere totalmente assolta per la confusione che prende piede a partire dall’estate del 2000. Questa leadership, segnata dalle pratiche autoritarie di Yasser Arafat, paralizzata dalle lotte per la successione, incancrenita dalla corruzione, ha mostrato una mortale forma di paralisi per parecchi mesi (4).
Non ha preso la misura del pericolo che avrebbe rappresentato la possibile vittoria di Sharon alle elezioni, aspettando gli ultimi giorni della campagna per premere sugli elettori arabi israeliani – traumatizzati dalla terribile repressione dell’ottobre 2000 – perché si mobilitassero. Non è stata capace di formulare chiaramente i propri obiettivi, di definire una strategia, di sviluppare una campagna sui media per rispondere alla disinformazione seguita al vertice di Camp David. Ha ravvivato i timori dell’opinione pubblica israeliana attraverso alcune dichiarazione inopportune sul «diritto al ritorno» di ogni rifugiato o esprimendo dei dubbi sul carattere sacro del monte del Tempio per l’ebraismo. Yasser Arafat, convinto che gli Stati uniti controllassero il 99% delle carte del negoziato, ha ignorato un fattore cruciale: nessun accordo è possibile senza il sostegno dell’opinione pubblica israeliana.
Ma le fortissime carenze dell’Autorità non cancellano i diritti dei palestinesi definiti dalle risoluzioni dell’Onu: nel 1990, nessuno ha aspettato una democratizzazione del potere in Kuwait per esigere la fine dell’occupazione irachena. Come scrive Henry Siegman, ricercatore al Council of Foreign Relations, un rigetto, anche se ingiustificato, da parte di Arafat di una proposta israeliana «non annulla i diritti dei palestinesi sulla Cisgiordania e Gaza, diritti riconosciuti dalla comunità internazionale» (5).
«Prendere o lasciare». È così che Barak ha presentato le proprie offerte a Camp David. Tuttavia, aveva dovuto fare alcuni passi avanti, modificare una ad una le «linee rosse» intangibili che aveva tracciato.
Avrebbe fatto simili concessioni senza la pressione esercitata dalla seconda Intifada? Come sottolinea Ami Ayalon, ex capo dei servizi israeliani di sicurezza interna (Shin Beth), «i palestinesi hanno imparato che Israele capisce solo il linguaggio della forza». L’Olp, dal canto suo, ha confermato che poteva dare prova di elasticità, purché gli interessi minimi del suo popolo venissero preservati.
L’incontro di Taba del gennaio 2001 segna il punto più avanzato dei negoziati tra i palestinesi e la squadra di Barak. Nel comunicato finale del 27 gennaio 2001 le parti affermeranno di non essere mai state così vicine ad un accordo. I documenti elaborati sulle quattro principali questioni (territorio, Gerusalemme, sicurezza, rifugiati), le confidenze fatte da importanti protagonisti (6), confermano questa affermazione.
Prima di tutto, le due parti hanno riconosciuto che, in accordo con la risoluzione 242 del Consiglio di sicuezza, le linee del 4 giugno 1967 sarebbero servite come base per il tracciato delle frontiere definitive: ogni annessione di territori palestinesi da parte di Israele avrebbe dovuto essere compensata. La delegazione israeliana ha proposto di restituire il 94% (7) della Cisgiordania (dove vive circa il 20% dei coloni) e di cedere l’equivalente del 3% in territori israeliani – il 3% «mancante» veniva riequilibrato con il «passaggio sicuro» che avrebbe collegato la Cisgiordania a Gaza, ma che non sarebbe stato sotto sovranità palestinese. Rispetto a Camp David, Israele aveva rinunciato alla valle del Giordano, a Shilo, all’est di Ariel e a qualche punto più isolato, come Kedumin e Bel El, oltre che a una regione al nord della colonia di Modim (che comprende 50mila palestinesi); ha anche accettato che se ne andassero i coloni dal cuore di Hebron e che venisse smantellata Kiyriat Arba.
La delegazione palestinese, dal canto suo, ha insistito sul concetto del «100%». Ha spiegato che «in una prigione, il 95% dello spazio è per i prigionieri – celle, mensa, sale di ginnastica, infermeria ecc – ma il 5% restante è sufficiente ai secondini per continuare a controllare i prigionieri» (8). Ha accettato di cedere il 2% della Cisgiordania (dive vive circa il 65% dei coloni), in cambio di territori di eguale valore (gli israeliani avevano offerto di cedere delle dune di sabbia a Helutza, nel deserto del Neghev, ai confini di Gaza).
L’evacuazione avrebbe dovuto realizzarsi rapidamente – tre anni per Israele, diciotto mesi per i palestinesi. Gerusalemme non sarebbe stata divisa e sarebbe diventata la capitale dei due stati. Come spiega Yossi Sarid, leader del partito di sinistra Meretz, uno dei partecipanti a Camp David, «eravamo d’accordo sul principio della spartizione, conformemente al piano Clinton (9), i quartieri ebraici sarebbero stati nostri, i quartieri arabi dei palestinesi». I palestinesi esigevano la sovranità sull’Haram El Sharif (la spianata delle Moschee), gli israeliani la volevano su tutto il muro occidentale (compreso il muro del pianto). Diversi suggerimenti sono stati esaminati, tra cui quello di affidare la sovranità, per un periodo limitato, ai cinque membri del Consiglio di sicurezza e al Marocco.
Anche sulla sicurezza, ci sono state posizioni convergenti. I palestinesi hanno concesso una limitazione dell’armamento del loro stato, oltre all’installazione, a determinate condizioni, di centri di allerta israeliani. La presenza di una forza internazionale alle frontiere è stata accettata.
Il dramma dei 3,7 milioni di rifugiati palestinesi dispersi tra la Giordania, la Siria, il Libano e i territori autonomi è stato l’ostacolo più imbarazzante. È stato al centro di numerose polemiche dopo il fallimento di Camp David. Arafat non stava per caso cercando di sommergere Israele sotto il flusso dei rifugiati? Il corrispondente di France 2, Charles Enderlin, testimone privilegiato dei negoziati israelo-palestinesi dal settembre 1999 (10), ribatte: «è un insulto all’intelligenza pensare, come afferma un certo tipo di propaganda, che i leader palestinesi credessero possibile concludere un accordo di pace che comportasse il ritorno in Israele di 3,7 milioni di rifugiati. La verità è che potevano accettare di rinunciare a questa rivendicazione storica dell’Olp solo in cambio di uno stato palestinese funzionante sulla quasi totalità della Cisgordania e di Gaza, con capitale la parte araba di Gerusalemme» (11). «L’umanità del campo avverso» I negoziati di Taba gli hanno dato ragione, ma è sufficiente dire la verità per venire intesi ? Nabil Chaath e Yossi Beilin, incaricati della questione dei rifugiati, hanno insistito entrambi sui progressi fatti. Le parti hanno affermato che una soluzione giusta del problema dei rifugiati, conformemente alla risoluzione 242, doveva portare all’applicazione della risoluzione 194 dell’Assemblea generale; hanno fatto passi avanti nella formulazione di un’analisi delle origini del problema dei rifugiati. A partire da questi principi, sono state elaborate soluzioni concrete. Sarebbero state offerte cinque possibilità ai rifugiati: il ritorno in Israele; il ritorno nei territori israeliani ceduti da Israele alla Palestina; il ritorno nello stato palestinese; l’insediamento nel luogo attuale di residenza (Giordania, Siria ecc.); la partenza per un altro paese (vari stati, tra cui il Canada, hanno già fatto sapere di essere disposti ad accettare un numero consistente di palestinesi).
Pur insistendo sulla libera scelta dei rifugiati, i leader palestinesi hanno ripetuto che non volevano mettere in discussione il carattere ebraico dello stato di Israele – carattere che hanno riconosciuto al momento della dichiarazione di indipedenza della Palestina adottata al Consiglio nazionale del 1988. Come precisa Yossi Sarid, la parte palestinese ha ammesso che «la decisione finale per il ritorno di ogni rifugiato in Israele è in mani israeliane». Israele ha accettato il ritorno di 40mila rifugiati in cinque anni – ai quali si sarebbero aggiunti quelli inclusi nell’ambito del «ricongiungimento familiare» – ma i palestinesi hanno ribattuto che un’offerta inferiore a 100mila non avrebbe permesso di fare passi avanti. Secondo Yasser Abel Rabbo, ministro palestinese della cultura e dell’informazione, la determinazione di questa cifra sarebbe stata l’ultimo ostacolo.
Le due parti si sono anche messe d’accordo sul fatto che la priorità doveva essere accordata ai rifugiati del Libano, che vivono in condizioni spaventose a causa della politica di discriminazione del governo di Beirut. Il testo israeliano precisa persino: «lo stato di Israele riconosce il proprio dovere morale per trovare una rapida soluzione per le popolazioni rifugiate nei campi di Sabra e Chatila».
Una commissione internazionale e un fondo internazionale sarebbero stati creati per risarcire i rifugiati. Infine, le due parti hanno accettato il fatto che la questione del risarcimento degli ebrei che hanno lasciato i paesi arabi per insediarsi in Israele non era argomento di una discussione bilaterale (12).
Perché non è stato possibile trasformare questi passi avanti di Taba in un accordo? Entrambi i protagonisti lo sapevano, era ormai troppo tardi: le elezioni israeliane erano troppo imminenti. «Se avessero avuto luogo a maggio, avremmo potuto concludere in due o tre settimane», insiste Yasser Abel Rabbo. In più, Barak ha esitato, tergiversato, sospeso i negoziati per poi riprenderli, ha rivendicato la sovranità su tutta la città vecchia. Nabil Chaath si ricorda delle «pressioni esercitate dai “moralisti” del governo israeliano, guidati da Abraham Burg, che affermava che gli elettori avrebbero sospettato Barak di aver sacrificato gli interessi nazionali a quelli del suo governo».
Tanto più che una sconfitta elettorale avrebbe significato una sconfessione degli impegni di Taba. Dall’altro lato, spiega Yasser Abel Rabbo, «non avevamo tempo di redigere un trattato e quale status avrebbe avuto una semplice dichiarazione? Un testo del genere non avrebbe avuto nessun carattere vincolante». Bisognava anche «vendere» le concessioni all’opinione pubblica palestinese, concessioni fatte senza alcuna contropartita concreta, poiché Sharon non si sarebbe sentito impegnato da una semplice dichiarazione. L’idea della dichiarazione, accarezzata per un attimo al vertice Arafat-Barak dell’ultima speranza, verrà poi alla fine abbandonata.
Per evitare di far evaporare i punti acquisiti negli ultimi mesi, le due delegazioni hanno incaricato Miguel Angel Moratinos, l’inviato speciale dell’Unione europea, presente a Taba – gli Stati uniti, in piena transizione presidenziale, non avevano delegato nessuno – di elaborare delle conclusioni. Per la storia, senza dubbio, ma anche perché, un momento o l’altro, bisognerà pure riunirsi nuovamente intorno a un tavolo. Difatti, benché oggi la priorità debba essere accordata alla protezione internazionale della popolazione palestinese, protezione che per il momento è assicurata solo da missioni civili internazionali, soltanto una soluzione politica può permettere di sfuggire a un ingranaggio mortale. È ciò che hanno ricordato con coraggio, alla fine di luglio, personalità rappresentative dei due campi – tra cui vari ministri (Yasser Abel Rabbo, Nabil Amr, Hisham Abdul Razzek) e intellettuali (Hanan Ashrawi, Sari Nuseibeth, Salim Tamari) palestinesi, così come Yossi Beilin, ex ministro della giustizia del governo Barak e numerosi scrittori (tra cui Amos Oz, A.B.Yehoshua, David Grossman).
«Noi, israeliani e palestinesi, nelle più difficili circostanze per i nostri popoli, ci riuniamo per reclamare la fine del bagno di sangue, la fine dell’occupazione, un ritorno urgente ai negoziati e alla realizzazione della pace (…) Malgrado tutto, crediamo sempre nell’umanità del campo avverso e nel fatto che abbiamo un partner con il quale faremo la pace. Una soluzione negoziata al conflitto tra i nostri popoli è possibile (…) Per fare passi avanti bisogna accettare la legittimità internazionale e l’applicazione delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell’Onu che conducono a una soluzione basata sulle frontiere del 1967 e su due stati, Israele e Palestina, fianco a fianco, con Gerusalemme come rispettiva capitale.
Soluzioni giuste e durevoli possono essere trovate a tutti i problemi rimasti in sospeso, senza minare la sovranità degli stati palestinese e israeliano, sovranità definita dai loro rispettivi cittadini e che comprende le aspirazioni a uno stato per entrambi i popoli, palestinese ed ebreo».
Difatti, lo sanno tutti, l’unica alternativa è uno scenario da incubo: un’escalation che non può che sfociare in un’ulteriore conflagrazione regionale, uno scontro senza fine la cui parola d’ordine sarebbe «o loro o noi», una guerra da cui entrambi uscirebbero sconfitti.
note:
(1) Si vedano le inchieste di Joseph Algazi in Haaretz (pubblicate in Francia dal Courrier International, 17 maggio 2001), e l’International Herald Tribune, Parigi, 20 agosto 2001.
(2) Contrariamente ai palestinesi, la delegazione israeliana ha orchestrato una serie di «fughe di notizie» durante Camp David e, in seguito, offrirà la sola versione ufficiale del vertice, versione che sarà ripesa tale e quale dai media israeliani e in seguito dai media occidentali.
Cfr. Aluf Benn, «The Sellig of a Summit», Haaretz, 26 luglio 2001.
Si è dovuto aspettare un anno perché i palestinesi presentassero la loro versione in un documento molto dettagliato e che sembra molto più vicino alla realtà rispetto all’idea israeliana di un’«offerta generosa». Cfr. Akiva Elder, «What Went Wrong at Camp David: the official Plo Version», Haaretz, 24 luglio 2001.
(3) Palestine Report, 1° febbraio 2001: Jmcc.org.
(4) La critica palestinese più severa è venuta da Yezid Sayigh, un intellettuale che lavora in Gran Bretagna e che a più riprese ha svolto il ruolo di consigliere della delegazione palestinese nei negoziati di pace aperti a Madrid nell’ottobre 1991. Cfr. «Arafat and the Anatomy of a Revolt», Survival, The International Institute of Strategic Studies, Londra, vol.43, n.3, autunno 2001.
(5) «Middle East Conflict: Seek Palestinian Confidence in What?», International Herald Tribune, Parigi, 17 luglo 2001.
(6) Le delegazioni sono guidate rispettivamente da Abu Ala’, presidente del consiglio legislativo palestinese, e Shlomo Ben Ami, ministro degli esteri israeliano. I membri della delegazione palestinese sono Nabil Chaath, Saeb Erakat, Yasser Abel Rabbo, Hassan Asfur, Mohamed Dahlan; quelli della delegazione israeliana sono Yossi Beilin, Amnon Lipkin Shahak, Gilad Sher, Israel Hassun e Yossi Sarid.
(7) Va sottolineato che queste percentuali meritano di venire discusse.
Non sono inclusi i 72 chilometri quadrati di Gerusalemme est (cioè l’1,3% della Cisgiordania), né la zona demilitarizzata annessa da Israele (in particolare attorno a Latrun) e che rappresenta l’1,8% della Cisgiordannia.
(8) «What went wrong…», op. cit.
(9) Il «piano Clinton» riprende le proposte avanzate il 23 dicembre 2000 dall’ex presidente statunitense sui principali punti della questione israelo-palestiese. Si veda il testo nell’archivio Medioriente del sito di Le Monde diplomatique: www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/
(10) Ha registrato le testimonianze di tutti i protagonisti del negoziato, a condizione di non renderle pubbliche prima della fine del 2001.
(11) Libération, 26 febbraio 2001.
(12) Tanto più che Israele non aveva mai sollevato questo problema in occasione del trattato di pace con l’Egitto.
(Traduzione di A. M. M.)



