L’autonomia delle macchine
 Da secoli ci preoccupiamo della possibilità che, come Adamo si ribellò a suo tempo al suo fabbricatore, così i nostri Adami si ribellino a noi. L’archetipo dell’antropoide ribelle è il Golem, la creatura umanoide che si immagina portata alla vita da Rabbi Judah Löw ben Bezäl in una Praga cinquecentesca, ma ancora intrisa di spiriti medievali. La leggenda del Golem risale addirittura al testo ebraico dei Salmi, attraversando tutto il medioevo. Nella tradizione talmudica, il Golem è “un’immagine con sembianze di vita, una sostanza embrionica non completa che viene chiamata all’attività quando, sulla fronte o sulle labbra, le sia applicato l’acronimo ‘Shem’ “, uno dei molti nomi di Colui che non può essere nominato (V.Tagliasco, Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali, Mondadori 1999, p.197). Con i pogrom del Cinquecento il Golem, che era stato fino ad allora poco più di una scimmietta al servizio di qualche rabbino, divenne il difensore degli israeliti e assunse un aspetto terrificante; come dice sempre Tagliasco, “un po’ King Kong, un po’ Superman rimbambito”. Comunque un personaggio inquietante, perfetto soggetto per un romanzo espressionista come quello di Gustav Meyrink, Der Golem, del 1914, che fece conoscere la creatura al mondo culturale non ebraico. Alla fine, Rabbi Löw disattiva il Golem, che si è reso responsabile di mille malefatte. Ma non sempre la letteratura ha considerato così facile rendere innocui gli artefatti ribelli.
Da secoli ci preoccupiamo della possibilità che, come Adamo si ribellò a suo tempo al suo fabbricatore, così i nostri Adami si ribellino a noi. L’archetipo dell’antropoide ribelle è il Golem, la creatura umanoide che si immagina portata alla vita da Rabbi Judah Löw ben Bezäl in una Praga cinquecentesca, ma ancora intrisa di spiriti medievali. La leggenda del Golem risale addirittura al testo ebraico dei Salmi, attraversando tutto il medioevo. Nella tradizione talmudica, il Golem è “un’immagine con sembianze di vita, una sostanza embrionica non completa che viene chiamata all’attività quando, sulla fronte o sulle labbra, le sia applicato l’acronimo ‘Shem’ “, uno dei molti nomi di Colui che non può essere nominato (V.Tagliasco, Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali, Mondadori 1999, p.197). Con i pogrom del Cinquecento il Golem, che era stato fino ad allora poco più di una scimmietta al servizio di qualche rabbino, divenne il difensore degli israeliti e assunse un aspetto terrificante; come dice sempre Tagliasco, “un po’ King Kong, un po’ Superman rimbambito”. Comunque un personaggio inquietante, perfetto soggetto per un romanzo espressionista come quello di Gustav Meyrink, Der Golem, del 1914, che fece conoscere la creatura al mondo culturale non ebraico. Alla fine, Rabbi Löw disattiva il Golem, che si è reso responsabile di mille malefatte. Ma non sempre la letteratura ha considerato così facile rendere innocui gli artefatti ribelli.
Il motivo d’angoscia che il pensiero dell’artefatto porta in sé è legato alla possibilità della sua autonomia: se l’artefatto sviluppa, o addirittura viene dotato, di una volontà sua propria, questa volontà — come quella di Adamo – può volgersi al male, o comunque al danno del suo fabbricatore. L’artefatto autonomo non è più completamente un artefatto, perché diventa capace della resistenza alla volontà umana che è caratteristica di ciò che è naturale. 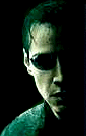 L’artefatto è prodotto per essere in tutto e per tutto permeabile alla volontà di chi lo ha prodotto, cioè per essere uno strumento. Nel momento in cui non è più completamente prono alla nostra volontà, l’artefatto cessa di essere tale per un aspetto importante (da cui l’antropomorfizzazione del PC o della lavapiatti, quando ci sembra che resistano alla nostra volontà esibendo qualcosa come un’ostinazione). La garanzia del limite della naturalizzazione dell’artificiale sta nella sua non autosufficienza. L’artefatto, anche se intelligente e autonomo, continua a dipendere da noi per la sua attività. Rabbi Löw, più severo col Golem di quanto Javeh sia stato con Adamo, gli toglie la vita; agli eventuali supercomputer ribelli “basterebbe staccare la spina”, si è sempre detto ogni volta che i progressi della tecnologia suscitavano qualche ansia. L’artefatto, anche autonomo, non è però autosufficiente e quindi non è fino in fondo naturalizzato.
L’artefatto è prodotto per essere in tutto e per tutto permeabile alla volontà di chi lo ha prodotto, cioè per essere uno strumento. Nel momento in cui non è più completamente prono alla nostra volontà, l’artefatto cessa di essere tale per un aspetto importante (da cui l’antropomorfizzazione del PC o della lavapiatti, quando ci sembra che resistano alla nostra volontà esibendo qualcosa come un’ostinazione). La garanzia del limite della naturalizzazione dell’artificiale sta nella sua non autosufficienza. L’artefatto, anche se intelligente e autonomo, continua a dipendere da noi per la sua attività. Rabbi Löw, più severo col Golem di quanto Javeh sia stato con Adamo, gli toglie la vita; agli eventuali supercomputer ribelli “basterebbe staccare la spina”, si è sempre detto ogni volta che i progressi della tecnologia suscitavano qualche ansia. L’artefatto, anche autonomo, non è però autosufficiente e quindi non è fino in fondo naturalizzato.
Matrix ha una bella invenzione poetica per ristabilire in pieno l’angoscia per la possibile ribellione delle macchine: immagina che le macchine, superintelligenti e autonome, si siano rese anche autosufficienti, sfruttando l’energia che ricavano allevando bambini umani. L’angoscia si raddoppia grazie all’inversione della relazione strumentale: non solo l’artefatto ribelle è diventato autosufficiente, ma lo è diventato trasformando gli uomini in suoi strumenti: sono gli uomini, ora, ad essere artefatti delle macchine. L’immagine è potente — anche visivamente – ma, a dire il vero e per fortuna, non molto convincente. Non è chiarissimo di che natura sia l’energia che le macchine assorbirebbero dagli uomini, e non si capisce (pensando agli scambi energetici del corpo umano) come potrebbe essere sufficiente ai consumi energetici delle macchine. Invece, si può pensare che la “produzione” di bambini sfrutti tecniche di fecondazione e gestazione artificiale, e suscitando questo pensiero il film sfrutta un’altra delle angosce attualmente in circolazione, quella legata alle biotecnologie. Insomma, abbiamo qui una meditazione non banale sul confine tra artificiale e naturale.
La mente e il corpo
Qui sarò brevissimo: mi limiterò a ricordare l’idea che “il corpo ha bisogno della mente” (“Il corpo non sopravvive senza mente”, dice uno dei personaggi del film), che rappresenta l’inversione del senso comune materialistico per cui è la mente ad aver bisogno del corpo, in particolare del cervello. Il corpo ha bisogno della mente, per cui un danno alla mente è, o comporta, un danno al corpo; non un danno cerebrale, ma un danno al corrispettivo fisico del corpo vissuto, cioè del fantasma del corpo che è vissuto come danneggiato nella vita mentale. E’ chiaro che, nel film, questa concezione è motivata da esigenze narrative e di spettacolarizzazione: bisogna che il rischio che i personaggi corrono nella loro vita virtuale in Matrix sia a tutti gli effetti un rischio mortale, e che le loro ferite virtuali siano (anche) vere ferite. Ma anche se i motivi non sono, probabilmente, filosofici, di fatto il film si trova a sostenere una concezione spinozistica del rapporto tra mente e corpo: la mente non è il cervello ma l’intero corpo in una sua possibile descrizione. Nei termini del film, si tratta di una concezione insostenibile: certamente è falso che se sogno di avere l’appendicite la mia appendice si infiammi davvero, e d’altra parte posso avere l’appendicite senza che ciò abbia alcun riscontro nella mia mente. Tuttavia, la teoria che Matrix assume per esigenze poetiche va nella direzione, oggi molto praticata, di concepire la mente in rapporto non al solo cervello ma all’intero corpo: per cui, ad esempio, molti dei nostri processi cognitivi sarebbero possibili — con l’efficienza con cui noi li realizziamo – solo grazie al “sapere del corpo”, cioè solo grazie ai meccanismi di interazione con l’ambiente che sono incorporati (appunto) nei nostri organi percettivi e motori.
“E se fosse tutto un sogno?”
Cioè, e se niente esistesse per davvero — né voi, né questo tavolo, né Milano qua fuori, né il mio stesso corpo – ma fosse un’illusione completa e coerente, generata dalla mia mente (come i sogni) oppure indotta da un agente esterno dotato di un immenso potere di suggestione? Solo la mia mente (ed eventualmente l’Ingannatore) esisterebbero davvero; tutto il resto sarebbe “della stessa materia di cui son fatti i sogni”, come dice Shakespeare: fantasmi, immagini, deliri, il tipo di cose che si agitano nella nostra mente quando sogniamo, ad occhi aperti o chiusi. La capacità degli esseri umani di sognare e di formare immagini mentali, anche di cose che non esistono e di situazioni non realizzate, è alla base di questa antica fantasia filosofica, a cui (nella variante in cui non c’è nessun Ingannatore esterno) è stato dato il nome di solipsismo: solo io esisto, o per meglio dire, solo la mia mente. La formulazione canonica, in epoca moderna e in Occidente, è dovuta a Cartesio. Nella versione di Cartesio, l’illusione che chiamiamo ‘realtà’ è prodotta da un essere perfido, un genio maligno:
Supporrò dunque che vi sia non un Dio ottimo, fonte di verità, ma un qualche genio maligno e nel contempo sommamente potente ed astuto, che abbia posto tutta la sua operosità nell’ingannarmi: stimerò che il cielo, l’aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne non siano altro che illusioni dei sogni con cui quel genio ha teso insidie alla mia mente. Supporrò di essere senza mani, senza occhi, senza carne, senza sangue, privo di qualsiasi senso e di possedere queste cose solo per falsa opinione. [Prima meditazione, 1641].
Perché il genio è detto ‘maligno’, che cosa c’è di malvagio in ciò che fa? Questa è una domanda di cui non ci occuperemo. In Cartesio, l’ipotesi del genio maligno è una delle ipotesi scettiche che vengono prese in esame lungo il percorso che dovrebbe portare ad una fondazione indubitabile del sapere scientifico. Recentemente, una nuova versione dell’ipotesi dell’illusione coerente è stata proposta da Hilary Putnam, questa volta allo scopo di portare acqua al mulino di certe teorie sulla mente e sul linguaggio (di cui non ci occuperemo). La versione di Putnam assomiglia molto da vicino a ciò che si immagina realizzato in Matrix (a riprova della popolare tesi secondo cui non c’è delirio che qualche filosofo non abbia teorizzato):
Immaginate che un essere umano (potete immaginare di essere voi) sia stato sottoposto ad un’operazione da parte di uno scienziato malvagio. Il cervello di quella persona (il vostro cervello) è stato rimosso dal corpo e messo in un’ampolla piena di sostanze chimiche che lo tengono in vita. Le terminazioni nervose sono state connesse ad un computer superscientifico che fa sì che la persona a cui appartiene il cervello abbia l’illusione che tutto sia perfettamente normale. Sembra che ci siano persone, oggetti, il cielo ecc., ma in realtà l’esperienza della persona (la vostra esperienza) è in tutto e per tutto il risultato degli impulsi elettronici che viaggiano dal computer alle terminazioni nervose. Il computer è così abile che se la persona cerca di alzare il braccio la risposta del computer farà sì che “veda” e “senta” il braccio che si alza. Inoltre, variando il programma lo scienziato malvagio può far sì che la vittima “esperisca” (ovvero allucini) qualsiasi situazione o ambiente lo scienziato voglia. Può anche offuscare il ricordo dell’operazione al cervello, in modo che la vittima abbia l’impressione di essere sempre stata in quell’ambiente.[…]
Potremmo anche immaginare che tutti gli esseri umani … siano cervelli in un’ampolla. Naturalmente lo scienziato malvagio dovrebbe trovarsi al di fuori. Dovrebbe? Magari non esiste nessuno scienziato malvagio; magari l’universo … consiste solo di macchinari automatici che badano a un’ampolla piena di cervelli. Supponiamo che il macchinario automatico sia programmato per dare a tutti noi un’allucinazione collettiva … Quando sembra a me di star parlando a voi, sembra a voi di star ascoltando le mie parole. Naturalmente le mie parole non giungono per davvero alle vostre orecchie, dato che non avete (vere) orecchie, né io ho una vera bocca e una vera lingua. Invece, quando produco le mie parole quel che succede è che gli impulsi efferenti viaggiano dal mio cervello al computer, che fa sì che io ‘senta’ la mia stessa voce che dice quelle parole e ‘senta’ la lingua muoversi, ecc., e anche che voi ‘udiate’ le mie parole, mi ‘vediate’ parlare, ecc. In questo caso, in un certo senso io e voi siamo davvero in comunicazione. Io non mi inganno sulla vostra esistenza reale, ma solo sull’esistenza del vostro corpo e del mondo esterno, cervelli esclusi.
(H. Putnam, Brains in a Vat, 1981, pp.6-7)
Come ho detto, l’ipotesi dell’illusione coerente è una fantasia filosofica classica, a cui sono state date — come è facile aspettarsi – risposte non meno canoniche. Quel che è interessante di Matrix è che contiene implicitamente delle risposte a queste obiezioni. Non è molto probabile che i Wachowski abbiano studiato il problema, o la letteratura filosofica che ne tratta; dunque, sembra che il fatto stesso di dover realizzare l’ipotesi dell’illusione coerente porti con sé la consapevolezza di queste obiezioni, e suggerisca delle soluzioni. Di queste obiezioni, per ragioni di tempo, ne prenderò in considerazione solo due, molto simili tra loro. La prima si potrebbe chiamare
(1) L’obiezione della parzialità intrinseca del sogno. La nozione di sogno, dice questa obiezione, presuppone l’idea di veglia (e di risveglio): da un sogno dev’essere possibile svegliarsi, dove questo ‘deve’ non indica una necessità naturale ma una necessità logica (o, come avrebbe detto Wittgenstein, una connessione grammaticale). Un sogno da cui non ci potesse svegliare non sarebbe un sogno nel nostro senso di sogno. Perciò un sogno, per così dire, globale è una contraddizione in termini: un sogno è intrinsecamente parziale. Matrix risponde a questa obiezione, perché dall’illusione computazionale, dalla vita virtuale di Matrix è possibile uscire: gli hackers protagonisti del film sono appunto dei risvegliati. Certo, non è chiaro come si esca da Matrix (né del resto come ci si rientri): ma il fatto che se ne possa uscire la legittima concettualmente: Matrix è un’illusione che ha un “fuori”, quindi è davvero un’illusione — un’illusione nel senso normale del termine.
L’altra obiezione, simile a questa ma diversa per una sfumatura, si potrebbe chiamare
(2) L’obiezione della vuotezza dell’ipotesi. Qui si sostiene che un’illusione globale, coerente e inevitabile non può essere contrapposta alla realtà perché non è veramente distinta dalla realtà; in verità, non è altro che la realtà stessa. Spesso noi contrapponiamo l’apparenza alla realtà: il bastone nell’acqua sembra spezzato ma in realtà non lo è, i segmenti paralleli nell’illusione di Müller-Lyer sembrano diversi ma in realtà sono lunghi uguali, e così via. Ma, quando contrapponiamo a questo modo apparenza e realtà, abbiamo sempre qualche evidenza a favore di ciò che chiamiamo ‘realtà’. Il bastone sembra spezzato ma, se lo tocchiamo, lo sentiamo intero; se lo tiriamo fuori dall’acqua non lo vediamo spezzato, e abbiamo ragione di ritenere che gli oggetti del tipo dei bastoni non cambino forma quando sono immersi nell’acqua; e le leggi dell’ottica ci spiegano perché il bastone, pur essendo integro, ci appare spezzato. L’apparenza ha qualche ragione dalla sua, ma la realtà ha ragioni preponderanti. Volendo essere estremisti, si potrebbe dire che chiamiamo ‘apparenza’ ciò che ha dalla sua una minoranza di ragioni, e ‘realtà’ ciò che è sostenuto da ragioni preponderanti. Comunque, nel caso dell’illusione globale le cose non stanno così: qui la realtà che vorremmo contrapporre all’illusione non ha, per ipotesi, nessuna via d’accesso: non abbiamo e non avremo mai evidenze da contrapporre a quelle che il genio maligno, o lo scienziato malvagio di Putnam, ci rendono accessibili. Il mondo dell’illusione coincide col mondo delle evidenze possibili, cioè con la realtà; dunque non è possibile alcuna contrapposizione tra sogno (o illusione) e realtà, l’ipotesi “che sia tutto un sogno” è vuota. Nella precedente obiezione si insisteva sulla contraddittorietà dell’idea di un sogno da cui non ci si può svegliare, qui si sottolinea che una realtà in linea di principio inaccessibile non potrà mai essere contrapposta all’illusione. Ma anche in questo caso l’obiezione non si applica al mondo di Matrix: Matrix, come abbiamo già detto, ha un “fuori”, accessibile con fatica e non si sa bene come ma accessibile, se non altro agli eroi del film. La realtà — il mondo impoverito e devastato in cui comandano le macchine e vegetano gli esseri umani – è un sottile contenitore di un colossale contenuto, Matrix; ma è proprio il suo carattere di contenitore a farne la realtà, e a fare di Matrix l’illusione. Matrix accade nella realtà, mentre la realtà non accade in Matrix.
Realtà virtuale
Questa asimmetria mi serve a introdurre l’ultimo tema di cui volevo parlare. L’idea centrale di Matrix è un’elaborazione dell’idea di realtà virtuale. Come sapete, gli sviluppi della computer graphics, resi familiari da molti film di cui il più noto è forse Jurassic Park (S.Spielberg, 1993), hanno consentito di simulare con grande verisimiglianza immagini tridimensionali che l’occhio umano non riesce a distinguere da rappresentazioni fotografiche, cinematografiche o televisive. I dinosauri di Jurassic Park non sono robot fotografati, ma “disegni” animati, realizzati dal computer e integrati con le “vere” immagini (= rappresentazioni) degli attori umani. Fin qui, non parliamo ancora di realtà virtuale ma soltanto di simulazione grafica. Senonché, è possibile coordinare queste simulazioni a certe nostre attività percettive e motorie in modo da ottenere quegli effetti di immersione e integrazione che sono caratteristici del nostro rapporto col mondo reale. In primo luogo, è possibile far coincidere l’immagine simulata col campo visivo dell’utente, che a quel punto non vede più l’immagine in uno schermo e lo schermo come oggetto tra altri oggetti del mondo reale, ma vede soltanto l’immagine simulata dal computer: si ottiene così un primo effetto di immersione (il mondo reale, infatti, ci appare anzitutto come il contenuto del nostro campo visivo: il mondo è ciò che di volta in volta vediamo). In secondo luogo, è possibile far determinare le proprietà dinamiche delle immagini dai movimenti dell’utente. La simulazione può essere completata con proprietà tattili, acustiche, olfattive ecc. Diventa così possibile, ad esempio, spostare un oggetto toccandolo (in realtà, modificare l’immagine muovendo una mano, i cui movimenti sono comunicati al computer attraverso un “guanto”). Si ottiene, in altre parole, una simulazione completa di un frammento di realtà: per esempio una stanza ammobiliata, o una strada percorsa da vari veicoli. Ed è questo che si intende per ‘realtà virtuale’. In Matrix, si immagina che la simulazione possa essere non solo globale anziché frammentaria, ma anche collettiva: una stessa simulazione è contemporaneamente fruita da molti utenti, che interagiscono con la simulazione e quindi, indirettamente, anche tra di loro – così come, nel mondo reale, se io taglio in due una mela la mela è tagliata in due anche per te, e puoi prenderne metà e mangiarla; e a quel punto la metà che tu hai mangiato non è più disponibile neanche per me (questo si intende quando si dice che la realtà è condivisa, o anche che è pubblica). L’idea di Matrix è quella di simulare la condivisione.
L’idea di realtà virtuale e i tentativi di realizzarla portano con sé interessanti riflessioni su che cos’è, per noi, abitare il mondo; o più precisamente, su quali stimoli devono esserci forniti, e in quali condizioni, affinché la nostra mente costruisca – ad esempio – l’immagine percettiva di una mela come immagine di una mela reale, e non di una simulazione di mela (o della fotografia di una mela). Quando guardiamo lo schermo del nostro computer, non prendiamo per realtà ciò che compare sullo schermo, per quanto perfetta sia la sua grafica tridimensionale, per quanto identica sia l’immagine visiva che formiamo a partire dalla mela sullo schermo all’immagine visiva che formiamo a partire da una vera mela; perché lo schermo occupa solo una parte del nostro campo visivo, e una parte relativamente piccola. La realtà è associata al contenitore; se anche lo schermo del computer non avesse un bordo, e al posto del computer noi vedessimo solo l’immagine — come in certi schermi molto raffinati che si vedono ultimamente – l’incoerenza dell’immagine con lo sfondo denuncerebbe il suo carattere di simulazione. Nel momento in cui l’immagine occupa invece l’intero campo visivo, il suo carattere di simulazione può evidenziarsi soltanto se è imperfetta — cioè se è incoerente coi nostri ricordi – oppure se non è integrata col nostro sistema motorio (tocco l’immagine della mela e la mela non si sposta, ad esempio). (Un ruolo è forse svolto anche dalla coerenza dell’immagine, dal fatto che obbedisca alle leggi di natura, ad esempio). Sembra dunque che le nostre attribuzioni di realtà — il fatto che trattiamo qualcosa come reale e non, invece, come una finzione, un’immagine, un’apparenza ecc. – abbiano a che fare con l’integrazione tra percezione e motricità, con un ruolo importante della memoria (dubitiamo che qualcosa sia una mela reale perché non assomiglia alle mele — s’intende alle mele che abbiamo visto e ricordiamo di aver visto). La forza degli hackers di Matrix sta nel fatto che essi conservano la memoria anche nel mondo virtuale, e perciò sanno di vivere in una realtà virtuale nel momento stesso in cui ci vivono — diversamente, si suppone, dagli altri esseri umani. Evidentemente Matrix — il programma – non è in grado di ricostruire ogni volta la memoria dei suoi fruitori. E’ un limite del programma, ma è ciò che consente al film di avere un plot: la memoria degli hackers è il loro legame con la realtà, è ciò che consente loro di portare con sé il contenitore mentre si muovono nel contenuto.



